di Carola Spadoni
La mostra No Master Territories, di cui a suo tempo avevamo dato notizia nella rubrica Altri luoghi, altri eventi, si è chiusa a Berlino il 28 agosto 2022. Anche se dopo la chiusura, riteniamo importante pubblicare questo interessante servizio e la preziosa intervista con le curatrici.
(La redazione del sito)
La Haus der Kulturen der Welt di Berlino ha ospitato fino al 28 agosto «No Master Territories», uno sfavillante giardino di immagini in movimento che proiettano infinite essenze di donne e del femminile. Guardando la mostra da qualsiasi angolo si ha la sensazione di essere in un caleidoscopio. Territori senza padrone. Un auspicio da estendere ovunque e per chiunque, preso in prestito dalla filmmaker e teorica vietnamita Trinh T. Min Ha. Sa di utopia delle pratiche e delle lucide follie di decenni in cui si disfaceva e rifaceva il mondo in collettività e nel segno internazionale della solidarietà. Come sottolinea Min Ha nel suo libro When the Moon Waxes Red, «Lei che sa di non poter parlare degli altri se non parla di sé stessa, lei che sa di non potersi occupare della Storia senza occuparsi della sua storia, sa anche che non può fare un gesto senza attivare quel movimento da e per la vita». L’altra inappropriata (the «Inappropriate Other») che rifiuta il pensiero binario, le dicotomie e attraversa le soglie di ciò che è concesso e non. Proprio come l’immagine principale della mostra, un fotogramma del film Untitled 77-A di Han Ok-he del 1977 in cui la filmmaker coreana taglia pezzi di pellicola con le forbici in un crescendo performativo nel quale delle immagini si accostano continuamente alle precedenti nel creare nuovi mondi. Ci son voluti due anni e mezzo di ricerca delle curatrici Erika Balsom e Hila Peleg insieme ad un team internazionale, degno di un film festival blockbuster, per scandagliare, raccogliere e selezionare, da mezzo mondo, film non fiction fatti da donne. L’importanza di questa mostra per la storia del femminismo e dei media è evidente tanto quanto per la storia del cinema indipendente; storicizza un periodo in cui i mezzi e le modalità distributive e di circolazione dei film si moltiplicarono oltre le sale e i cineclub inondando contro culture, soggiorni, cortili e centri di attivismo e militanza. Anni in cui i mezzi di produzione si alleggeriscono e le possibilità di filmare la quotidianità e le forme di opposizione e resistenza della miriade di movimenti diventano alla portata di molte. Sono anni in cui il personale diventa politico, in cui l’imprevisto, dai più conformisti, soggetto storico femminile irrompe ovunque, in fabbrica e quartiere, cucina e camera da letto. La potenza che sposta, a volte scardina, i padroni fuori dai territori per mettersi di nuovo al mondo, crea inedite alleanze e linguaggi, la resistenza e il rifiuto dello status quo travolge forme e contenuti. Sia la mostra che il catalogo sono concepiti nel rendere evidente l’importanza di questi lavori e di queste geneaologie per i nostri giorni. Le curatrici dichiarano di aver voluto delineare vari percorsi nella produzione delle immagini in movimento per mettere al centro una critica alla separazione in generi cinematografici della non fiction. Nella categoria non fiction troviamo inclusi il cinema sperimentale, quello educativo, il documentario, la videoarte, i cinegiornali, film prodotti per la televisione come il caso di Processo per stupro del 1979, presente in mostra.
La maggior parte delle filmmakers e artiste in mostra esercitavano altre attività e a volte erano meglio conosciute come editrici, giornaliste, insegnanti, antropologhe, coreografe. Le indicazioni sulle storie ed attività delle filmmakers si possono seguire nella documentazione sul retro delle postazioni di ogni film o video esibito. Attraverso le documentazioni capiamo come spesso i rapporti di lavoro, collaborazione e amicizia creavano reciproche influenze artistiche che generavano nuove produzioni ed alleanze nel segno della solidarietà. All’entrata della mostra il banner di Cauleen Smith Comfort the Afflicted del 2018 ne dichiara le intenzioni: «affliggere i privilegiati, confortare gli afflitti». Le curatrici sono esplicite nel rendere evidente il lavoro femminista sulla memoria e sulle geneaologie come nel caso della rinomata scrittrice Alice Walker che in seguito alla ricerca della tomba di Zora Neale Hurston in Florida, al tempo abbandonata e senza nome, pubblica un articolo nella leggendaria rivista Ms. nel 1975 che genera un rinnovato interesse per la scrittura della antropologa, filmmaker e scrittrice afroamericana. Neale Hurston a seguito di studi etnografici gira dei film del suo lavoro sul campo, field works, di cui un girato in 16 mm nel 1928 in Florida è in mostra. Pour mémoire girato al funerale di Simone de Beauvoir del 1987 da Delphine Seyrig, cineasta, attrice e anche una delle fondatrici del Centre Simone de Beauvoir, è un omaggio doppio a tutte le presenze accorse a salutare la grande scrittrice, attraverso loro la celebriamo e la ricordiamo.
Il cinegiornale Congrès international des femmes à Moscou, girato da Esfir Shub, che lavorava soprattutto come montatrice e che produsse nel 1946 per l’Incontro internazionale delle donne per la pace e contro il fascismo a Mosca, racconta la grande partecipazione delle delegate. Il congresso fu ospitato quell’anno a Mosca perché critico sull’invasione coloniale in Algeria, quindi ostacolato in Francia. Si riflette sulla rappresentazione del cinema stesso nei lavori di Sara Gómez e Barbara Hammer, vediamo gli effetti che i film hanno sul loro pubblico. Il primo, Mi aporte, girato dalla cineasta afrocubana per l’anniversario dei dieci anni della rivoluzione e completato nel 1972, su commissione della Federación de Mujeres Cubanas responsabile per l’avanzamento delle donne nel processo rivoluzionario, viene poi censurato e tolto dalla circolazione. Riemerso di recente e restaurato, mostra le discrepanze tra l’atteso cambiamento per i diritti delle donne e la realtà contingente, incluso un dibattito del pubblico in maggioranza femminile che ne discute la rappresentazione e rende espliciti i problemi di disuguaglianza. Nel film della Hammer, Audience del 1983, vediamo interviste al pubblico prima e dopo tre proiezioni della stessa regista. I contesti sono quelli del cinema lesbico militante femminista in cui si dibatte di desiderio tra donne, rappresentazione di sesso esplicito, e dell’idea di proiezioni solo per donne. Un altro itinerario della mostra è dato con l’esplicita critica ai media e alla rappresentazione dominante del femminile. Molti film e video, spesso con tagliente ironia e umorismo, spostano la tipica descrizione della donna da oggetto a soggetto che incarna visioni non conformiste. We aim to Please di Margot Nash e Robin Laurie del 1976 è un divertente assalto agli stereotipi femminili del trucco, della giusta posa, del canone commerciale di bellezza. Paper Tiger TV, uno storico gruppo di media busters newyorkesi, nel video del 1993 Sisterhood TM fa già il verso al femminismo neoliberal delle donne-in-carriera-a-qualsiasi-costo usando lo schema visivo della pubblicità. Prowling by Night in 16mm del 1990, è un’ilare animazione sulla prostituzione e le sue disavventure a Toronto; gli incontri con il poliziotto di quartiere che regolarmente esige prestazioni gratuite, gli appuntamenti dal ginecologo, la clientela regolare e quella del fine settimana. Il film è composto con disegni realizzati dalle prostitute stesse e l’audio dei loro discorsi. Uno dei temi principali, la legalizzazione della prostituzione. Nella documentazione sul retro della postazione la fanzine Stiletto riporta articoli sul film, accenni all’autrice il cui nome è Gwendolyn, al gruppo di ricerca femminista Studio D sostenuto da fondi del governo canadese, le date di proiezione in un circuito di cooperative sociali e centri di comunità sociale.
Lungo una parete sono in mostra la serie di foto di Sheba Chhachhi, Seven Lives and a Dream del 1980-81, in cui la fotografa ritrae momenti topici della vita quotidiana femminile a New Delhi ricreando insieme a delle attiviste femministe un ‘teatro di sé stesse’ come soggetto e presenza critica. I tanti percorsi continuano con il primo film di Tracy Moffat Nice Coloured Girls del 1987, con ritratti e autoritratti disseminati in tutta la mostra, Christiane Diop e Assia Djebar del 1985-87 di Sarah Maldoror, Soft Fiction di Chick Strand del 1979, Paola di Rony Daopoulo e Annabella Miscuglio, girati in Super 8 tra il 1973 e il ’76, Essere donne di Cecilia Mangini del 1965. Il femminismo italiano degli anni ’70 è presente e ben raccontato nel catalogo dall’affilata penna della storica dell’arte e femminista Giovanna Zapperi. In apertura del catalogo che funge non solo da compendio ma espande il progetto espositivo, un verso di Adrienne Rich ne restituisce la complessità, «We who are not the same. We who are many and do not want to be the same» (Noi che non siamo le stesse, noi che siamo molteplici e non vogliamo essere le stesse).
Intervista alle curatrici
Abbiamo chiesto a Erika Balsom e Hila Peleg, curatrici della mostra «No Master Territories», qualcosa di più sulla coralità dell’evento anche in rapporto alle politiche identitarie contemporanee.
«La mostra – ci dice Erika Balson – nasce dall’esigenza di rivedere la mancata storicizzazione di tante esperienze avvenute nell’ambito femminista delle immagini in movimento e di donne artiste e filmmaker che hanno operato fuori dai canoni precostituiti. Con gli occhi di oggi tornare alle generazioni delle madri e delle nonne per raccogliere le origini e segnare genealogie dei temi scottanti. Nasce anche dall’idea di un femminismo che rifiuta la dominazione in tutte le sue forme, che si occupa non solo di genere ma dei diritti dell’ambiente, della difesa delle risorse naturali, dei diritti sociali civili, delle oppressioni coloniali e dello sfruttamento delle risorse umane. L’idea era fin dall’inizio di realizzare la mostra con una metodologia che rispecchiasse queste intenzioni. Non c’è quindi una narrazione lineare e dominante che rispecchia il pensiero di noi curatrici ma vari percorsi che il pubblico può scegliere a seconda dei propri interessi specifici. C’è anche un programma di film da vedere nell’auditorium e una biblioteca in cui sono raccolti i libri da cui abbiamo scelto alcuni dei testi pubblicati in catalogo. Un’ispirazione per mantenere le coordinate di un’idea centrifuga della storia e della cronologia e tradurla in un pensiero espositivo è stato il testo di Lis Rhodes Whose History? (La Storia di chi?) del 1979. Un’altra chiave da cui abbiamo voluto prendere le distanze è l’idea dell’autore/autrice che abbia uno stile riconoscibile, che abbia prodotto un consistente numero di film per essere riconosciuta tale, e che lavori a tempo pieno come regista. Questo non è il caso per la maggior parte delle filmmakers e artiste incluse in questa mostra che spesso avevano altri lavori ed erano conosciute per altri ruoli professionali.
A questo proposito avete menzionato nella presentazione le filmmakers della Germania dell’Est che potevano lavorare anche nella non fiction con formati come il 35 mm, l’accessibilità ai mezzi e le loro condizioni di produzione erano spesso migliori che in molti paesi dell’occidente.
Erika Balsom: Nel mondo socialista la dichiarazione di uguaglianza tra i sessi era ufficiale, faceva parte dei programmi di partito e di stato, di conseguenza le esperienze femministe sono state molto diverse rispetto all’ovest. Abbiamo scelto film dalla Germania dell’est, dalla Polonia, da Cuba, una deliziosa animazione russa sulla giornata internazionale della donna, l’8 marzo. Questo è un ulteriore percorso all’interno della mostra.
Come considerate il supporto teorico ed espositivo del mondo accademico quando si occupa del femminismo intersezionale e di temi come la decolonizzazione e la restituzione pur mantenendo modalità a senso unico, non dialogiche e sostanzialmente gerarchiche?
Erika Balsom: Io vengo dall’accademia, quindi mi è molto familiare il tuo discorso. Molte di noi hanno sofferto nelle maglie iperproduttive dell’accademia di questi ultimi anni dove la pressione per una professionalità performativa è costante. Pubblicare con regolarità, congegnare corsi che siano di successo, che abbiano un alto numero di iscritti, presenza sui social media, fare costante promozione di se stesse, e competere per risorse sempre più scarse. Tutte dinamiche tipiche del mondo neoliberale. Di fatto nella mostra un filone centrale è quello della critica al femminismo neoliberale che sembra esserne diventata la forma dominante negli ultimi anni, in cui il successo individuale e l’affermazione professionale a tutti i costi sovrastano qualsiasi altra forma e possibilità di emergere. Un femminismo che si realizza per poche privilegiate alle spese della maggioranza. A ricordare che la solidarietà è qui protagonista e ha un peso diverso dalla sorellanza (sisterhood), abbiamo voluto ad accogliere il pubblico il banner di Cauleen Smith. Bisogna lavorare, lottare e creare le circostanze perché la solidarietà esista e renderla salda con il mutuo rispetto delle differenze, mentre la differenza con la sorellanza è che quest’ultima è di solito un concetto e un modo di porsi tra donne quasi in automatico, senza troppe questioni. Le collaborazioni che abbiamo messo in atto per la mostra vengono da queste esigenze così come l’accessibilità del nostro testo che volevamo fosse fruibile da tutte e tutti, non solo da addetti ai lavori o a studiose.
Hila Peleg: Abbiamo saputo oggi dalla responsabile del dipartimento d’educazione del museo che c’è un grande interesse a visitare la mostra da parte di studenti e insegnanti, le richieste arrivano non solo dalle università, anche da classi delle superiori e ne siamo molto contente. L’opuscolo gratuito ad esempio è ricco anche di testi e informazioni approfondite in un linguaggio accessibile a chiunque.
Un altro approccio importante che si evince dai lavori in mostra è la volontà di esporre lo sguardo sullo stigma della donna difficile, sulla filmmaker in opposizione, considerata tale da e in un sistema prettamente patriarcale e oppressivo che viene spesso reiterato anche da figure intellettuali interessanti e in contesti illuminati. Come esporre e rivoltare gli effetti di questo sguardo?
Erika Balsom: Sappiamo bene in tante cosa significa quello che hai appena descritto, non si può certo essere sempre gentili e disponibili in circostanze oppressive o di sfruttamento. Va sempre appurato e considerato da chi è giudicata difficile una donna, e in quali circostanze lavorative e produttive. Un esempio di come abbiamo introdotto questo tema è Processo per stupro, un lavoro fondamentale e quasi insostenibile che abbiamo fortemente voluto. Sì, mi ricordo di averne visto delle parti in tv da piccola e fu tanto importante quanto impressionante realizzare il livello di discriminazione istituzionale verso le donne.
Immagino.
Erika Balsom: Invece di arroccarci in un sentimento vittimista della donna difficile che compiange sé stessa, abbiamo scelto lavori che creano nuovi sguardi e nuovi mondi, in collettività e con ogni mezzo possibile. Video e film prodotti a volte contro ogni previsione.
(il manifesto, 16 luglio 2022)
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, insieme al figlio di Carla Lonzi, Battista Lena (che ci ha generosamente dato in comodato il suo prezioso archivio) e alla responsabile dell’Archivio Carla Lonzi presso la Galleria Nazionale, Annarosa Buttarelli, ricorda i 40 anni dalla scomparsa di Carla Lonzi con le sue stesse parole:
Noi viviamo questo momento e questo momento è eccezionale.
Il futuro ci importa che sia imprevisto piuttosto che sia eccezionale.
La presenza dell’Archivio Carla Lonzi, dal 2018, ha ampliato le possibilità di un orientamento di impegno e di pensiero già intrapreso dalla Galleria Nazionale dal 2015 – sotto la direzione di Cristiana Collu – con numerose azioni messe in campo nel segno di una valorizzazione della presenza femminile nell’arte e nelle diverse pratiche culturali. Una grande indagine sul femminismo e sul suo significato nel nostro tempo è stata condotta nell’arco di 7 anni – ma sempre in fieri – attraverso mostre, progetti, festival, open call, eventi e acquisizioni.
I preziosi materiali dell’Archivio – dal 2020 completamente digitalizzati e consultabili – riconosciuti a livello internazionale per la loro importanza nel campo della storia dell’arte e degli studi di genere, hanno permesso alla Galleria Nazionale di condurre un lavoro per promuovere e trasmettere lo studio e la ricerca sul patrimonio di Carla Lonzi. Non solo, considerando i tanti progetti che questo Archivio non ha mai smesso di attivare, continua ad agire sul presente come fonte di ispirazione, generando nuova conoscenza e rivolgendosi con domande aperte alle generazioni future, nella conferma della sua piena vitalità.
Queste le tappe principali:
L’Archivio Carla Lonzi
L’ordinamento e l’inventariazione dell’Archivio Carla Lonzi presso la Galleria Nazionale ha preso avvio nel gennaio 2018. È la prima volta che si tenta l’operazione complessa di raccogliere, ordinare, custodire, digitalizzare e mettere a disposizione l’eredità documentaria di Carla Lonzi.
Women Out of Joint
All’inizio degli anni Settanta, Carla Lonzi ha definito il femminismo «la mia festa». Nel 2018 la Galleria Nazionale ha reso omaggio alla sua figura con un festival di tre giorni e un programma di incontri, laboratori, performance, proiezioni e letture che ha messo in relazione le esperienze di artiste, storiche, scrittrici, attiviste, ricercatrici e architette provenienti da una scena internazionale.
Le open call
La open call Dopo Hegel su cosa sputiamo? (2018), direttamente ispirata al pensiero lonziano e focalizzata sulla produzione di un testo in qualunque lingua e di qualunque genere, è stata seguita da quella internazionale per la realizzazione di video-autoritratti dal titolo Taci. Anzi, parla (2020).
Io dico Io – I say I
La centralità dello sguardo delle donne è il cardine della mostra Io dico Io – I say I, inaugurata a marzo 2021 a cura di Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola Ugolini. Cinquanta artiste italiane di generazioni diverse che in differenti contesti storici e sociali hanno raccontato la propria avventura dell’autenticità̀. Una sezione della mostra è stata inoltre dedicata all’esposizione di materiali provenienti dall’Archivio Carla Lonzi.
Self-portrait (Autoritratto)
Nel 2022 la Galleria Nazionale si è fatta promotrice della prima traduzione in inglese di Autoritratto (Self-portrait) di Carla Lonzi a cura di Allison Grimadi Donahue per Divided Publishing, presentata poi dal museo con un evento online.
Le donne e l’indagine sul femminismo sono sempre al centro delle attività della Galleria Nazionale. Tutte le tappe dal 2015 a oggi tra mostre, progetti, festival, eventi, call, digitalizzazioni e acquisizioni sono raccontate sul blog del museo nella pagina di Women Up.
(https://lagallerianazionale.com/, 2 agosto 2022)
di Elena Tebano
La scoperta di Vivian Maier è una delle vicende più straordinarie della recente storia della fotografia. Nel 2007 il contenuto di un deposito in cui l’allora sconosciuta Vivian Maier conservava parte delle sue stampe e dei suoi rullini andò all’asta, suddiviso in diversi lotti. Uno dei compratori, John Maloof, un giovane che aveva lasciato la scuola d’arte per problemi di soldi e si era dedicato a lavori diversi, tra cui l’agente immobiliare, capì presto il valore artistico delle fotografie di Maier. E si organizzò con un altro degli acquirenti, Jeffrey Goldstein, per raccogliere tutto il suo archivio – 143mila immagini, di cui Maier aveva stampato solo il 5% – e poi organizzare una mostra in collaborazione con il Chicago Cultural Center. Allestita nel 2011, fu subito un successo e proiettò Maier, bambinaia di professione e fotografa solo per passione, nell’olimpo della fotografia. Da allora le sue mostre hanno fatto il giro del mondo; l’ultima, dedicata agli scatti “italiani” di Maier si è conclusa alla fine di giugno a Torino (qui la recensione sul Manifesto). Maier era morta a ottantanove anni solo due anni prima, senza mai sapere di essere stata “scoperta”. I suoi primi curatori l’hanno rintracciata solo dopo la sua morte, grazie al necrologio pubblicato su internet: lei aveva vissuto sempre nel più totale riserbo.
Il suo successo postumo è dovuto in parti uguali alla bellezza delle sue foto e al mistero che la circonda. Perché una fotografa così talentuosa non solo non ne ha mai fatto un lavoro a tempo pieno, ma ha letteralmente lasciato la maggior parte dei suoi rullini chiusi in un deposito, spesso senza neanche svilupparli?
La risposta a queste domande si può ora trovare in Vita di Vivian Maier. La storia sconosciuta di una donna libera, l’imponente biografia della Maier appena edita in Italia da Utet. È nata anch’essa dalla curiosità nei confronti di questa donna misteriosa: la sua autrice, Ann Marks, non è una biografa di professione, né una studiosa di fotografia, ma un’ex dirigente d’azienda in pensione che si è appassionata alla storia di Maier dopo aver visto un documentario e ha deciso di indagare più in fondo. Il limite del libro sta forse qui, ma è comunque una straordinaria fonte di informazioni e una preziosa raccolta di oltre 400 foto, molte delle quali sconosciute, di Vivian Maier.
Marks ricostruisce la storia familiare di Maier, segnata da uomini inaffidabili e violenti e donne che – in tempi in cui le donne avevano pochissime possibilità – hanno dovuto cavarsela da sole, spesso lasciando indietro le loro figlie, che ne hanno pagato il prezzo. È successo alla nonna materna di Maier, Eugénie Jaussaud, originaria di Saint-Julien-en-Champsaur, un villaggio delle Alte Alpi francesi nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Figlia di contadini, rimase incinta a sedici anni del bracciante che lavorava nella fattoria dei genitori e che si rifiutò di sposarla. Sua figlia Marie, la madre di Vivian, nacque dunque nel 1897 fuori dal matrimonio e lei e Eugenie ne patirono lo stigma che ne derivava all’epoca. Quattro anni dopo, Eugenie partì da sola per l’America, dove nessuno sapeva della sua figlia illegittima, e iniziò a lavorare come cuoca per le famiglie ricche dell’East Coast. Marie fu tirata su dalla nonna e raggiunse sua madre, che praticamente non conosceva, solo quando aveva diciassette anni, nel 1914. Sembra una storia lontanissima, eppure è quello che succede ancora oggi ai figli e alle figlie di tante tate, colf e badanti ucraine, sudamericane o filippine che lavorano nelle case italiane.
Pochi anni dopo, nel 1919, Marie, cattolica, sposò il luterano Charles Maier, in un matrimonio traballante fin dall’inizio, se è vero che i testimoni furono la moglie del pastore che lo officiò e il custode della chiesa. L’anno dopo nacque il loro primo figlio, Carl, e poi, nonostante la coppia si lasciasse e riprendesse continuamente, Vivian, nel 1926. Charles era dipendente dall’alcol e dal gioco, la madre sofferente e incapace di tenersi un lavoro, e nel 1927 si lasciarono definitivamente. Carl fu messo in orfanotrofio, Vivian rimase con la madre che però la lasciava spesso sola o in qualche casa-famiglia, fino a quando dopo l’inizio della grande Depressione si trasferì a casa di Jeanne Bertrand, fotografa francese amica della nonna dall’inizio della sua immigrazione americana. Fu lei probabilmente ad avvicinare Vivian alla fotografia. Dopo un periodo in Francia con la madre, tra il 1932 e il 1939, Vivian tornò a New York e iniziò a lavorare a 17 anni in una fabbrica di bambole. Poi, dopo un altro breve viaggio in Francia per vendere un terreno ricevuto in eredità alla morte della nonna, iniziò a lavorare come bambinaia. Lo avrebbe fatto per tutta la vita.
La sua passione per la fotografia era iniziata in Francia, con la macchina fotografica di sua mamma, l’unica in tutto il villaggio. Vivian la coltivò per anni, soprattutto a New York, dove negli anni 50 frequentava fotografi e artisti, tra cui Jeanne Bertrand. Marks racconta che però non riuscì mai a farne un lavoro, forse perché donna, autodidatta ed estranea agli ambienti della fotografia professionale. Sicuramente anche la sua storia familiare ebbe un peso. Sua madre fin dal 1939 iniziò a mostrare gravi disturbi mentali e morì in solitudine. Il fratello Carl fece dentro e fuori dal riformatorio, da ragazzo, e poi dal carcere, da adulto. Ebbe problemi di dipendenza dall’alcol e dalla droga e alla fine gli fu diagnosticata una forma di schizofrenia. Morì in una struttura di ricovero dopo aver passato lunghi periodi in psichiatria.
Vivian dopo essersi trasferita a Chicago condusse una vita sempre più solitaria. Sviluppò un disturbo da accumulo, collezionando soprattutto libri e giornali, tanto da rendere praticamente inabitabile camera sua e da dover affittare i depositi che alla fine finirono all’asta. Il fatto che non abbia mai stampato né mostrato la maggior parte delle sue fotografie potrebbe avere a che fare con questa difficoltà di lasciare andare che affligge molti accumulatori. Ma all’epoca non esisteva né diagnosi né cura per il suo disturbo, che finì per causarle problemi anche con i suoi datori di lavoro. Marks è convinta che Maier possa aver subito anche violenze o abusi sessuali: provava «orrore» per gli uomini, non sopportava il contatto fisico, aveva «reazioni brusche che facevano pensare a improvvisi flashback traumatici», «raccomandava alle bambine di non sedersi in braccio agli uomini e descriveva loro tutti i reati violenti o a sfondo sessuale di cui un uomo si poteva macchiare». È impossibile da sapere con certezza, ma è tutt’altro che improbabile. In ogni caso i bambini che ha cresciuto facendo la tata la raccontano come una donna eccentrica ma capace d’amore.
In mezzo a tutte queste difficoltà, Vivian Maier ha saputo anche trovare e coltivare la sua immensa creatività. Tra i suoi soggetti preferiti ci sono i bambini, forse un modo per sanare attraverso l’arte la sua infanzia piena di abbandoni. E poi le donne della classe lavoratrice in mezzo alle quali ha vissuto. Ha nutrito da sola il suo talento superando gli ostacoli della povertà, di una mancanza di istruzione formale, dei pregiudizi di genere in un’epoca in cui per una donna anche muoversi da sola senza meta per la città era malvisto e pericoloso. Nonostante tutte le ferite che la vita può averle inferto ha saputo costruire bellezza. L’arte è questo. E lo è anche se nessuno la vede, come è successo a lungo con le sue fotografie.
(27esimaora.corriere.it, 9 luglio 2022)
di Mariella Pasinati
All’età di 87 anni è scomparsa lo scorso 8 giugno Paula Rego (Lisbona 1935 – Londra 2022) artista portoghese ma attiva fin dagli anni ’50 del Novecento in Gran Bretagna.
Grande narratrice di storie visive che molto spesso interpretano e risignificano narrazioni letterarie e opere visive del passato, Rego ha fatto dell’esperienza femminile il punto di osservazione privilegiato da cui guardare il mondo e secondo cui dar valore alla realtà, un orientamento intrecciato a temi quali la violenza, il rapporto di subordinazione/dominio, l’esercizio del potere – sessuale e sociale – in particolare nel mondo dell’infanzia e della famiglia. Le sue storie, inquietanti e che lasciano spiazzate, espongono e svelano le difficoltà delle relazioni umane presentate come luogo di contrapposizioni e di conflitto.
Per ricordarla oggi voglio citare solo la sua serie di disegni e acqueforti sull’aborto che inaugurava, nel 1999, un tema iconografico del tutto nuovo in una storia dell’arte sostanzialmente frutto dell’esperienza e dell’immaginario maschile (per una lettura più ampia del lavoro di Paula Rego rimando ad un mio saggio su Letterate Magazine https://www.societadelleletterate.it/2013/05/pasinati/).
La serie sull’aborto nacque da una costrizione: la necessità di prendere la parola dopo l’insuccesso del referendum indetto in Portogallo per cambiare una legge sull’aborto estremamente restrittiva. Ma quell’urgenza politica le consentì di nominare e dare esistenza simbolica a un’esperienza destinata altrimenti a rimanere muta, come la stessa artista ha lasciato intendere, omettendo, in questi lavori, i titoli.
Il risultato sono opere forti, intense, dure che però non hanno nulla di crudo o di brutale, suggeriscono più che descrivere. In contesti estremamente semplificati, l’attenzione è tutta concentrata sulle figure: corpi massicci che assorbono e dominano lo spazio, donne che, sia pure nella sofferenza, sono l’unico soggetto dell’azione. L’intento non è tanto denunciare un problema sociale, piuttosto sottolineare il controllo femminile sulle proprie scelte, anche in una condizione estrema. Per questo Paula Rego rappresenta le figure secondo due pose diverse ma complementari: rannicchiate su se stesse oppure rivolte verso chi guarda ma, in entrambi i casi, la donna raffigurata ha sempre il pieno controllo sull’evento, sempre protagonista e mai vittima delle circostanze.
Quest’anno la Biennale di Venezia le ha dedicato uno spazio nel Padiglione centrale, un’ottima occasione per rivederne le opere, fino alla serie più recente Seven Deadly Sins del 2019. E fino al 18 giugno sempre a Venezia, alla Galleria Victoria Miro, si può ancora visitare la mostra Paula Rego: Secrets of Faith, centrata sulla sua particolare interpretazione femminista della figura della Vergine Maria.
(www.facebook.com, 13 giugno 2022)
di Katia Ricci
Ho visitato l’Esposizione ai Giardini e all’Arsenale con Donatella Franchi e un’artista messicana, Patricia Meza, sua allieva nel master Duoda. È stata per questo una visita ancora più interessante perché abbiamo potuto scambiarci opinioni. Ero piena di aspettative per quella che veniva indicata come la Biennale delle donne. Desiderosa di un giusto, anche se tardivo, riconoscimento alla creatività femminile e nello stesso tempo timorosa che fosse un tributo alla moda del momento che parla di post-umano, gender fluid, superamento del binarismo eccetera… Sicuramente in comune con tutte queste problematiche le opere di artiste e artisti mostravano un netto superamento dell’antropo(andro)centrismo. Ma andiamo con ordine, in primis i numeri: per la prima volta nei 127 anni della Biennale tra i duecento artiste e artisti provenienti da 58 nazioni, c’è una netta maggioranza di donne rispetto ai colleghi uomini, il che racconta di un protagonismo femminile che finalmente è emerso anche agli occhi della critica e del pubblico e di qui non si torna indietro. I numeri dicono pure qualcosa, anche se si dice comunemente che non è la quantità quella che conta. E allora entriamo nel merito della qualità e dei problemi affrontati. L’enorme elefante verde scuro, Elefant, che ci accoglie nel Padiglione centrale dei Giardini, realizzato in poliestere da Katharina Fritsch mi appare come una figura imponente e nello stesso tempo rassicurante, come la matriarca che è alla base dell’organizzazione familiare della specie. La scultura e il titolo della mostra, Il latte dei sogni, tratto dal libro di favole di Leonora Carrington, introducono in un mondo magico e nello stesso tempo reale e quotidiano, come se la vita stessa offrisse infinite possibilità di eventi meravigliosi e potesse essere plasmata e reinventata continuamente se si abbandonano schemi prefissati e luoghi comuni. In una sala sotterranea del Padiglione centrale, detta La culla della strega, esprimono un rapporto magico e stupefacente con l’universo le opere di artiste delle avanguardie storiche, tra cui Eileen Agar, Leonora Carrington, Claude Cahun, Leonor Fini, Carol Rama, Dorothea Tanning, Remedios Varo, Benedetta, Rosa Rosà, Meret Oppenheim, Valentine de Saint-Point. Il riferimento frequente all’inconscio, il superamento delle contrapposizioni proprie della cultura patriarcale, essere umano natura, corpo mente, femminile maschile, reale immaginario prefigurano la nascita della “donna nuova”, autonoma e indipendente dall’uomo. Breve il passo per il raggiungimento di una completa libertà. Un’opera di Varo mostra un’artista, un ibrido di donna e civetta, che nel suo fare artistico prende direttamente luce e colori dagli astri, da forze soprannaturali. La culla della strega si presenta, dunque, come un laboratorio alchemico di pensiero, consapevolezza, pratiche artistiche a cui faranno riferimento artiste e artisti negli anni a venire e fino ai nostri giorni. La sezione Corpo orbita con opere di artiste come Tomaso Binga, Mirella Bentivoglio, Djuna Barnes, Sister Gertrude Morgan, Minnie Evans, solo per citarne alcune, ricercano un proprio linguaggio nella Poesia visiva o utilizzando scritture automatiche che sono anche una pratica corporea per esprimere un linguaggio inconscio del tutto personale. Affascinanti l’installazione e le opere di Cecilia Vicuña, Leon d’oro alla carriera insieme a Katharina Fritsch. L’installazione, NAUfraga, dedicata alla laguna di Venezia, che occupa tutta la stanza con materiali di recupero, corde, reti, detriti raccolti a Venezia, denuncia lo sfruttamento della Terra che sta facendo naufragare lentamente Venezia. Il dipinto dedicato alla madre, Bendígame mamita, esalta il modo creativo e forte con cui la madre ha reagito al violento colpo di stato cileno: il suo sguardo attraversa il foro di una chitarra e non a caso è diventato uno dei simboli della Biennale per comunicare il superamento dell’odio e delle difficoltà. Metamorfosi dei corpi in lavori come quelli dell’artista rumena Andra Ursuƫa, che, usando calchi di parti del suo stesso corpo, evoca la fragilità e la precarietà della forma umana. Molte artiste e artisti affrontano il tema del rapporto con la Terra e la natura, sia nei video di alcuni che negli stupendi paesaggi ricamati da Britta Marakatt-Labba presente anche all’Arsenale. Uno dei riferimenti della curatrice è sicuramente Ursula K. Le Guin, secondo la quale la civiltà sarebbe nata non dall’invenzione delle armi, ma dai recipienti e oggetti utili alla vita quotidiana. E così in una sezione dell’Arsenale si ammirano oggetti di Sophie Taeuber-Arp, le leggerissime sculture in filo di ferro ispirate a una tecnica di intreccio di ceste di Ruth Asawa, i gusci fragili di Mária Bartuszová, i modelli in cartapesta degli organi sessuali femminili di Aletta Jacobs che nei Paesi Bassi già a fine Ottocento si batteva per l’abolizione della prostituzione. Ai genitali femminili sono evidentemente ispirate le conchiglie dipinte dalla francese Bridget Tichenor, stabilitasi poi in Messico. Complessa la scultura in ceramica di Tecla Tofano, nata a Napoli, ma vissuta in Venezuela, dove si è battuta per l’uguaglianza tra uomini e donne in una società fortemente maschilista. La sua ceramica affronta la questione della maternità in un modo problematico senza retorica.
Culture non occidentali e saperi indigeni sono al centro di molte opere. Il Padiglione americano coperto per l’occasione da paglia che lo trasforma in una capanna africana contiene sculture in bronzo di figure di donne nere di Simone Leigh, che apre la mostra all’Arsenale con un monumentale busto di bronzo di una donna nera, la cui gonna ricorda una casa di argilla. All’antica scultura indiana si ispira Mrinalini Mukherjee che con la fibra di canapa dà vita a monumentali sculture, in cui l’astrazione si fonde con elementi naturali per dar vita ad antiche divinità. Uno dei padiglioni più affascinanti, oltre a quello molto bello del Belgio sui bambini che giocano nelle strade del Messico, in Africa e in Cina, e che mi ha sorpreso maggiormente è quello della Polonia che presenta un grandioso progetto dell’artista rom Małgorzata Mirga-Tas, Re-enchanting the World, ispirato a Palazzo Schifanoia. L’epopea del popolo Rom raccontata in tra fasce copre tutte le pareti con la storia della migrazione, i segni zodiacali, e nella fascia bassa lavori e vita quotidiana in cui sono protagoniste le donne. Sono dodici pannelli di tessuti dai colori brillanti, una festa per gli occhi. Arazzi, ricami, opere realizzate con materiali vari anche di uso quotidiano sono numerosi in tutta l’esposizione in cui non mancano sorprese come le opere della cantante cilena Violeta Parra che realizza quadri e ricami che riprendono le sue canzoni e rappresentano in scene corali donne, uomini e animali ed eventi storici. Inevitabile la sezione dedicata al cyborg intitolata La seduzione del cyborg nella parte finale delle Corderie all’Arsenale, con opere di artiste che fin dall’inizio del Novecento hanno immaginato nuove mescolanze e combinazioni tra macchine, esseri umani e tecnologia. Tra queste artiste del Bauhaus come Marianne Brandt, le futuriste, Aleksandra Ėkster, Giannina Censi e Regina. Chiude una grande installazione di Barbara Kruger con slogan, poesie e frasi. Non è, dunque, solo la quantità che fa di questa Biennale la Biennale delle donne, ma anche e soprattutto la qualità: le novità, le pratiche artigianali e artistiche, un tempo appannaggio delle donne, i contenuti che riguardano la rappresentazione dei corpi, le relazioni con tutti gli esseri viventi, la fine dell’antropocentrismo e i legami con la Terra per un «re-incantesimo del mondo», come scrive Silvia Federici.
(www.libreriadelledonne.it, 6 giugno 2022)
di Danila Baldo
Inizia oggi una serie di quattro interviste ad artiste accomunate dal fatto di essere donne, di aver rappresentato l’essere donne nel mondo e di aver fatto conoscere, con la loro arte – produzioni, attività, mostre – il loro sguardo sulla realtà. Che cosa sia la realtà è la più sottile e complessa delle disquisizioni filosofiche: se è ciò che si vede o ciò che è velato, ciò che appare alla luce del sole o ciò che è nell’ombra, ciò che è al di qua o al di là dello specchio… in ogni caso l’artista si pone in un luogo altro che fa cogliere sprazzi di realtà non visibili immediatamente, colti nella mediazione delle sue emozioni, sentimenti e visioni. E aiuta tutte e tutti noi, ri-creandola, a comprendere e ri-conoscere la realtà in cui siamo immersi, come pesci nell’acqua.
Iniziamo con l’artista emiliana Clelia Mori.
Ci parli della tua ultima fatica, la mostra che a Matera città della Cultura 2019 è stata intitolata Il mistero (negato) del corpo che non tace e che ha avuto altre esposizioni, prima del lockdown che ha bloccato tutto: società, scuola, rappresentazioni artistiche?
Bella questa idea della realtà ri-creata dall’arte: racconta molto della visione artistica. Sì, ha proprio bloccato tutto il Covid, anche per me dopo Matera. Comunque dopo averla esposta in parte a Mestre con Le Vicine di casa e Alessandra De Perini che mi ha creduta per prima, a Brescia con la Cgil, a Reggio Emilia con la Fondazione Tricolore e a Foggia alla Merlettaia, quest’opera è approdata, con la partecipazione preziosa della critica Katia Ricci, a Matera alla Biblioteca Provinciale, a cura della fondazione Basilicata Futuro e della Cgil e col Patrocinio della Provincia, dove volevo assolutamente andasse, visto che riguardava le donne della Basilicata. Mi serviva portarla là per unirle idealmente a tutte le donne d’Europa e della terra.
Questa serie di più di 40 opere tra tute, carte e lenzuola, sul mistero del corpo femminile, è nata perché mi sono sentita negata come donna insieme alle operaie della Fca di Melfi quando ho letto, nel 2015, che non volevano più le tute bianche di ordinanza, uguali a quelle degli uomini, perché si macchiavano di sangue mestruale. Mi era sembrato assurdo che il nostro corpo fosse considerato uguale a quello degli uomini. È un’uguaglianza ottusa che continua ancora oggi in tutte le fabbriche di questa multinazionale. Non capivo come fosse possibile non vedere che al mondo ci siamo anche noi e che ogni donna e uomo nasce sempre da un corpo di donna. Un corpo misterioso e anarchico che Marchionne pensava di poter cancellare col bianco, ma che non tace mai e il bianco mitizzato lo ha tradito. Ho pensato che dovevo far uscire quelle tute dalla fabbrica, renderle un’opera d’arte ed esporle. Far vedere questa violenza simbolica. Ho cercato un’operaia che me le regalasse e dopo più di un anno, al cambio della mise, gentilissima, me le ha mandate.
Confidavo mi arrivassero sporche, ne avevamo parlato. È un periodo che in arte va di moda il sangue e volevo usarlo anch’io, avevo perfino un motivo molto serio che mi toglieva dall’idea dell’esibizione. Ma le quattro tute usate, il ritratto di chi ci aveva vissuto dentro, mi arrivarono pulite e stirate e non potevo macchiarle apposta fingendo.
E allora?
Eh, lentamente mi sono resa conto che dovevo lavorare sui simboli: ricamarle e dipingerle io. Non aveva senso insistere sul sangue reale se le operaie avevano rifiutato le tute proprio per proteggere la loro libertà di dire a chi, quando e come volevano il loro mistero. Una libertà che rivendicavano per tutte noi. Anche la mia amica operaia me l’aveva detto mandandomele pulite. Non dovevo proprio scioccare nessuno col sangue vero. Ormai era puerile. Era il nostro mistero negato che doveva stare al centro del mio lavoro. La sua voluta in-visibilità.
E sulla nostra in-visibilità ho lavorato.
Alle maglie ho delegato l’invisibilità con fili bianchi e oro che mi serviva per indicare la nostra preziosità corporea e ai calzoni la visibilità con cerchi di filo rosso e macchie rosse di acrilico. Ma quando le ho esposte a Mestre chi le vedeva non si stupiva come me.
E allora ho capito che dovevo affrontare il nostro mistero togliendolo dal tabù in cui è relegato. Ho cercato una forma, ma nessuna funzionava e finalmente è arrivata liberatoria l’unica vera: la macchia di sangue mestruale sui pannolini. E quella ho ricamato enorme, con materici fili rossi, bianchi e oro, a punto croce, una tecnica persino ironica nella sua xx cromosomica, per sbatterci contro al tabù su grandi lenzuola usate, filate e tessute da altre donne su cui avevano anche amato. Chiudendo un cerchio tra donne sulla nostra preziosità.
Ma ricamavi già nelle tue opere?
No. Ma una volta scartato il sangue vero, concettualmente superato, non potevo certo usare pennellate forti e sgocciolanti. Troppo maschili, vistose e false per parlare del nostro Sangue di vita che è differente da quello di morte, ferita o malattia e va detto. Perché noi siamo le Creatrici del tempo e dello spazio ogni volta che creiamo una vita. Un tempo che non è quello dell’orologio e della storia maschile, ma quello della vita vera che parla, ride, piange e ama. Uno dei miei lavori è proprio sulla capacità creatrice della nostra differenza sessuale: Creatrici del tempo. Concetto spaziale 2020. È basato sulla mia storia fertile che racconto con tredici pallini: uno per ogni mestruazione, per ogni anno dall’inizio fino alla fine, con la riga vuota della gravidanza. È il tempo dell’umanità che io ho creato e che creiamo tutte dandogli spazio in ogni parte del mondo. Tredici è il numero di mestruazioni che ogni donna in genere dovrebbe avere in un anno e lo si trova dividendo i giorni dell’anno per 28, lo stacco di tempo anche lunare tra una apparizione mestruale e l’altra.
Così mi è sembrata molto naturale e meditativa la levità del ricamare, senza fare una tovaglia da tè, rispetto alle pennellate energiche. In fondo erano le coordinate artistiche di sempre quelle che usavo: spazio, segno, materia, luce, cambiava solo la tecnica. Non ho il mito artistico della riconoscibilità personale della critica e del mercato. L’arte è un linguaggio, mi serve per parlare e per farlo da libera credo vadano anche ribaltate le richieste dei canoni, anche se rassicurano, se serve per ri-creare la realtà osservata da un’altra prospettiva. Per me è l’altro meraviglioso linguaggio che possiedo. So che questa lingua è da sempre arrivata prima della parola: la stimola e la contiene ed è quella che uso e amo da sempre. È il lavoro dell’arte.
Qual è stato il percorso scolastico e culturale che ti ha portata a esprimerti con le arti visive?
Sono Maestra d’Arte diplomata al Toschi di Parma. Una scuola che ho scelto contro la volontà della famiglia molto preoccupata del mio futuro che mi voleva al liceo. Devo però ringraziare i miei genitori che hanno creduto in me in tempi economici ancora difficili. Mi hanno regalato da contadini la libertà del mio desiderio e del mio piacere della vita. Amavo il segno fin dalle aste e i puntini dell’asilo. Costringere la mia mano a fare quello che voleva il mio cervello era una goduria espressiva estrema che non ho più abbandonato. Certo non è stato semplice insegnare, lavorare e dipingere, fare la casalinga e la madre, ma non potevo non parlare con questa lingua: era la mia più originale e profonda e l’ho sempre coltivata strappandola alle incombenze del quotidiano. Strapparla è stato creativo per il desiderio. Se non l’avessi usata non sarei più stata me stessa. Così, forte della mia conquistata e scolastica sapienza pittorica, ho passato il tempo a sublimare, a distruggere e ricostruire quello che avevo imparato a scuola tra ricerca di sintesi linguistiche, cromatiche e spaziali. Non è stato facile, molte sensazioni contrapposte mi agitavano ogni volta che lavoravo e cercavo di cambiare strada insieme all’idea di sbagliare, ma ad un certo punto ho cominciato a dare fiducia solo alle mie emozioni. A pescare nel loro farsi con l’obiettivo di dirle con tutta la libertà che mi potevo dare, guardando più il mio mondo sensoriale che a quello che mi dava l’esterno: il fuori mi deconcentrava. Lì sono diventata libera come artista.
Hai incontrato personalità artistiche che ti hanno particolarmente colpita o indirizzata, nel tuo percorso?
Non ho avuto tanto tempo per coltivare questi aspetti, lontani geograficamente da me, oltre a compagni e compagne di scuola. Abito in mezzo ai campi da sempre. Ma ho guardato molto artiste e artisti famosi che amavo, da quelli storici a quelli moderni. Pian piano li ho introiettati e digeriti grazie anche a una coscienza sempre più femminista che mi ha permesso critiche a convenzioni artistiche che mitizzavo. Un’altra idea di spazio nell’opera è la mia ultima liberatoria conquista: uno spazio della vita, non solo quello freddo, geometrico, acido di un taglio che ho adorato.
Ci fai qualche nome di artisti o artiste amate?
Nel mio Istituto d’arte, negli anni sessanta, le artiste non erano contemplate, nonostante avessi una insegnante di storia dell’arte. Lei seguiva i canoni classici che erano costituiti soprattutto dalla visione maschile e con quelli mi sono confrontata. Ho amato tutti i grandi nomi della storia dell’arte. Ogni nome era una scoperta di un mondo pittorico diverso e intenso per una ragazza che veniva dalla campagna: dai capolavori dell’arte greca e romana a quelli del medioevo che ritrovavo anche a Parma con l’Antelami, dove c’erano anche il Correggio e il Parmigianino, ai fiorentini e ai romani del Rinascimento e su fino all’impressionismo per fermarci a prima del futurismo. Il resto me lo sono fatta da sola. Ma lì ho imparato a confrontarmi con la pittura maschile senza sentirmi a disagio se poi non li condividevo più. Lì ho imparato un senso dell’armonia compositiva che ancora mi guida, anche se ho cambiato linguaggio espressivo, per cercare me stessa nel dire. E adesso so che sono una artista, donna, e che si vede nel mio lavoro. Credo ci sia un modo femminile di fare arte visiva nelle nostre opere e non solo se ricami. L’ho capito guardando i quadri di Joan Mitchell un giorno. Non so l’inglese e credevo di guardare i dipinti di un uomo. Ma quando sono arrivata davanti a certi suoi segni compositivi ho visto che avevano la stessa mia matrice informale e ho scoperto stupita che guardavo invece una donna artista. È un tema grande questo, tacitato troppo spesso con l’affermazione che l’arte, quando è arte, è sempre arte e non c’entra chi la fa. C’è una verità critica dentro questa affermazione che però a me non basta, perché sento che c’è anche altro. Sarebbe interessante se si provasse a guardare l’arte delle donne dal di fuori dei rassicuranti canoni storici che in qualche modo limitano studi più approfonditi, meno monotoni e omologanti. Siamo in un tempo in cui ci si può permettere qualche strutturale cambiamento mentale. Penso alla magica libertà di Maria Lai come artista donna nel suo filo azzurro che lega Ulassai alla montagna, che non trovo guardando altro, o alla leggerezza ironica delle foto di Tomaso Binga nuda e mai scontata nel suo Alfabetiere. O ai disegni scarni e urticanti di Carol Rama o a Marina Abramović mentre pulisce una montagna di ossa sanguinanti sulla prima guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale e sento che solo delle donne potevano arrivare lì.
Ritieni che la nostra società, con tutte le problematiche economiche, sociali e geopolitiche che si trova ad affrontare, dia il giusto spazio all’arte o alla cultura in generale? Abbiamo anche dovuto sentire, negli anni scorsi: «Con la cultura non si mangia». Pensi che sia ancora vero?
È un tasto dolente questo, soprattutto per le donne che vogliono fare arte. Difficile trovare spazi per artiste come me che non seguono sempre regole consolidate. Tomaso Binga (nome d’arte di Bianca Pucciarelli), una delle più brave e irriverenti artiste italiane viventi (ora ha ben novantun anni), mi ha detto da poco che lei ha cominciato a diventare famosa a ottant’anni e che avevo ancora molto tempo davanti… In fin dei conti io voglio parlare col segno e la luce del colore e il resto alla fine non mi riguarda. Preziosa è la libertà artistica che mi sono data con l’indipendenza economica e a quella libertà mi tengo ben stretta.
Quali sono state le tematiche che hai principalmente affrontato?
Sono sempre partita dal corpo: l’immagine che mi interessava di più, in particolare dal mio corpo di donna. Era quello che conoscevo meglio in un periodo in cui dipingere un modello era abbastanza superato. E dal mio sono arrivata al nostro, passando attraverso la ricerca di una sintesi del segno che fin dall’Istituto d’Arte mi attraeva. Andandomene pian piano dal corpo esteriore per ritrovarlo nella sua essenza più interiore, dopo essere passata dal trionfo del segno cromatico dell’informale di anni fa. Mi è servito per rendermi indipendente dalla forma reale. Ho persino fatto una serie di quaranta lavori su Le violon d’Ingres di Man Ray, una bellissima foto venduta da poco a un prezzo mai visto, irridendo la sua idea che il corpo di donna si possa suonare come un violino e poi appoggiare in un angolo nell’attesa del suo prossimo uso. L’ho fatto pensando all’Estasi di Teresa d’Avila del Bernini in Santa Maria della Vittoria a Roma e alla Kiki di Man Ray, chiedendomi chi tra le due donne abbia avuto di più da un amore. Sembra da come Man Ray ha architettato la foto di Kiki che lei vivesse nella sua ombra, ma nella sua biografia Kiki gli dedica circa una mezza pagina. Ho cercato anche di capire con questo lavoro se la forma corporea femminile avesse un modo femminile di essere vista, ma cambia solo l’interpretazione perché questa forma è già data per sempre a chi la guarda. Quello che non aveva capito Marchionne e chi pensa che si possa cambiare la definizione di donna per noi donne.
E i tuoi progetti in corso o futuri?
Il Mistero (negato) del corpo che non tace è un tema infinito. Ha così tante sfaccettature che sto ancora lavorandoci. È così vasto e complesso che ogni cosa che ci accade intorno lo riguarda e propone un altro punto di vista da cui osservarlo per cercare nuove soluzioni a quelle asfittiche dentro cui siamo come in una prigione. La rivoluzione della tenerezza è un altro punto di osservazione che ho rappresentato, da una recente splendida omelia sul grembo di Maria di Papa Francesco, dove afferma che «Gesù è cresciuto giorno dopo giorno nel suo grembo». Maria è stata sempre dipinta col bambino già nato in braccio e mai incinta, se togliamo la Madonna del parto di Piero della Francesca, e penso che col suo grembo si rivaluta finalmente quello di tutte. È un punto fermo sulle capacità del nostro corpo che prima non c’era. Ho realizzato quest’opera con uno zig zag enorme rosa: lo zig zag, un segno primordiale, per la rivoluzione, e il rosa femminile per la tenerezza, sempre a punto croce su di un grande lenzuolo.
Penso sia un passaggio dovuto al mio lavoro sul corpo delle donne. E oggi con questa terribile guerra in Ucraina parlare del mistero della madre e del nostro corpo – come matria in alternativa alla patria – mi sembra un liberatorio e auspicabile cambio di sguardo e lì sto lavorando nel mio nuovo lenzuolo appena iniziato. Poi esporrò una serie di 10 grandi carte disegnate su Genoeffa Cocconi Cervi, la madre dei Sette Fratelli Cervi uccisi nel ’43 dai fascisti. L’ottava vittima in quella famiglia, ancora in parte misconosciuta proprio perché una madre, morta poco dopo loro nel ’44, e sarà all’Istituto Cervi qui vicino in novembre. Genoeffa: una Maria laica.
Ringraziamo Clelia Mori per le interessantissime riflessioni e considerazioni, utili ad allargare anche i nostri orizzonti nella comprensione della realtà in cui viviamo.
(vitaminevaganti.com/Arti visive, Conversazioni, numero 168, 28 maggio 2022)
di Giuseppe Frangi
Nella storia di Corrado Levi, il caso gioca sempre un ruolo importante. Lo gioca con molta grazia e leggerezza. Nell’immediato dopoguerra, mentre era impegnato a recuperare gli anni perduti facendo l’università a tappe forzate, si era recato in visita a Ottone Rosai nel suo studio di Fiesole. Gli aveva comperato un piccolo quadro, dietro il quale Rosai aveva scritto una dedica: «A Corrado Levi con l’augurio di trovarlo pittore». Levi era iscritto ad Architettura, dove si sarebbe laureato con Carlo Mollino, ma evidentemente guardava alla sua vita come a un campo aperto e libero: del resto «Libero» era il cognome della madre che lui aveva adottato nel 1943-44 per scampare alle leggi razziali.
Levi è un «inclassificabile» in ogni senso. Lo testimoniano i biglietti da visita che con un tocco di ironia ha voluto squadernare in una doppia pagina alla fine di questo libro che colma una mancanza e finalmente ripercorre la sua storia creativa: Corrado Levi. Corpi (a cura di Beppe Finessi, con un testo di Luca Massimo Barbero, Electa, pp. 208, euro 32,00). Si dichiara architetto, e insieme «guanto giallo di savate», o boxe francese. Ma in un altro biglietto si definisce «fan di Boetti di Albini di Mollino di Klee di Schifano di Escher di Kraus di Zanichelli di Rama». Chi lo ha avuto come affascinante professore alla facoltà milanese di Architettura, si trovava davanti un maestro che non ha mai smesso di considerarsi allievo dei nomi di cui sopra, in particolare di Mollino, come più tardi di Franco Albini, «fratelli di nevrosi» per la comune ricerca della perfezione progettuale che li caratterizzava. Credeva nella virtù di «imparare l’uno dall’altro». «L’ho sempre fatto anche con gli allievi del Politecnico. Imparare guardandosi. Se non è un atto politico questo…», racconta nell’intervista a Maria Villa che correda il volume.
In una facoltà in ebollizione per le contestazioni studentesche, vara un progetto editoriale «Dalle cantine», con la sua costola «Dalle cantine frocie». Un numero speciale è dedicato a un artista-chiave per Corrado Levi, Pontormo, a cui lo lega una passione viscerale. Per Levi è un artista-chiave in ogni senso: addirittura assicura di aver ottenuto la cattedra al Politecnico dopo che Paolo Portoghesi lo aveva sorpreso, durante un’occupazione, a leggere in piedi il Diario del grande manierista. Un disegno di Pontormo, Il giocator sgambettante, è poi origine di una serie di lavori realizzati a inizi anni ottanta, «con occhi spalancati, mano attenta e cuore sognante», come sottolinea Finessi. Levi, dopo aver replicato su carta undici volte la figura pontormesca, ne ha coperto il sesso, spavaldamente ostentato, con pennellate di colori sempre diversi. Un tocco con cui sembra divertirsi a stare al gioco di «Madame Pontormo» (questo era il titolo del numero speciale della fanzine universitaria).
La politica entra sempre in gioco nel percorso di Levi. Ma entra attraverso pertugi imprevisti, mai con un andamento obbligante. La politica per lui è esperienza, e il corpo è il territorio immancabile di questa esperienza. Come scrive Finessi il corpo resta sempre «un territorio capace di rappresentare al meglio il suo pensiero, contenerlo, amplificarlo, permettendogli di mostrare la sua ricerca, tra ascolto, sperimentazione e humour». Quando sceglie di aderire al FUORI, lo fa anche «per attingere alle linfe colorate dei collettivi individuali, delle notti trascorse tra Artaud, Genet, l’illeggibile groviglio di Eliogabalo» (Massimo Barbero). Quando nel 2015 intercetta la ferita sociale dei migranti, decide di indossare uno sull’altro i vestiti abbandonati da chi era approdato sulla costa pugliese. Politica, anche in questo caso, è «lasciarsi attraversare dalle cose», prendersi addosso la realtà. La foto scattata per fissare quella performance, firmata da Finessi, rimanda in modo dolce ma perentorio ai corpi e alle vite assenti ma reali degli «arrivati».
Una decina di anni prima, avendo deciso di ristrutturare un vecchio riad a Marrakech per ricavarne un atelier, aveva lavorato al fianco dei muratori. Alla fine si era fatto dare le loro tute da lavoro, che ha poi montato in un assemblaggio circolare: praticamente ne è nato un rosone di impronta operaia. Il suo abito da cantiere è invece un’opera a parte, in forma di composizione danzante, come a comunicare la dimensione di un’inedita scioltezza. «Se non fossi così ingenuo nel manifestare le cose forse non avrei queste qualità», dice di se stesso, quasi per spiegare la semplicità ineffabile di tante sue soluzioni.
È una «levità», come la definisce Massimo Barbero, che caratterizza anche la sua esperienza pittorica, vera sorpresa di questo libro. Levi agisce in punta di pennello, con un segno che spesso è quasi stenografico. Si riconosce a monte il tocco del De Pisis più struggente e fuggitivo, o l’orizzonte errante di Licini. Levi si muove su quelle tracce ma è debitore a Mario Schifano, di cui da giovane è stato assistente, del raggiungimento di un’autocoscienza pittorica. Era accaduto a inizi anni ottanta, durante un’estate ad Ansedonia; un giorno Levi d’istinto aveva iniziato a lavorare su grandi tele distendendole nel prato. Vedendolo dall’alto Schifano aveva proclamato un «habemus pinctor» (sic), che per Levi è risuonato come un imprimatur importantissimo. Lui poi ricorda come Schifano lo richiamasse spesso all’idea della relatività: «L’ho interpretata come possibilità di non considerare l’opera un assoluto, ma come entità viva nello spazio e nel tempo, un furore».
Nelle pagine del libro scorrono le grandi tele di quegli anni; sembrano tutte pervase da fremiti fuggenti; la pittura avanza per accenni, per scosse leggere, dense di desiderio e di dolcezza. Lo sguardo di Levi, anche in pittura, è sempre uno sguardo amico, uno sguardo trepidante, soprattutto laddove l’intenzione è più scopertamente e teneramente erotica. È un «voler bene» al mondo che si esplicita nelle forme più inattese, con la capacità di abbracciare più pensieri. «Levi inizia tra le arti un percorso costruito attraverso acuti sincretismi», scrive Massimo Barbero. «L’arte, la visione, la società, il respirare quieto e profondo del rapace e del palombaro senza risparmiarsi campi di interesse ed escursioni».
Tra queste escursioni ce ne sono di fondamentali, come quella che lo ha portato a una relazione speciale con Carol Rama (documentata nelle meravigliose pagine ripubblicate in È andata così, Electa, 2009). Alla Biennale del 1993, su invito di Achille Bonito Oliva, Levi aveva allestito una sala personale a lei dedicata, stipando i lavori per nuclei omogenei ai quattro angoli; ogni angolo era allestito con criteri diversi, o affastellando le opere o disponendole ordinate. A vegliare la sala, appeso a un filo che scendeva dal soffitto, c’era un omaggio di Carol al suo curatore, Il chiodo di Corrado, un giubbino di pelle nera, imbottito sulla schiena di camere d’aria. Era un allestimento che restituiva tutta la pregnanza fisica di quelle opere-corpo, «buchi di me» come le aveva definite la stessa Carol Rama.
Di sorpresa in sorpresa il libro porta a riscoprire quell’intervento realizzato per «Rapido fine», una rassegna organizzata nel 1986 da un gruppo di artisti negli spazi della Zenith, fabbrica abbandonata a Ferrara. Levi si era fatto vivo portando un presepe e allestendolo con grande cura in un angolo dell’edificio. Il senso di quel gesto era semplicemente di donare un oggetto pieno di sentimento a quel luogo in rovina. C’è sempre una quota di stupore nelle azioni artistiche di Corrado Levi. Come scrive Barbero, l’arte per lui è ogni volta «un inciampo libero».
(il manifesto, 8 maggio 2022)
di Arianna Di Genova
Biennale Arte 59. La rassegna internazionale raccontata dalla curatrice ufficiale della mostra
Già nel 2017, quando era stata chiamata a curare il padiglione Italia, Cecilia Alemani si era incamminata in direzione della linea fantastica che aveva attraversato il ’900, in pittura come in letteratura. Coerente con quella intuizione intrisa di magie e allucinazioni, torna in Laguna dall’America in cui vive, questa volta per imbastire il grande puzzle della mostra ufficiale della Biennale. E lo affida a un buon 80% di presenza femminile (213 in tutto le e gli «ospiti») e alla scrematura onirica de Il latte dei sogni (23 aprile – 27 novembre), stesso titolo del quadernetto privato che raccoglieva le storie eccentriche, intessute di mutazioni e ibridazioni tra specie, inventate dalla inglese-messicana Leonora Carrington, scrittrice e artista convinta che ognuno di noi possedesse «un’anima animale, un proprio bestiario interiore».
La sua mostra è modulata nell’alternanza di presente e passato, con produzioni recenti e «capsule del tempo». Può spiegarci meglio?
Ho immaginato una mostra che potesse unire temporalità e mondi differenti. Ovviamente, la rassegna ha guardato tanto al contemporaneo, a produzioni degli ultimi due anni, ma si è anche volta al passato, alla storia stessa della Biennale e dell’arte in generale, per intrecciare una costellazione di lavori – soprattutto del ’900 – che potessero dialogare con quelli contemporanei (nell’allestimento, le due «linee» sono parzialmente separate). Vorrei che le «capsule» offrissero allo spettatore delle lenti per leggere l’arte, compresa quella più vicina al nostro tempo. Surrealismo, Futurismo, Bauhaus mi permettevano di focalizzare l’attenzione sulla produzione di opere di artiste che hanno militato in quei movimenti ma che sono state dimenticate. Era un modo per ricucire quella storia e intersecarla con il contemporaneo. La storia non è qualcosa di fisso e archiviato, ma va ripescata e reinterpretata.
Possiamo rintracciare un filo conduttore per orientarsi nella esposizione tra Giardini, Corderie e Arsenale?
Anche ingenuamente, mi piace dire che a una mostra ci vado perché voglio imparare, non solo sentirmi engaged. Le capsule storiche possono aiutare a capire che alcune tematiche – come la metamorfosi o il cyborg – non sono una mia invenzione. Naturalmente, la metamorfosi è un tema che nella storia dell’arte è presente da centinaia di anni, anche nel lavoro di artiste oggi poco conosciute. Operavano spesso accanto ai loro colleghi uomini portando avanti le loro ricerche. E, le loro produzioni sono diventate anche più contemporanee e attuali, soprattutto alla luce della pandemia.
La parola «sogno» rimanda a una sospensione temporale, a un fluttuare della coscienza… È una cancellazione di quel che stiamo vivendo?
No, casomai la dimensione onirica è una metodologia utilizzata dagli artisti per processare proprio i traumi del presente. Non è una fuga, un voltare le spalle all’urgenza del momento. Mi sembra di poter dire che è uno strumento che gli artisti hanno usato nell’isolamento cui siamo stati costretti. La solitudine ha favorito il ricorso all’introspezione, all’inconscio per rielaborare quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni. Non solo il contenuto dei lavori è interessante, ma anche lo stile scelto per confrontarsi con quel trauma. C’è molta pittura, è una mostra fisica e materiale, rifugge dall’arte più concettuale e astratta. È un percorso che si deve attraversare col proprio corpo. Forse è il risultato di averla preparata tramite lo schermo e la mediazione del computer, con incontri e visite in studio online. È ciò che volevo vedere e non potevo durante la pandemia – la fisicità di un quadro o la presenza scultorea di un’installazione.
Oltre alla preponderante presenza di artiste c’è una attenzione alle culture indigene e alla loro lingua creativa. Una corrispondenza di intenti che risuona con alcuni padiglioni e che sembra indicare uno spostamento della Storia…
Ovviamente, io parlo dal mio punto di vista che è quello di donna bianca, occidentale, privilegiata, però mi interessava portare a Venezia delle simbologie e visioni del mondo diverse dalla mia, che espandessero il concetto di storia. L’idea di fondo è: «Cosa stiamo narrando?». Chiamo tutto ciò «mito» in modo generico, quelle narrazioni parallele che non obbediscono ai canoni cui siamo abituati. Questo approccio è nato quando preparavo il mio padiglione Italia. Avevo ripreso gli studi di Ernesto De Martino, lui era affascinatissimo dalla cultura orale, quella non scritta dei tanti rituali del sud Italia. Volevo dare spazio a una formulazione diversa.
Ci sono alcune muse ispiratrici per disegnare un immaginario quadrilatero magico della rassegna?
C’è Leonora Carrington, naturalmente e accanto a lei – nell’ipotetico quadrilatero – metterei Magdalene Odundo (nata a Nairobi nel 1950, in Kenya, vive e lavora in Inghilterra), che realizza bellissime ceramiche a forma di corpo come contenitore di vita. Poi, Barbara Kruger, per lo shock di scoprire quanto il suo lavoro con gli slogan femministi degli anni 80 sia ancora così rilevante – è da notare, forse, la nostra società non si sta evolvendo così tanto. E Belkis Ayon (L’Avana, 1967 -1999), artista cubana che racconta strane mitologie africane esportate ai Caraibi e le rivisita in chiave matriarcale e femminista. Un lavoro potente il suo.
Molte opere pongono in primo piano le altre specie…
La considerazione di un mondo popolato da tante creature viventi rappresenta una parte fondamentale degli artisti presenti nel percorso della mostra. Si dà spazio al desiderio di immaginare un pianeta in cui il rapporto fra esseri umani e natura sia meno di sfruttamento, non gerarchico, più orizzontale e simbiotico. Questo è ciò che dice anche Rosi Braidotti e che sottolineano altre filosofe del postumano. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Il virus, una forza invisibile, ha capovolto il nostro modo di pensarci, abbattendo la nostra «superiorità» come specie.
Infine, una domanda extra: lei vive in America, cosa pensa della «cancel culture»?
In Italia non si ha molta voglia di capire cosa sia. Non si tratta di censure. Certamente, l’America è una società estrema, senza mediazioni. Ma è un processo difficile: per comprendere quel che è accaduto nello spazio pubblico ai monumenti dobbiamo interrogarci su cosa sia successo nel ’700, nell’800, o semplicemente ottanta/cento anni fa. È un esercizio utile per mostrare che siamo una società viva. La storia deve poter cambiare. Non c’è niente di male a contestualizzare un oggetto nello spazio pubblico, soprattutto se è simbolico. Ma il problema è che al fondamento di tutto ciò, al tavolo delle decisioni si deve sedere chi si sente offeso dalla statua o monumento. Se continuiamo a parlarne fra noi non ha nessun senso.
(Alias – il manifesto, 16 aprile 2022)
di Francesca Amé
Se non avete ancora messo piede alla Fondazione Ica di Milano, questa è la volta buona per rimediare. Siamo in zona ex scalo di Porta Romana, la torre d’oro di Fondazione Prada luccica poco distante: l’ingresso, al civico 26 di via Orobia, è industriale. Solo un piccolo stencil ci dice che, varcata la soglia di quello che appare come il passaggio di una delle tante fabbriche nei dintorni, dentro ci si trova ben altro. Arte contemporanea, nello specifico, ma anche editoria, ceramica, cinema, performance, musica, formazione: siamo in uno spazio privato, ma l’istituzione è no profit. L’idea di base: valorizzare tutte le forme d’arte senza mettere troppe etichette e aprirsi a ogni genere di pubblico. È diventato uno degli indirizzi da tenere d’occhio, e lo dimostra anche l’apertura (coraggiosa, in questi giorni di gennaio in cui Milano appare ancora deserta, praticamente quarantenata) di un tris di mostre personali, tutte aperte fino al prossimo 6 marzo.
Espongono la franco-libanese Christine Safa, la siciliana ma di casa a New York Maria Rapicavoli, la svizzero-americana Olympia Scarry.
C’entrano poco l’una con l’altra: sono tutte giovani, donne e con una biografia che abbraccia diverse latitudini, ma poi ciascuna presenta il suo percorso, la sua idea. Non è una mostra tripartita, sono proprio tre mostre diverse.
Si comincia a piano terra, con White Noise, il rumore bianco delle sculture di Olympia Scarry, anzi delle composizioni alchemiche disseminate sul pavimento e disegnate alle pareti in cui l’artista riflette sul senso del suono e del tempo.
Salite le scale si entra del magico mondo di Christine Safa, che ha solo ventisei anni e la saggezza di una donna matura: riccioli neri, poliglotta, una vita divisa tra la Francia (dove i genitori sono migrati) e l’amato Libano (dove torna, quando può, in estate) ci riconcilia con la pittura, dimostrando che non è affatto un genere superato. Nei suoi lavori troviamo la luce mediterranea, spesso creature addormentate o colte in attimi di sospensione, e dei colori, come l’arancio bruciato e il blu, che rimandano ai ricordi d’infanzia dell’artista. Nei ritratti senza volto così come nelle composizioni paesaggistiche Christine Safa cattura il Libano, il suo posto del cuore. Ama giocare con le linee, inventando volti e corpi che diventano montagne all’orizzonte. «Tutta la mia arte è sospesa tra due mondi, appartengo a entrambi», ci dice davanti alla sua “geografia di espressioni” che compongono C’era l’acqua, ed io da sola, il titolo della personale curata da Alberto Salvadori.
Rinfrancati da questa luce, attraversiamo il piazzale interno: nell’edificio di fronte bisogna prendersi 20 minuti buoni, spegnere il cellulare e osservare con calma la toccante video-installazione (su due diversi schermi) di Maria Rapicavoli, catanese che lavora in America. Qui si narra – ma al modo in cui fanno gli artisti: per visioni, per accostamenti audaci – la vera storia di Mena, giovane italiana costretta ai primi del Novecento a sposare l’uomo che aveva abusato di lei per poi emigrare con lui nei pressi di Boston, dove ha passato la vita tra il tentativo di rivendicare la propria identità e libertà e la difficoltà a emanciparsi. Una storia particolare che diventa subito universale: ai nostri occhi, specie oggi, risulta davvero perturbante.
(Vogue.it, 20 gennaio 2022)
di Redazione
Sono stati presentati gli otto progetti per la statua di Margherita Hack: uno di questi diventerà un monumento pubblico all’astrofisica. Le opere sono tutte realizzate da artiste. Ecco quali sono, cosa significano, le loro foto.
Si tiene dal 19 gennaio al 13 febbraio 2022, presso la Casa degli Artisti di Milano, la mostra Una scultura per Margherita Hack, la rassegna organizzata da Fondazione Deloitte, in collaborazione con Casa degli Artisti e con il supporto del Comune di Milano – Ufficio Arte negli Spazi Pubblici. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di donare alla città di Milano la prima scultura su suolo pubblico dedicata a una storica figura femminile nonché massima espressione del mondo STEM, Margherita Hack (Firenze, 1922 – Trieste, 2013), astrofisica, accademica e brillante divulgatrice scientifica del ventesimo secolo. Il progetto di realizzazione è già partito e la scultura sarà inaugurata a giugno dell’anno prossimo in occasione del centenario della sua nascita.
Casa degli Artisti ha invitato una selezionata rosa di artiste italiane e internazionali a partecipare al concorso di idee per la realizzazione dell’opera. Le artiste che hanno aderito all’invito sono Chiara Camoni, Giulia Cenci, Zhanna Kadyrova, Paola Margherita, Marzia Migliora, Liliana Moro, Sissi e Silvia Vendramel. La conferenza stampa in cui verranno annunciati la menzione speciale, il progetto vincitore, lo spazio pubblico scelto per l’installazione dell’opera e le motivazioni della giuria, è prevista il 9 febbraio 2022 alle ore 11:00, sempre presso Casa degli Artisti (era inizialmente prevista per il 19 gennaio, ma è slittata). Vedrà la partecipazione di: Guido Borsani (Presidente di Fondazione Deloitte), Valentina Kastlunger (Presidente di Casa degli Artisti), Fabio Pompei (CEO di Deloitte) Italia, Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura del Comune di Milano), Vincenzo Trione (accademico, critico d’arte e Presidente di Giuria) e Anna Wolter (astrofisica ricercatrice all’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e membro della giuria). Sarà infine presente l’artista vincitrice. Sarà possibile seguire la conferenza anche da remoto sui canali social di Deloitte Italia e Casa degli Artisti.
La mostra presenta al pubblico i testi, i disegni, i rendering e le maquette che illustrano gli otto progetti proposti. Le artiste hanno risposto alla sfida di progettare, attraverso il proprio peculiare linguaggio, un’opera dedicata alla donna Margherita Hack e al suo operato, che sia chiaramente identificabile in quanto tale, e di proporre, al contempo, una riflessione sul concetto stesso di monumento e sulla sua forma tradizionale. L’attenzione alla ricerca scientifica della Hack ma anche alla sua vita personale, alla coerenza delle sue scelte professionali, civili e politiche, all’impegno dimostrato per la divulgazione della scienza, il rapporto con lo spazio pubblico e un ripensamento dell’atto del ricordare, sono elementi chiave che legano, seppure in modi diversi e con scelte anche distanti, i lavori presentati.
L’artista vincitrice sarà in residenza a Casa degli Artisti, che le fornirà il supporto necessario alla realizzazione dell’opera. La scultura verrà donata al Comune di Milano e Fondazione Deloitte si farà carico della manutenzione per gli anni a venire. La giuria di selezione, composta dal Presidente di giuria Vincenzo Trione (accademico e critico d’arte) e i giurati Guido Borsani (Presidente Fondazione Deloitte), Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia), Alessandro Oldani (Conservatore dei Beni Culturali presso l’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano), Benedetta Tobagi (giornalista e scrittrice), Diletta Huyskes (ricercatrice in gender & technology ethics), Sara Sesti (docente di Matematica e membro dell’Associazione “Donne e Scienza”), Anna Wolter (astrofisica ricercatrice all’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera), Simona Cerrato (fisica e divulgatrice scientifica, collaboratrice di Margherita Hack), Alberto Salvadori (direttore di Fondazione ICA Milano, membro del Comitato scientifico di Casa degli Artisti), Giovanna Amadasi (Head of Public and Educational Programs Pirelli HangarBicocca), Chiara Costa (Responsabile programmazione Fondazione Prada), Milovan Farronato (critico e curatore indipendente), Alessandro Danovi (Accademico e direttore finanziario di Casa degli Artisti) si è riunita il 29 novembre scorso e, dopo un’intensa e approfondita discussione, ha scelto il progetto vincitore e deciso di conferire una menzione speciale a un secondo progetto. Ecco di seguito i progetti presentati.
Chiara Camoni
Affascinata dalle stelle binarie, uno degli ambiti di ricerca della Hack, Chiara Camoni ha immaginato un monumento che si sdoppia in due elementi separati ma simbiotici: una presenza fisica e materiale nella città, in cui saranno assemblati ferro, alluminio, ottone, argento, oro, rame, silicio attraverso la fusione di oggetti di uso quotidiano e un film che sappia interpretare la sua vita, la sua persona, l’approccio all’astrofisica. Siamo fatti di stelle, titolo dell’opera, riporta la materia alla sua origine e a quanto ripeteva la Hack. Tutti gli elementi presenti sulla Terra provengono dalla fusione nucleare e dalle esplosioni delle supernove. Le stelle creano quindi gli elementi della tavola periodica, inclusi quelli che costituiscono il corpo umano.

Giulia Cenci
È un’opera anti-monumentale quella suggerita da Giulia Cenci. Una scultura che non è la raffigurazione di un corpo, ma di una mente capace di comprendere il mondo che la circondava in modo umile e appassionato. In questa scultura il corpo perde le sue sembianze classiche ed è ridotto a pochissimi elementi. Parti di calchi di ossa umane ed animali sono fuse ed ibridate per costruire delle linee guida in tensione, sospese sul perimetro di un letto semplice. Su quest’asse è trattenuto e sospeso un volto dormiente. L’origine di questa forma proviene dal calco di un manichino per la rianimazione, alla cui fisionomia anonima sono stati sovrapposti manualmente i tratti fisionomici della Hack. Il corpo è costituito dall’incontro dei lasciti (o strutture interne) di varie specie animali o umane.

Zhanna Kadirova
La proposta di Zhanna Kadirova è una figura sagomata raffigurante la Hack con una torcia in mano che illumina un frammento di cielo stellato su un grande vetro blu. Quel frammento è il cielo della data e dell’ora di nascita della Hack, che potrà essere visibile o non visibile a seconda della posizione delle stelle. Un omaggio che si concentra sull’inizio della vita di una scienziata, astrofisica dal forte impegno civile e politico. Durante il giorno la luce del sole illumina le figure sul vetro e il cerchio proietta una bella ombra del cielo notturno sul terreno. Al calar della notte, la torcia che tiene in mano la scienziata e una striscia LED incorporata nel contorno dell’ellisse, illumineranno le costellazioni e le stelle impresse sul vetro.
Paola Margherita
Paola Margherita rappresenta Margherita Hack con due elementi separati. Una raffigurazione della Hack in età ancora giovanile, a figura intera, che si cimenta in un gesto atletico-giocoso a testa in giù, mentre si arrampica su un traliccio. Tale traliccio allude al piede di un radiotelescopio. Il secondo elemento è la modellazione della scia che lascia un meteoroide nell’aria mentre sta per sfiorare il suolo. I due distinti elementi scultorei sono distanti fra loro, ma sempre contemporaneamente presenti nel campo visivo degli osservatori.
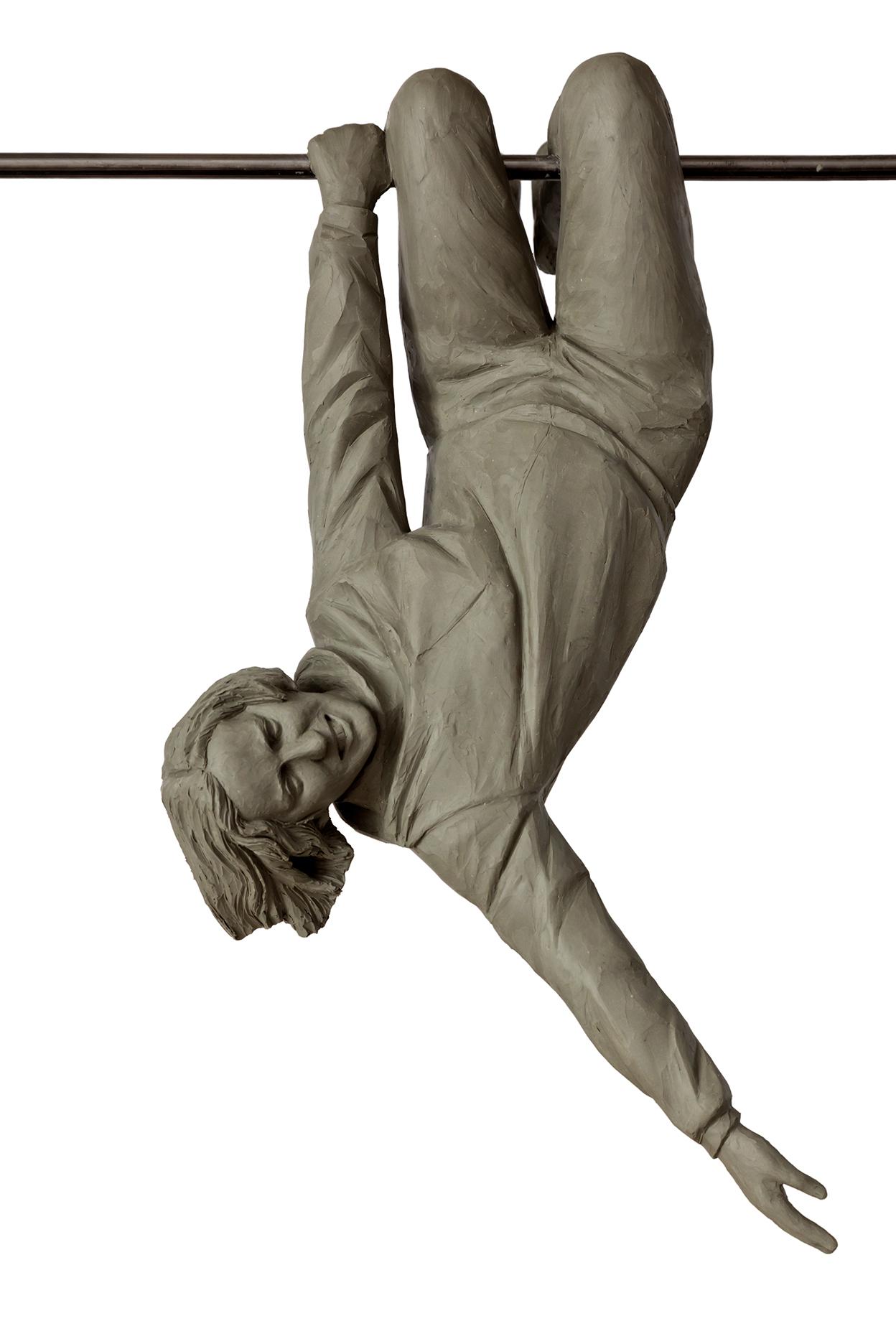
Marzia Migliora
Marzia Migliora riprende la definizione della Hack di donna con gli occhi al cielo e i piedi piantati a terra, per immaginare un’opera dove le stelle possano toccare terra per diventare una pavimentazione da percorrere, in cui sostare, giocare e apprendere. Uno spazio sociale e di prossimità tra corpi umani e celesti. La pavimentazione riproduce una porzione di calotta celeste: la costellazione di Cefeo, che comprende 168 stelle e 1 nebula. Le coordinate e la collocazione delle stelle sono una riproduzione fedele delle loro posizioni visibili nel cielo notturno. L’installazione è realizzata in lastre di cemento, con inserti in marmo policromo e acciaio, arricchita da elementi testuali e multifunzionali, con cui le persone avranno la possibilità di interagire. Le 8 stelle che compongono la costellazione saranno superfici su cui potersi sedere e il pubblico potrà interagire con l’installazione posizionando la torcia dello smartphone sulla superficie di alcune delle sedute di marmo e così “accendere le stelle” posizionate sul pavimento, attraverso cavi di fibra ottica.
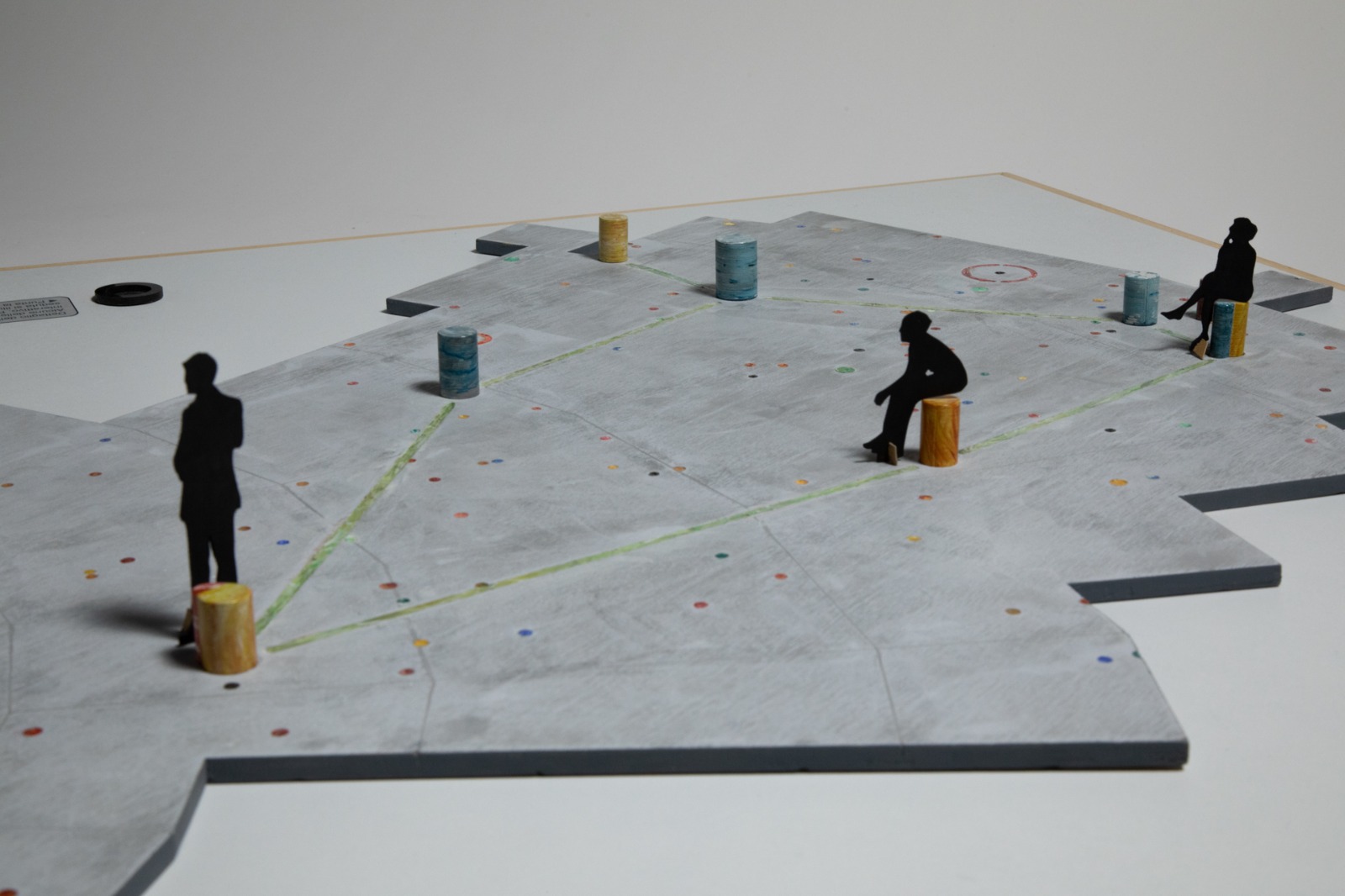
Liliana Moro
Liliana Moro si sofferma non solo sugli studi scientifici, ma soprattutto sulla vita personale della Hack: grande sportiva, amante degli animali, vegetariana, divulgatrice, impegnata nella vita politica e sociale. Donna che rappresenta un esempio di coerenza e di passione. La scultura, realizzata in bronzo, rappresenta Margherita Hack a mezzo busto e poggia su una base circolare non regolare che somiglia a un vortice, a una spirale, ma anche ad un’architettura atipica, che ricorda il movimento circolare di una ruota di bicicletta. Il movimento ascensionale è amplificato dalla posizione inclinata del busto e dalle braccia sollevate a formare un cannocchiale con le mani. Sulla base circolare come fossero un solo corpo, un cane e un gatto, il cane guarda noi mentre il gatto volge lo sguardo verso Margherita e il cielo.

Sissi
Sissi rappresenta la Hack come una metamorfosi: una persona nata dagli elementi di una galassia e impegnata a studiare le stelle che la formarono. Un interrotto flusso di vita che parte dalle stelle per tornarvi. Margherita Hack ci insegna che l’essere umano non è cosa altra rispetto all’universo ma ne è parte integrante: non guarda il cosmo dall’esterno ma dal suo interno. Il monumento di Margherita Hack è una scultura in bronzo che la vede raffigurata mentre, emergendo da una galassia, osserva le stelle. Alzando le braccia verso l’alto, simula un telescopio. La statua invita a riconoscerci simili, perchè raffigura una comune gestualità, che è quella di guardare le stelle senza alcun mezzo tecnico: un invito al sogno e all’immaginazione. Con il titolo Sguardo fisico svela la sua identità di astro-fisica giocando con due parole per lei caratterizzanti. Lo Sguardo è il senso capace di percepire gli stimoli luminosi mentre Fisico non solo richiama la radice della sua professione, ma anche la concretezza e solidità del suo atteggiamento intellettuale e filosofico.

Silvia Vendramel
Una scultura sensibile all’incidenza della luce, che possa offrire a chi la vive nello spazio pubblico un’esperienza corporea, fisica e visiva insieme, è la proposta di Silvia Vendramel. Una scultura che ricrei condizioni simili a quelle della ricerca scientifica in cui nulla è dato per scontato e solo attraverso una lenta, costante e visionaria osservazione è possibile attingere alla conoscenza. La giustapposizione di materiali e forme realizzate con vetro, bronzo, alluminio su cui la luce ha incidenza diversa a seconda del trascorrere del giorno. Incisioni e fori presenti sulla superficie in bronzo costituiscono una libera interpretazione di simboli ancestrali relativi alle costellazioni.


(www.finestresullarte.info, 19 gennaio 2022)
di Giulia Menzietti
«A partire dall’ultimo quarto del XIX secolo, la strada percorsa dalle donne nel campo dell’architettura per raggiungere una giusta emancipazione e riconoscibilità in un universo di fatto maschile non solo è stata lunga, ma anche segnata da momenti storici e professionali diversi. Le prime progettiste lavorarono per far sentire la presenza di una voce femminile nel settore, dal secondo dopoguerra si sono sempre più potentemente imposte come leader. Non più voci isolate ma componenti significative della professione».
A Maristella Casciato, cui si deve la consulenza scientifica delle ricerche per la mostra apertasi al Maxxi Good News. Donne in architettura (fino al 24 aprile 2022), così come una delle voci della sezione «Narrazioni», non sono mai piaciuti gli elenchi («anche se a volte sono utili come matrice di un ordine») e tantomeno le classifiche. Storica dell’architettura, attualmente Senior curator, Head of architecture special collections al Getty Research Institute a Los Angeles. Docente universitaria, in Italia e all’estero, curatrice di mostre come Bauhaus Beginnings (2019) al Getty Research Institute e Gio Ponti. Amare l’architettura al Maxxi (2019), e autrice dei libri Casablanca Chandigarh. Reports on Modernization (con Tom Avermaete, 2013), The Metropolis in Latin America, 1830-1930 (con Idurre Alonso, 2021), Rethinking Global Modernism. Architectural Historiography and the Postcolonial (con Vikram Prakash e Daniel Coslett, 2021), Casciato ha condiviso con il manifesto alcune riflessioni sui temi affrontati nell’itinerario espositivo.
Tra le architette che hanno cercato di affermarsi nel campo della professione, quali sono le sue preferite?
Tutte le architette «ospitate» in questa mostra hanno, nel corso di un secolo e mezzo, reso possibile questa rivoluzione. Non saprei quindi indicare quali siano le mie preferite, anche se con alcune avverto una maggiore affinità. Non sono una progettista, il che mi fa sentire più vicina a quelle che hanno lavorato per creare occasioni fertili affinché la voce delle altre si potesse sentire; hanno curato esposizioni, prodotto manifesti, elaborato un pensiero teorico attraverso riviste e pubblicazioni, sono state docenti che hanno sempre difeso un percorso pedagogico in cui le più giovani avessero la libertà di parlare e, ancor più importante, fossero ascoltate. A loro mi sento più vicina.
La rassegna racconta la progressiva trasformazione dello status dell’architetto, che dalla figura del singolo maestro sembra migrare sempre più verso formule di studi a coppie, o collettivi etc… Pensa che questo processo abbia a che fare col fenomeno più globale della gender equality? O che risponda alla progressiva apertura, nel campo del progetto, verso altri territori d’indagine e alla necessità di lavorare in team con contributi multidisciplinari?
Non credo che la pratica professionale, di coppia o collettiva, sia figlia di un superamento del gender gap. Anzi, nel caso delle coppie di progettisti in cui sono presenti i due generi, la vera battaglia è stata quella che le donne hanno combattuto per difendere il loro privato rispetto all’aggressività del mondo del lavoro in generale. Spesso la biografia di coppia è stata più felice di quella per un uguale riconoscimento del valore di ciascuno da parte degli agenti esterni. Si veda la polemica protesta di Denise Scott Brown nei confronti della commissione del Pritzker Prize quando il premio fu assegnato al solo Robert Venturi. Concordo nel leggere la professione come un processo sempre più poliedrico, pluridisciplinare ma non solo, integrato nel ricercare la multietnicità, sfaccettato per quanto concerne le competenze, certamente sempre più competitive. Anche in conseguenza della pandemia, quella dell’architettura è, fra tutte le professioni, la più porosa, la più coraggiosa nell’accettare le diversità, la più visionaria… Infine, la più bella.
Alla luce della sua esperienza di storica, trova sia possibile identificare un’attitudine specifica delle donne verso l’architettura, un atteggiamento progettuale verso il disegno dello spazio che emerge nel lavoro delle progettiste più che in quello dei loro colleghi?
Le donne sono fra loro diverse, come lo sono gli uomini. Ed entrambi i sessi sono fra loro incomparabili. Dipende dalle condizioni (politiche/culturali) in cui si lavora, dal momento storico, dalla committenza, dal mercato, per citare solo alcune delle sovrastrutture con le quali ogni professionista si trova a operare; dagli interessi di ciascuna verso il progetto di architettura piuttosto che per il design, verso il paesaggio piuttosto che per la pianificazione urbana, verso la piccola scala artigianale piuttosto che per la macrostruttura, verso le infrastrutture piuttosto che per i sistemi tecnologici complessi. Le donne hanno dimostrato una grande duttilità nel muoversi attraverso questi universi spaziali, flessibilità e intuito, pazienza e coscienza del proprio essere femminile, autocritica e autoironia. È chiaro che la diversità di genere non è un’invenzione della contemporaneità. Ne siamo diventate più consapevoli e fiere.
Il campo dell’architettura, della professione e del cantiere sono sempre stati territori prevalentemente appartenenti al mondo maschile. Anche l’ambito teorico, legato alla ricerca e alla critica è stato quasi sempre rappresentato da autori maschili; addirittura è forse più facile farsi venire in mente nomi di note progettiste, piuttosto che di autrici, ricercatrici o storiche dell’architettura. Quali sono, secondo lei, le principali ragioni di questo fenomeno?
Sicuramente, una disparità di occasioni, sia nell’ambito professionale, che in quello accademico. Ma ciò che mi sembra importante sottolineare è che questa tendenza si sta ribaltando. I contributi delle donne al pensiero storico-critico in architettura sono molto aumentati nell’ultimo trentennio. Nella gran parte dei casi si tratta di un lavoro che è più capillare, che esamina i dettagli, che opera sui microcosmi senza pretendere di creare teorie globali. È una storia che si interroga, che introduce il dubbio come apparato investigativo, che si confronta anche con altre discipline, allargando il campo a contenuti nuovi e a un racconto pieno di sorprese.
(il manifesto, 2 gennaio 2022)
di Valeria Palumbo
Guardano in «macchina», le pittrici e le fotografe che si ritraggono. Perfino, come fa coraggiosamente Paula Modersohn Becker nel 1906, quando si ritraggono nude e non belle o anziane. Impietose, direbbe qualcuno che ritiene che le donne, come ci si ostina a credere per la Contessa di Castiglione, si facciano ritrarre o si ritraggano soltanto per offrirsi a uno sguardo compiaciuto. Non necessariamente maschile, ma altrui. Che l’unico scopo del loro «mettersi in posa» sia il farsi guardare e ammirare. Passive. Perfino nella seduzione. Ribalta quest’ottica una bella mostra aperta fino al 2 gennaio alla Fondazione Beyeler a Riehen, appena fuori Basilea in Svizzera. Si intitola Close up [da vicino, n.d.r.] e raccoglie le opere di nove artiste, in particolare i loro autoritratti, tra Ottocento e giorni nostri. Non a caso, nel recensire la mostra, il celeberrimo quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung o Nzz mette in apertura proprio l’autoritratto di Modersohn-Becker: un capolavoro di ironia. Superato solo dal sarcasmo di Frida Kahlo. Per inciso Paula Modersohn-Becker, esponente di punta del primo Espressionismo, in 31 anni di vita e 14 di attività, realizzò 750 dipinti e mille disegni. Morì per le complicazioni del parto, dopo aver dato alla luce la prima figlia, Mathilde. In un’illuminante lettera del 17 febbraio 1906 al poeta Rainer Maria Rilke, oggi ben più famoso di lei e piuttosto bizzarro (già celebre per il triangolo con Lou Andreas-Salomé, si innamorò di Paula al primo incontro, ma poiché lei si era appena fidanzata, sposò, brevemente, la sua migliore amica, la scultrice Clara Westhoff), Paula scrisse: «Io sono io, e spero di diventarlo sempre di più, Ich bin ich, und hoffe es immer mehr zu werden».
Problemi di identità
Non che gli artisti uomini non abbiano mai avuto problemi di identità. Anzi. Il punto è che alle donne, sempre, anche quando avevano idee chiarissime su chi fossero, qualcuno ha cercato di spiegarlo. Meglio, di imporlo. E guarda caso erano identità piccole piccole, ben calibrate sui desideri, le esigenze, le paure e, a volte, le perversioni dei maschi. Perfino sulle loro idealizzazioni: e in questo caso le identità, più che piccole, risultavano poco adatte a un essere umano, tra muse angelicate, madri-martiri, belles dames sans merci e mogli kamikaze. In questa costruzione di identità altrui, le arti visive hanno svolto un ruolo fondamentale (e continuano a svolgerlo, cinema in testa). Eppure, è proprio nella pittura e nella fotografia che le artiste hanno avvertito da subito che no: così non era. Loro non si vedevano, e non volevano essere viste, come gli altri le disegnavano. Hanno cominciato le pittrici del Rinascimento, Sofonisba Anguissola e Artemisia Gentileschi in testa. Una con l’autoritratto più fiero, sereno e severo di donna che il Cinquecento ricordi. L’altra con quella sua esuberanza quasi ingombrante (come Allegoria della pittura), che così bene sintetizza un secolo complicato come il Seicento. E hanno proseguito le altre: dalla francese Elisabeth Vigée Lebrun che si ritrae in mille modi, pittrice, madre autonoma ed erede di Rubens, alla britannica Elizabeth Siddal, che il marito, Dante Gabriele Rossetti, chiude nello stereotipo della vergine sognante, spaventata e anche stordita di droga. E che invece si auto-ritraeva triste e anche piuttosto arrabbiata.
Vittime dei pregiudizi
Nella mostra di Basilea, Close Up, il racconto comincia con le impressioniste. In particolare Berthe Morisot e Mary Cassatt, vittime entrambe non solo dei pregiudizi di un’epoca tanto pruriginosa e severa con le donne libere, quanto (ancora oggi) scandalosamente deliziata dagli eccessi maschili. Alle pittrici non era concesso riprendere modelli dal vero. Neanche un braccio nudo di maschio. Nemmeno mucche all’aperto, se è per questo: mica se ne potevano andare in giro da sole. Se poi, come Victorine de Meurent (celebre soprattutto come la “scandalosa” modella nuda di Edgar Degas), si prostituivano pur di continuare a dipingere, perché per loro non c’era mercato, affari loro. Neanche le accademie d’arte le volevano. E così Morisot, che pure viveva tra amici pittori tanto trasgressivi e all’avanguardia, scriveva sul suo Carnet, nel 1891: «Non credo che sia mai esistito un uomo che abbia trattato una donna da pari a pari, eppure è tutto quello che avrei voluto, perché so di valere, Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un homme traitant une femme d’égal à égal, et c’est tout ce que j’aurais demandé, car je sais que je les vaux».
Il dipinto di Marie Bashkirtseff
Non a caso la mostra alla Fondazione Beyeler termina con un magnifico dipinto dell’ucraina Marie Bashkirtseff (ma perché a scuola non abbiamo studiato neanche lei?), L’Académie Julian, del 1881, in cui un gruppo di sole pittrici ritrae un San Giovannino nudo che guarda perplesso verso la “macchina”. E ovviamente a nessuno può sfuggire l’ironia della scelta: San Giovanni è quello che ne disse tante contro la povera Erodiade che, grazie ai desideri espressi dalla figlia di lei, Salomé, dopo una celebre danza, si ritrovò senza testa. Osservatelo con attenzione quel quadro, se vi capita. Perché siamo talmente abituati a osservare scene in cui tutti gli artisti (magistrati, medici, scienziati, etc.) sono maschi vestiti e le donne, se ci sono, se ne stanno lì come agnellini sacrificali, o abbassando pudicamente lo sguardo oppure offrendosi esplicitamente, che vedere un luogo in cui contano solo le donne e l’unico uomo è l’agnellino di turno, ci crea ancora un certo disorientamento. Scriveva Marie nel suo Journal, il 1° maggio 1884: «Se non muoio giovane, spero di rimanere nella memoria come una grande artista; ma se muoio giovane, voglio far pubblicare il mio diario perché non può essere altro che interessante».
Sapere di valere
Ecco, qui la consapevolezza è piena: so chi sono. E so di valere. Magari ci rido su. È quello che fanno quasi tutte le artiste di Close Up, da Frida Kahlo, appunto, alla nostra contemporanea Cindy Sherman, con i suoi “finti” autoritratti che smontano gli stereotipi femminili. Non solo sanno di valere, ma sono appunto pronte a rovesciare lo sguardo. Non a farsi guardare. Ma a guardare e, in caso, a giudicare. A riscrivere la storia: Frida Kahlo ricostruisce il suo albero genealogico, con sua madre vestita di bianco ma con il suo feto già in pancia e il cordone ombelicale in vista, che porta dritto a lei. Non a un maschio. Ma a lei, Frida. Non credete che sia una banalità: nello scrivere il mio ultimo libro, sulla Contessa di Castiglione, avevo immaginato di inserire qualche albero genealogico seguendo le linee femminili per mostrare anche quanti figli naturali girassero nell’aristocrazia. Mi sono trovata davanti le solite linee di successione: nonno-padre-figlio. Fuori le donne e i “bastardi”.
La pittrice e il suo modello
La bravissima pittrice Lotte Laserstein (di nuovo: ho fatto le scuole sbagliate io? Perché non la ricordo mai citata), una “Neue Frau”, una donna emancipata, pure ebrea, che dovette rifugiarsi in Svezia per sfuggire al nazismo ma visse abbastanza per avere ragione (1898-1993), non solo si ritrasse con i capelli corti e modi “androgini”, come si continua a scrivere. Ma nel 1929-1930 intitolò un quadro: Ich und mein Modell, Io e il mio modello. Lei è la pittrice, più matura, ovviamente vestita e guarda, ancora una volta, davanti a sé. Lui è giovane, seminudo e la osserva con deferenza. Ruoli invertiti. Ci appaiono ancora irritanti? Pensate come apparissero due secoli fa, quando la Contessa di Castiglione si faceva fotografare i polpacci e i piedi nudi, gonfi. Si gridava alla follia: è pazza. Lo si dice ancora adesso. È pazza perché solo all’apparenza si sta facendo guardare. In realtà guarda. E giudica. E ironizza. E non ha paura. Lo ricordassero ogni tanto anche le ragazze che ammiccano dai selfie, saremmo a cavallo.
(27esimaora, 19 dicembre 2021)
di Samantha De Martin
Dal 5 novembre al 19 aprile alle Gallerie Corsini di Roma – La mostra si potrà visitare, a partire dal 5 novembre, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.
Roma – Un’“architettrice”, vestita con il tradizionale abito della domenica della “middle class romana” del Seicento, tra le mani un compasso e un foglio da disegno, volge il suo sguardo magnetico e assorto agli ospiti delle Gallerie Corsini, come sorpresa dal loro sopraggiungere.
A ritrarla, in un olio su tela in prestito da una collezione privata di Los Angeles, è un pittore attivo a Roma verso la metà del Seicento. La protagonista di questo ritratto, l’unico che abbiamo di lei, è molto probabilmente Plautilla Bricci, artista singolare, ricamatrice, pittrice di talento, esperta ideatrice di apparati effimeri, unico architetto donna dell’Europa preindustriale.
La mostra che le Gallerie Corsini le dedicano fino al 19 aprile più che un percorso espositivo è un’affascinante scoperta che fa luce su un unicum straordinario: un’artista versatile e complessa, autrice di opere pubbliche e pale d’altare, riuscita a ritagliarsi spazi di libertà tra le convenzioni di una società dominata da soli uomini.
Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice, la prima mostra personale dedicata alla pittrice e architetta Plautilla Bricci, a cura di Yuri Primarosa, riunisce per la prima volta l’intera produzione grafica e pittorica dell’artista, costruendo un perfetto allestimento che segue l’evoluzione della donna, da “zitella” invisibile che lavora sotto mentite spoglie, a pittrice “libera”, capace di incantare Roma con i suoi edifici grandiosi.
“Quella che presentiamo oggi – spiega Primarosa – è una mostra di ricerca, destinata ad arricchirsi di nuovi studi e scoperte, un punto di partenza che, per la prima volta, fa conoscere al pubblico un’artista complessa, riunendo solo le opere che sappiamo con sicurezza essere state realizzate da lei”.
Portata di recente all’attenzione del grande pubblico da Melania Mazzucco, autrice del romanzo L’architettrice (Einaudi 2019), Plautilla inaugura anche la riapertura della Galleria Corsini.
“Dopo molti mesi di lavori – commenta Flaminia Gennari Santori, direttrice delle Gallerie Nazionali Barberini e Corsini – siamo felici di riaprire con un’assoluta novità. La Galleria è ora pronta ad accogliere i visitatori con una rete wi-fi, una guida digitale gratuita di supporto alla visita e servizi di accoglienza completamente rinnovati. La nuova illuminazione e gli interventi conservativi sulle decorazioni settecentesche assicurano poi una migliore fruibilità degli spazi”.
L’apoteosi di Plautilla Bricci si compie in mostra attraverso un percorso lineare, ben pensato e che presenta, all’inizio in maniera soffusa, una professionista ancora nascosta, che esploderà solo alla fine del percorso. Come quasi tutte le sue colleghe, anche Plautilla era figlia d’arte e nella bottega romana di suo padre Giovanni acquisì molto di più che i soli rudimenti nel disegno e nel colorire.
Oltre a dipingere insegne di botteghe, muri e tele nell’entourage del Cavalier d’Arpino, il padre era infatti anche un bravo musicista e compositore dilettante, attore e commediante, poligrafo e poeta. Da nuove ricerche si evince che fu proprio Giovanni a offrire alla figlia la prima rete di contatti e committenze, come nel caso della Madonna col Bambino di Santa Maria in Montesanto (1640 circa) – prima opera conosciuta della pittrice – che conserva sul retro la firma dell’artista giovinetta assieme a una relazione che ricorda un evento prodigioso: a ultimare l’opera sarebbe stata la Madonna stessa.
Questo esordio legato a un evento miracoloso garantì a questa artista alle prime armi, destinata a vivere in odore di santità, un posto d’onore nella produzione di immagini devozionali di martiri e sante vergini. Queste occasioni formative consentirono a Plautilla di entrare in contatto con l’abate Elpidio Benedetti, una figura chiave nella vita della pittrice e nel fervido dialogo politico e artistico tra Roma e Parigi, servitore, o se vogliamo “art advisor”, prima del cardinale Giulio Mazzarino e poi di Jean-Baptiste Colbert, nelle funzioni di agente di Luigi XIV.
Elpidio Benedetti fu quasi un alter ego per Mazzarino, sbrigando per lui ogni tipo di mansione, dall’invio di pregiate casse di vino italiano e guanti profumati all’acquisto di palazzi e carrozze. Fu probabilmente lo stesso Benedetti a mediare l’esecuzione dello straordinario ritratto, esposto per la prima volta in questa mostra, che Pietro da Cortona realizzò per celebrare l’ascesa alla porpora del “Cardinale di Francia”, avvenuta nel dicembre del 1641.
Il ritratto, mostrato al pubblico per la prima volta e in prestito da una collezione privata, con il movimento del fazzoletto che ricorda la spuma del mare, il volto del cardinale incorniciato da un ghigno di astuzia e cinismo, rappresenta l’apice della ritrattistica romana di età barocca, reso ancora più interessante dalla penetrante indagine psicologica.
All’inizio Plautilla vive quasi all’ombra di Elpidio Benedetti, al quale sarà unita, fin sul letto di morte, da una straordinaria, devota amicizia. E questo l’incipit del percorso espositivo lo mette bene in luce, affiancando, e quasi sovrapponendo, le opere di Plautilla e quelle del suo committente Benedetti. Tra queste, gli accurati studi grafici del monumento funebre di Giulio Mazzarino, che il cardinale avrebbe desiderato innalzare a Parigi per glorificare la sua memoria e i cui studi grafici formulati da Benedetti assieme a Plautilla furono inviati in Francia nel 1657. L’abate Elpidio aveva diversi motivi per potersi attribuire queste opere. Per realizzare il suo sogno scelse Plautilla, l’unica “invisibile signora” che avrebbe potuto disegnare, ideare e lavorare per lui senza pretendere, nella società maschilista del tempo, di essere riconosciuta.
Dal canto suo, grazie al decisivo sodalizio con Benedetti, la Bricci poté cimentarsi nell’esecuzione di importanti pale d’altare, nell’ideazione di apparati decorativi e nella progettazione di altre opere insigni, affermandosi anche come architetta. Questo evento fu talmente eccezionale da richiedere l’invenzione addirittura di un neologismo, quello di “architettrice”. Di questo titolo si trova traccia su un atto notarile relativo ai lavori della Villa Benedetta fuori Porta San Pancrazio, detta “il Vascello”, la sua opera più famosa, per suggellare, dopo diversi anni di attività sottotraccia, il riconoscimento ufficiale della donna in un settore artistico che la tradizione riservava ai soli uomini.
I lavori per il Vascello ebbero inizio tra il 1662 e il 1663. Purtroppo l’edificio andò distrutto nel 1849 durante l’assedio francese di Roma. Pur avendo preso parte a quel cantiere artisti del calibro di Bernini, Cortona e Grimaldi, fu proprio Plautilla a dirigerne le maestranze.
Tra i progetti dell’architettrice presentati in mostra è possibile ammirare quello, ambizioso, per la scalinata di Trinità dei Monti (1660), o ancora la vasta lunetta dipinta per i Canonici lateranensi (1669-1673) e altre due sue tele conservate a Poggio Mirteto, borgo che diede i natali al padre di Elpidio, Andrea Benedetti, ricamatore papale. Si tratta dello Stendardo della Compagnia della Misericordia raffigurante la nascita e, sul retro, il martirio del Battista (1675) – restaurato per l’occasione e visibile per la prima volta recto e verso – e la Madonna del Rosario (1683-1687). Chiude l’esposizione il quadro d’altare raffigurante San Luigi IX di Francia tra la Storia e la Fede dipinto da Plautilla per la cappella di San Luigi dei Francesi, interamente progettata dall’architettrice per l’abate Benedetti.
Il catalogo che accompagna l’esposizione, stampato da Officina Libraria, contiene i saggi di Yuri Primarosa, curatore della mostra, e di Melania Mazzucco, autrice de L’architettrice, oltre ai contributi di alcuni dei maggiori specialisti dell’artista e del suo contesto culturale, offrendo una nuova e aggiornata monografia sulla pittrice.
(Arte.it, 4 novembre 2021)
di Manuela De Leonardis
Una linea tracciata con il pennello intinto nella vernice bianca unisce i padiglioni 9A e 9B del Mattatoio di Roma, curata da Angel Moya Garcia la mostra personale Conosco un labirinto che è una linea retta (fino al 9 gennaio 2022) – il titolo è una citazione del racconto di Jorge Luis Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius – realizzata in collaborazione con la Reale Accademia di Spagna a Roma, presenta le opere dell’artista spagnola Dora García (Valladolid, 1965, vive e lavora a Oslo) protagonista di numerose mostre d’arte internazionali, tra cui le Biennale di Venezia 2011, 2013 e 2015. Un labirinto visibile, ma anche misterioso, in cui la linea retta – l’ineluttabilità – mette in relazione il film Segunda Vez (2018) con Il labirinto della libertà femminile.
Le «performance delegate» si susseguono: in un cerchio una donna legge poesie di Amelia Rosselli, Anna Achmatova, Alejandra Pizarnik, Mariangela Gualtieri; la Sfinge si aggira ponendo enigmatici quesiti mentre nella lettura della partitura di Lacan l’oratore/ascoltatore si trasforma in lettore/danzatore. Un percorso di perlustrazione dell’inconscio che per il curatore è «un’incessante negoziazione tra colui che parla e colui che ascolta, tra autore e lettore, tra attore e pubblico», in cui viene sovvertito il limite tra la finzione della rappresentazione e la realtà dell’accadimento.
Fanno parte dell’opera «Il labirinto della libertà femminile» le parole «position voice mundo», qual è il loro significato?
L’intera scenografia è basata su un disegno di Gloria Anzaldúa, scrittrice femminista chicana e sulla citazione di queste sue tre parole. Nella mia interpretazione «posizione, voce e mondo» sono la chiave per mostrare la soggettività nell’esercizio dell’indirizzare al mondo la propria voce. Quando preparavo questo lavoro, pensando alla complessità del significato di libertà della donna ed emancipazione – proprio in quanto donna – ho riflettuto su come proprio queste parole di Anzaldúa provenissero da una posizione atipica. Lei stessa si è sempre trovata nel «luogo sbagliato» senza trovare una definizione specifica in cui sentirsi a proprio agio. Del resto penso che sia abbastanza comune la difficoltà di adeguarsi alla definizione di femminilità.
Alla tematica femminista si riferisce il disegno della mano con la moneta dorata proveniente dalla mitologica azteca.
Anche questo è un riferimento che proviene da Anzaldúa. In quanto chicana la cui discendenza indios è precedente a quella dei colonizzatori dell’America, nel libro Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, lei si identifica con la divinità azteca Coyolxauhqui che fu uccisa dal fratello e il suo corpo tagliato a pezzi. In una città del Messico (Templo Mayor a Tenochtitlán, Ndr) è stata ritrovata la sua raffigurazione su una pietra dove venivano svolti riti sacrificali con il sangue. Quello che trovo interessante è l’idea di questo corpo femminile smembrato, dissociato dai canoni occidentali di tenerezza e maternità, messo in relazione con l’idea di ferocia e paura. Quindi la rottura dei canoni di sottomissione da parte di questa donna forte.
Nel rendere il pubblico protagonista dell’opera c’è anche una volontà di farlo partecipare al «disvelamento dell’illusione»?
Sì. C’è un riferimento a Bertolt Brecht che nella storia della performance teatrale ha distrutto gli elementi dell’illusione come forma liberatoria per lo spettatore. Non sono sicura che ciò emerga in questa specifica mostra, ma è stato un riferimento importante per me. Nel teatro borghese lo spettatore è invisibile, al contrario nella tradizione brechtiana è esso stesso parte dell’azione, anzi incoraggia la sua emancipazione nel portare l’esperienza teatrale in una dimensione reale trovando una via liberatoria. Non posso dire di identificarmi con questa visione, ma il tipo di performance che porto avanti negli anni non è mai un intrattenimento ma una durational performance, ovvero un sistema in cui lo spettatore è invitato a prendere parte, ma che va sempre avanti indipendentemente dalla sua presenza o assenza.
Transitorietà, controllo, tempo, ripetizione e precarietà sono elementi molto presenti nel suo lavoro…
Lo sono soprattutto in relazione alla performance La partitura Sinthomo, che si basa sul seminario Le Sinthome di Lacan sugli scritti di James Joyce in cui si parla di «attività precaria» collegata all’instabilità come di qualcosa che mantiene la soggettività sana. Tra le «attività precarie» c’è anche la pratica artistica. Ma anche per me che sono artista non è detto che funzioni ogni volta, è necessario che quest’attività venga praticata quasi in maniera frenetica.
Naturalmente, poi, la pratica artistica include anche la precarietà economica e penso che si riferisca anche alla narrativa, può toccare la poesia, la letteratura e anche ciò di cui sto parlando con te, ovvero quel tipo di costruzione narrativa di storie alla cui luce può essere letta anche questa mostra.
Jacques Lacan è citato anche nel film «Segunda Vez».
Il film parla dello psicoanalista argentino Oscar Masotta che ha avuto diverse vite: a vent’anni era critico letterario, a trenta critico d’arte contemporanea e a quaranta psicoanalista. Nel film queste diverse parti si possono vedere tutte insieme, anche se forse l’accento principale è sulla sua pratica artistica legata alla sua lettura psicoanalitica. Un altro aspetto importante del film è la lettura politica nell’analizzare il ruolo degli intellettuali in contesti di «urgenza politica», come lo sono anche i tempi in cui viviamo.
L’inconscio affiora in tutte le opere. È così?
Qualche giorno fa ho letto una citazione dello psicoanalista argentino Braunstein in cui l’inconscio è definito come ciò che permette all’essere umano comune di diventare poeta, mentre per Lacan è il luogo del linguaggio e per Freud quello degli impulsi. L’inconscio influenza costantemente il visibile e l’invisibile, ma penso soprattutto che sia alla base della pratica artistica. È l’archetipo. Nella poesia dove il linguaggio nasce dal profondo – in generale lo è nella pratica artistica – è anche il modo con cui l’artista parla alla gente.
La sua pratica artistica include la «performance delegata», come l’ha definita la storica dell’arte Claire Bishop.
Fin dai tempi in cui ero studente, in Olanda, pur essendo interessata al linguaggio della performance, ero consapevole di voler rimanere fuori dall’azione. All’epoca il modello principale era Marina Abramović. Ma io odio che la gente mi guardi e mi identifichi come l’artista, la persona eccezionale. Per me l’artista deve essere come tutti gli altri, semplicemente qualcuno che si occupi di arte. Della performance mi piace soprattutto il riscontro immediato, l’idea del qui e ora e di come ciò possa influenzare la realtà e modificare il quotidiano. Ero già interessata al teatro invisibile di Augusto Boal, ma solo nel 2007 ho sentito parlare per la prima volta di «performance delegate». È stato un passaggio molto naturale per me.
(il manifesto, 20 ottobre 2021)
di Anna Toscano
Il tempo restituisce cautamente spazio e forma, voce e luce alla figura e alle opere di Camille Claudel. Se penso alle vicende di questa artista, che visse sempre controvento a cavallo tra Ottocento e Novecento, mi viene in mente una clessidra in cui i granelli di sabbia determinano luci e ombre, anche sulla sua scultura. Dalla nascita, nel 1864, e per la durata di poco più della metà della sua vita la clessidra ha portato luce a una donna che diveniva una grande artista, con uno sforzo immane in un contesto socioculturale che la voleva altro e altrove, ma lei indefessa perseguì la sua passione di vita, la sua arte, i suoi amori, il suo modo di stare nel mondo. E il suo modo di stare nel mondo era contro ogni convenzione, sempre più non tollerato dalla madre e dal fratello, così chiacchierato e sul filo dello scandalo da costringerla a un lento e senza sosta ritiro dalla società per stare nel suo studio, sola, con i suoi gatti. Ma anche questa sua richiesta minima di vita, complice la famiglia che la ostacolava, era troppo alta, anche per lei stessa che iniziava un cammino nella sofferenza mentale. Così, alla morte del padre, nel 1913, che fino ad allora la aveva sostenuta, le sue fatiche e le sue insofferenze fecero sì che la madre facesse aprire per lei le porte del manicomio.
Qui iniziano a scendere i granelli dell’ultima parte della clessidra della vita di Camille, i granelli dell’ombra e del buio, e non sono pochi, quasi trent’anni di manicomio lenti e inesorabilmente reclusi. Non ci fu ascolto per i medici che in questi tre decenni consigliavano il reintegro in famiglia e la ripresa della sua arte, non ci fu ascolto per le innumerevoli lettere di Camille mai recapitate, per ordine della madre, e per le molte lettere a Camille mai ricevute, sempre per ordine della madre. Gli ultimi infiniti anni sono senza voce, muti nonostante le molte parole scritte, e sordi, sordi agli affetti: la madre pare mai si recò a trovarla; con cadenza annuale, per un certo periodo, il fratello. Fino al 1943, il 19 ottobre, un cui l’ultimo granello, così scuro da esser nero, della clessidra si depose sopra a tutti, aveva settantotto anni. Malnutrizione la causa del colpo apoplettico, scrissero i medici. Il buio pervase la grande voce artistica di Camille e la sua opera, nessuno della famiglia si presentò al funerale e nessuno reclamò il corpo che pare giaccia in una fossa comune. Ma la clessidra si è girata, riparte, la sua voce, la sua forza non possono non tornare alla luce: così dopo molti anni di silenzio, granelli scuri si sono succeduti nuovamente per decenni, ecco che tornano quelli chiari, la luce sulla potenza della donna Camille Claudel, donna e artista.
La sua vita in forma anche romanzata è iniziata ad apparire in film, opere teatrali e biografie, e finalmente lo studio della sua opera si è avviato sempre più approfonditamente. Un movimento che inizia in Francia, sua patria, e che man mano interessa molti altri paesi. Oltre all’opera, le sue sculture, inizia la ricerca delle sue parole: la raccolta della corrispondenza esce a Parigi, per Gallimard, nel 2003 a cura di Anne Rivière e Bruno Gaudichon, e in Italia per Abscondita nel 2005 con il titolo Corrispondenza nella traduzione di Monica Martignoni. Di questa opera ho scritto qui nel pezzo dal titolo Camille Claudel e August Rodin: parole come pietre. In quasi vent’anni dalla pubblicazione della corrispondenza la clessidra ha continuato inesorabilmente la sua metà di luce, granelli come tasselli nel ridare corpo e dignità a questa donna. Le pubblicazioni sono continuate ma anche la ricostruzione e riunione di alcune opere. Difatti nel 2017, dopo lunghi assestamenti, a Nogent-Sur-Seine nasce il Museo Camille Claudel. Cittadina a novanta chilometri da Parigi ospitò dal 1876 al 1879 la famiglia Claudel e in quella stessa abitazione ha sede parte del museo. Già a inizio Novecento la città aveva dedicato alla scultura uno spazio, il museo Dubois-Boucher, nel tempo riadattato, saccheggiato durante la guerra e infine chiuso.
Con l’annessione della casa in cui visse la famiglia Claudel e un’importante progettazione aggiuntiva nasce il nuovo spazio museale. Il complesso nell’insieme è di impatto, l’edifico appare un tutt’uno, il nuovo fuso nel vecchio e viceversa, che ricorda molto l’energia della nostra artista verso il futuro. Dalla stazione ferroviaria sono nemmeno quindici minuti a piedi nel centro di una cittadina che appare per lo più vuota, desolata, nel silenzio interrotto solo da alcune auto. Quindici sale portano alla conoscenza e all’approfondimento dell’opera di Claudel con un percorso che presenta la scultura ai tempi dell’artista attraverso sculture di altri autori e video: un interessante excursus sulla scultura negli spazi pubblici, l’opera di Paul Dubois, l’immagine della donna nell’arte in quei decenni, l’allegoria e il mito come moda di raffigurazione, i lavoratori, la scultura nella sfera privata e la raffigurazione del corpo in movimento. La sala numero dieci è lo spazio dedicato all’atelier di Auguste Rodin, luogo di apprendistato e di conoscenza per Camille e nella sala numero undici i fili del destino che incrociano qui, come in una continua reiterazione di epifanie, Camille e Alfred Boucher.
Le ultime quattro sale sono finalmente, è il caso di dirlo, dedicate a Camille: solo a lei. La sua opera di ritrattista, come autrice di La Valse e di L’âge mûr e il mondo che ruota attorno a Persée et la Gorgone. Le opere dell’artista non sono davvero molte, soprattutto se confrontate con quelle degli scultori che la precedono nelle prime undici sale, e anzitutto se si pensa alle opere di lei esposte al Museo Auguste Rodin nel cuore di Parigi. Tuttavia il fatto che in questo museo tutto il percorso sia concentrato sulla collocazione storica dell’opera di Claudel è rilevante. Certo, sarebbe stato importante un museo a Parigi che raccogliesse tutte le sue opere come un mausoleo che contenesse le sue spoglie, come avviene per Rodin, ma di fatto si va a tasselli. Anche le parole di Claudel giunte sino a noi sono aumentate: un fortuito rinvenimento ha permesso una edizione aggiornata del libro Corrispondenze: per Gallimard nel 2014 e poi per Abscondita nel 2020 è uscita una edizione ampliata delle lettere grazie al ritrovamento del carteggio con il critico d’arte belga Léon Gauchez, nella traduzione di Caterina Medici.
Gauchez e Claudel avevano sì un rapporto di lavoro molto professionale ma nelle lettere a lui, così come nella vita dell’artista, il personale fa capolino a ogni riga, coinvolgendo e spostando il mondo artistico nel privato e viceversa. Nonostante per la vita e per l’opera di Camille Claudel i tasselli pare stiano a disposizione del tempo e delle sue beffe, possiamo forse oggi considerare concluso il lavoro della clessidra e iniziare a vedere Camille per quello che è, un’artista atemporale. Noi, umani, non possiamo che cogliere, raccogliere, custodire, studiare e dare voce alla sua opera e alla sua vita, tutta la voce che sino a oggi non ha avuto, scavare quella coltre di silenzio che, per disparati e ignobili motivi, l’hanno lasciata muta. Risarcirla in parte di tutto lo splendore che le è stato sottratto.
(Doppiozero, 3 ottobre 2021)
di Giuseppina Massarelli
Avvicinarmi al culto della Dea ha significato per me stabilire un legame profondo con le antiche culture che la rappresentavano; non solo mi ha incuriosito, ma ha travolto la mia vita. Non voglio scrivere di Marija Gimbutas quanto piuttosto riflettere su come la conoscenza delle sue scoperte sia stata in grado di incidere un segno trasformativo dentro di me.
Marija Gimbutas, archeologa e linguista lituana, ha dedicato l’intera sua vita a mettere insieme testimonianze per far conoscere quella metà di storia taciuta e ha dovuto lottare per farla riconoscere al mondo intero, attraverso le testimonianze trovate andando sempre più indietro nel tempo e attraverso gli scavi sempre più giù nella terra.
Marija Gimbutas ha avuto il grande merito di far notare quanto sia importante ciò che «non è ritratto nell’arte Neolitica», ovvero la mancanza di immagini che idealizzano la potenza armata, il potere basato su crudeltà e violenza; non esistono nell’arte Neolitica immagini di nobili guerrieri o scene di battaglia, sono assenti sontuose sepolture di capitribù e ne ha dedotto che nella storia non ci sono sempre state guerre, intese come momenti di conquiste e sopraffazioni ma ci ha parlato di civiltà che erano in pace. A me piace dire che era un tempo in cui gli uomini e le donne vivevano in armonia con tutte le cose, loro stessi erano natura e le donne in quanto fertili erano riconosciute come superiori, fertili come la terra. Era una struttura sociale pacifica, matrilineare, egualitaria e anche la simbologia religiosa era strettamente connessa al femminile.
La domanda che mi sono fatta, quando sono entrata in contatto con la cultura della Dea grazie agli scritti di Gimbutas, è stata quanta di quella storia fosse rimasta dentro di me, e dentro noi tutte. Avevo sentito sin da subito che le mie cellule richiedevano giustizia. Nelle grotte e nell’umidità nasce la vita, così ci ha insegnato Marija Gimbutas. Per me non era una grotta ma una bottega, fucina d’ingegno e di ricerca; è lì che sono nata creativamente, plasmavo la terra umida e forgiavo oggetti inspirati alla cultura della Daunia, fino a quando i segni geometrici che incidevo sulla terracotta hanno cominciato a risuonare dentro di me, e si sono riempiti di significato quando li ho collegati alla cultura della Dea, comprendendo che i triangoli, le linee ondulate intervallate da foglie, i vortici o le semplici successioni di linee che avevo per anni decorato senza saperne il senso, prendevano corpo e significato, erano segni legati alla vita e alla trasformazione.
Il legame di quella cultura con la terra e le cose viventi era così forte e sacro da riprenderlo sui numerosi manufatti ritrovati, traducendosi in un vero e proprio linguaggio storico. Una scoperta a dir poco magica ha fatto sì che mi si aprisse un mondo e con esso avvenisse la mia trasformazione. Il motivo dominante nell’ideologia e nell’arte dell’antica Europa fa riferimento a un mutamento continuo, a un’energia vitale in costante movimento per la celebrazione della vita; tutto veniva significato su vasi o oggetti di vario ordine e forma, serpenti che strisciano, api e farfalle, spirali e vortici, energia che muove, si rigenera, le colonne della vita, una forma che si dissolve in un’altra, un inno continuo. La vita sulla terra è in continua trasformazione, in costante e ritmico cambiamento dalla creazione alla distruzione, dalla nascita alla morte e la Dea era il simbolo dell’unità di tutte le forme di vita esistenti in Natura in Europa. La simbologia della Dea dominò per tutto il Paleolitico e il Neolitico e nella fase seguente fu soppiantata da popolazioni di invasori arrivate con cavalli e armi. La Dea si ritirò allora nel profondo delle foreste o sulle vette delle montagne, lì sopravvisse fino ai giorni nostri poiché i cicli storici non si fermano mai; ora vediamo riemergere la Dea recandoci speranza per il futuro nel riportarci alle nostre antiche radici umane.
È grazie al lavoro di Marija Gimbutas che abbiamo delle chiavi di lettura di un passato che non ci è stato restituito ma che possiamo riscoprire.
Giuseppina Massarelli è tra le fondatrici del circolo culturale La Merlettaia a Foggia.
(https://vitaminevaganti.com/2021/09/25/marija-gimbutas-il-segno-trasformativo/, 25 settembre 2021)
di redazione Ohga!
Shamsia Hassani è la prima street artist e attivista donna a colorare gli edifici distrutti dai bombardamenti della sua città in Afghanistan. Per le strade di Kabul ha dipinto donne con gli occhi chiusi e senza bocca, ma che continuano, in una società patriarcale che non dà loro una voce, a rincorrere i propri sogni.
Shamsia Hassani, la prima street artist donna afgana, ha deciso di portare la sua arte per le strade di Kabul. Le sue protagoniste sono le donne dell’Afghanistan, ritratte tutte con gli occhi chiusi e senza bocca ma che continuano, in una società patriarcale che non dà loro una voce, a rincorrere i propri sogni.
Shamsia, figlia di rifugiati afgani, è nata in Iran trentatre anni fa e solo nel 2005 ha fatto ritorno nella sua terra. In Afghanistan ha frequentato l’università di belle arti di Kabul, dove adesso detiene la cattedra di scultura. Da sempre affascinata dalla pittura e dal disegno come mezzo di espressione, ha iniziato a sperimentare con i graffiti solo nel 2010. «Voglio usare un muro come tela perché solo così posso condividere il mio lavoro con le persone e introdurli all’arte» – commenta Shamsia in un’intervista per Vice – «perché la maggior parte di loro non ha la possibilità di andare in musei o gallerie».
Le donne di Shamsia vengono ritratte nei loro abiti tradizionali con gli occhi chiusi e senza bocca ma con degli strumenti musicali tra le mani, l’unico modo per poter far sentire ciò che provano. Attraverso loro, l’artista racconta ciò che accade in Afghanistan, spesso sotto gli occhi giudicanti di uomini che non approvano o non capiscono cosa stia facendo. Quasi come in un presagio, poco prima della conquista di Kabul da parte dei Talebani, Shamsia aveva dipinto una donna con un piano tra le braccia, il volto chino e un muro di uomini vestiti di nero dietro di sé. Con il ritorno dei Talebani nel paese, le donne potrebbero perdere quei pochi diritti acquisiti durante gli ultimi vent’anni, come studiare, lavorare o uscire senza dover essere accompagnate da un tutore maschio. Shamsia, in quanto artista, insegnante e donna, ha pensato di dover cancellare le sue tracce anche dai social ma le sue opere, condivise da migliaia di utenti in tutto il mondo, sono diventate virali. Così ha deciso con coraggio di continuare a postarle anche durante i giorni della caduta di Kabul.
Una donna in ginocchio, una intenta a suonare una chitarra e un’altra ancora su uno sfondo macchiato di sangue e poi, infine, una donna che stringe tra le mani la vista da una finestra. Forse è così che Shamsia vuole conservare il ricordo di casa sua che ha dovuto abbandonare per mettersi in salvo. «Carissimi, grazie per i messaggi e per aver pensato a me in questo momento» – scrive in uno dei suoi ultimi post su Instagram – «I vostri messaggi e commenti mostrano che l’umanità e la gentilezza sono ancora vive e non hanno confini. Grazie per il vostro supporto e la vostra preoccupazione, sono al sicuro».
Nascosta chissà dove, grazie ai social, Shamsia continua a raccontare le donne e quella società che le vuole sottomesse nella speranza che possa tornare presto a colorare le macerie della sua città dal vivo. «Voglio colorare i brutti ricordi della guerra e se coloro questi brutti ricordi, allora cancello la guerra dalla mente delle persone» – aveva commentato l’artista in un’intervista per Art Radar nel 2013 – «Forse posso rendere famoso l’Afghanistan per la sua arte, non per la sua guerra».
(Ohga!, www.ohga.it, 2 settembre 2021)
di Glenda Cinquegrana
Per la prima volta alla guida della prossima edizione dell’Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia c’è una donna italiana di profilo internazionale. Classe 1977, milanese, ma newyorchese d’adozione, Cecilia Alemani si è fatta notare con un curriculum di livello internazionale costruito non tanto sulle mostre museali, ma soprattutto su innovativi e poco convenzionali progetti di arte pubblica realizzati prima per la High Line di New York, poi per Frieze Projects di New York, infine Art Basel Cities. Un curriculum eccentrico, che le ha conferito già nel 2017 l’ingresso nella classifica Art Power 100 pubblicata dalla rivista Art Review, che enumera la lista dei più potenti dell’arte contemporanea.
Dal 2011 è curatrice di High Line Art, programma di arte pubblica legato alla High Line, il parco urbano costruito su una ferrovia sopraelevata a New York, che è divenuto il palcoscenico dei lavori site-specific commissionati ad artisti e artiste come El Anatsui, Phyllida Barlow, Carol Bove, Sheila Hicks, Rashid Johnson, Barbara Kruger, Zoe Leonard e Ed Ruscha. Questo progetto di lungo periodo ha creato la sua solida reputazione di curatrice impegnata a sviluppare il dibattito attorno a temi importanti come l’accessibilità dell’opera al pubblico e l’importanza dell’arte come strumento di creazione di consapevolezza per le comunità urbane.
A queste esperienze ha poi unito i brillanti progetti di arte pubblica realizzati per Art Basel – nel 2019 cura la performance di Alessandra Pirici nella piazza open-air della fiera – e la direzione artistica della prima edizione di Art Basel Cities, un complesso progetto di rilancio dell’ecosistema culturale urbano che sotto l’egida del marchio Art Basel ha trovato una primissima partnership di successo con la città di Buenos Aires. In quella occasione prepara una mostra a cielo aperto intitolata “Hopscotch (Il gioco del mondo)” ispirata alle formule combinatorie del capolavoro letterario di Cortázar, in cui presenta diciotto opere in stretto dialogo con i luoghi della città, collegando l’arte visiva, agli spazi urbani e le storie della metropoli in modi inaspettati.
Oltre alle collaborazioni con MoMA PS1 e Tate Modern di Londra, la sua reputazione è imprevedibilmente legata a progetti come No Soul For Sale, il festival di spazi indipendenti, organizzazioni non-profit e collettivi artistici che si è tenuto a X Initiative, spazio per alternativo in cui ha curato mostre di artisti come Keren Cytter, Hans Haacke, Christian Holstad. Il suo profilo combina understatement, brillantezza e sguardo laterale sull’arte. Per capire come si è calata nei nuovi panni di curatrice della cinquantanovesima Biennale l’abbiamo raggiunta in conference call a New York. La Alemani è sorridente, gentilissima; per una curatrice della sua preparazione ha un linguaggio di semplicità disarmante.
«Ricevere l’incarico di curare la più prestigiosa mostra internazionale d’arte contemporanea è una grande soddisfazione e al tempo stesso una grande responsabilità». Le sue parole sono un’allusione al fatto che il suo incarico è passato anche attraverso le forche caudine della pandemia, con il conseguente slittamento del progetto dal 2021 al 2022. La Alemani non è nuova a Venezia, essendo stata curatrice del Padiglione Italia nella Biennale nel 2017: la mostra “Il Mondo Magico”, con Adelita Husni-Bey, Giorgio Andreotta Calò e Roberto Cuoghi, è stata fra le più apprezzate degli ultimi anni. Più che continuità con quel lavoro, sottolinea la natura differente delle due mostre, l’una focalizzata sull’arte italiana, l’altra, specchio della complessa scena artistica internazionale. Il titolo della mostra “Il Latte dei Sogni”, ispirato alla pittrice surrealista Leonora Carrington, prende le mosse da una visione di re-incantesimo del mondo, onirica e femminile.
«La prospettiva femminile è certamente inerente al lavoro della Carrington da cui ho preso le mosse per costruire l’esposizione». Ma sul tema dello sguardo al femminile precisa che «il mio lavoro di curatrice si basa sul supporto agli artisti e alle artiste a prescindere da suddivisioni di genere o da possibili quote rosa». Prosegue spiegandoci i contenuti della mostra. «Oggi il mondo appare diviso tra ottimismo tecnologico, che promette il perfezionamento infinito del corpo umano attraverso la scienza, e lo spettro di una totale presa di controllo da parte delle macchine grazie all’automazione e all’intelligenza artificiale. Questa frattura è stata acuita ulteriormente dalla pandemia del Covid-19. Le ricerche di molti artisti oggi trovano delle risposte al presente celebrando la comunione con il non-umano, con l’animale, e con la terra; altri reagiscono alla dissoluzione di sistemi universali riscoprendo forme di conoscenza locali e nuove dimensioni identitarie». Gli artisti sono lo specchio delle inquietudini e le preoccupazioni del nostro tempo, che ci indicano chi e che cosa possiamo diventare.
(Forbes.it, 12 luglio 2021)
di Franca Fortunato
“Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole”, “ un desiderio di rigenerazione, di respiro, di risveglio”, “con le emergenze, la pandemia e l’isolamento ho sentito l’urgenza di raccogliermi in me stessa per concentrarmi e trovare le risorse per non farmi trascinare in una deriva di bruttura, insensatezza e odio”, “stretta di mano, carezza, bacio tutto scontato poco apprezzato eppure adesso tanto agognato l’abbraccio perduto di un anno passato col volto coperto da un filtro di veli solo uno sguardo smarrito supplica il ritorno al passato ad una vita di incontri per non restare distanti”, “la mia storia mi insegna che la creatività e la ricerca di bellezza sono salvifiche. La bellezza si espande nell’universo, arricchisce e rigenera”, “la natura non chiede permessi per nascere e fiorire”, “la vita non fa salti”, “torneremo a sorridere”, “salviamo il mondo”: sono queste alcune frasi che accompagnano le immagini della mostra di arte postale “Rigenerazione”, curata dalla critica d’arte Katia Ricci e allestita da Rosy Daniello della Merlettaia di Foggia in collaborazione con Le Città Vicine e inaugurata ieri nella sede dell’associazione, in diretta on line. Una mostra legata alla vita, ai sentimenti, ai pensieri, ai sogni, ai desideri, ai bisogni di “rinascenza” del dopo Covid, “di gioia di vivere, nonostante tutto e senza dimenticare il pericolo corso e i lutti”, di cambiamento, di trasformazione di sé e della realtà all’insegna del rispetto per la natura, accoglienza e cura reciproca, per non tornare alla “normalità” del prima ma per “fare sorgere un’aurora foriera di un nuovo e luminoso giorno per la civiltà”. È la natura, rigenerante e rigenerativa, bisognosa di attenzioni, di cure e guarigione, la protagonista della mostra, dove arte, musica e armonia si mescolano alla leggerezza del vivere. Sono cartoline per lo più di donne, spedite da ogni parte d’Italia, dove bellezza e creatività, simbolo di rigenerazione dell’anima, hanno il volto di donna. Donna che si tuffa nel mare e riemerge, donna con una grande rosa sul grembo, donna le cui lacrime riempiono gli oceani, donne che reggono il mondo con la cura e le relazioni umane, unica risorsa generativa di vita e di rinascita. Che cos’è l’arte postale? È una pratica artistica connessa alla vita che viaggia in una busta da città in città, da paese a paese, da continente a continente, tessendo relazioni interpersonali, scambi di pensieri, sentimenti, sensazioni, odori. Nata agli inizi degli anni Sessanta, da artisti desiderosi di fondere l’arte con la vita, ben presto si trasformò in una rete di artisti internazionali e si diffuse anche tra le donne diventando veicolo di consapevolezza della propria identità, del desiderio di significare sé stesse, di diffusione del femminismo. Nel 1975 un gruppo di donne inglesi cominciarono a spedirsi l’un l’altra piccoli lavori artistici attraverso le poste. “Noi cercavamo di unire aspetti apparentemente assai diversi- il privato, il domestico e il personale con il politico e sociale.” Si servivano di materiali poveri, vecchie scatole, abiti e cose riciclabili. L’arte postale è stata uno strumento di sensibilizzazione di lotta e di resistenza in tutti quei paesi dall’America latina a quelli dell’Est in cui vigevano regimi dittatoriali, fino alla sanguinosa guerra nei Balcani. Ha esplorato molte forme creative d’avanguardia: collage di oggetti di uso comune, immagini riciclate, francobolli veri o dipinti, poesie, musiche e immagini di musicisti come quello che nella mostra di Katia Ricci suona col violoncello un inno alla creatività. La bellezza ci salverà? Basta crederci.
(Il Quotidiano del Sud, 18 giugno 2021)
Redazione cultura
Mostre. Nella cornice del festival Brescia Photo, trentacinque sguardi per una statuaria femminile che cambi i connotati degli spazi pubblici
Il festival Brescia Photo si articola quest’anno intorno alla parola Patrimoni. Un argomento che, insieme alla conclusione dei lavori di restauro della Vittoria Alata, ha suggerito al gruppo di autrici dell’Associazione Donne Fotografe una riflessione sulla presenza – in realtà sulla reiterata assenza – della donna nella statuaria monumentale e negli spazi pubblici. Un vuoto che ha attraversato i secoli e «risuona» ancora oggi nelle nostre piazze e giardini. È nata così la mostra Scolpite, promossa dall’Associazione stessa e curata da Paola Riccardi (visitabile fino al 13 giugno a Palazzo Facchi), in cui trentacinque fotografe compongono un mosaico visivo, interpretando il tema con «virtuali memoriali» e seguendo liberamente l’impronta del loro linguaggio.
Così se Tiziana Aris rivisita la Vittoria alata sotto forma di Mater Universalis, dedicandola all’originaria Lucy, Patrizia Bonanzinga sceglie una statua acefala di Palazzo Ducale a Mantova, consegnandole il volto e il corpo di sua madre, ragazza 22enne nel 1946: la data non è casuale perché coincise con il voto femminile e, grazie a questo, con la nascita della Repubblica (l’omaggio è anche alla partigiana Bruna, Lidia Menapace). Antonella Monzoni con Il Sacrificio delle donne armene entra nel Memoriale del ricordo del Genocidio di Erevan, proponendo la scultura situata nel cortile che ritrae le vittime della deportazione.
E mentre Paola Mattioli s’interroga sulle presenze femminili «sacre» ed estreme a Milano, sempre apolidi, sospese tra il cielo e la terra, Melania Messina indaga l’infanzia trasformata in ex voto della Santuzza di Palermo (con un pensiero rivolto a Felicia Impastato). Antonella Gandini nel suo S/colpite riproduce un anonimo ritratto d’epoca, minacciato dall’inserimento di un coltello sulla scena (il riferimento è per Susy, accoltellata a Brescia nel 2020). Simona Filippini affida lo sguardo al corpo libero, che infrange i confini, della ballerina di danza classica e buto Andreana Notaro. E Anna Rosati ritrova una Biancaneve disneyana ma indipendente, principessa che invece di aspettare il tanto chiacchierato risveglio del principe, alza i tacchi ed esce di scena, andandosene per la sua strada.
(il manifesto, 28 maggio 2021)