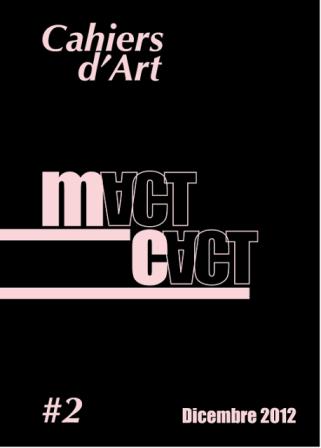Dal 3 maggio al 10 maggio 2013 all’ Associazione Apriti Cielo Via Spallanzani 16 -Milano saranno in mostra opere di Francesca Guffanti per la presentazione del libro “Nessuno te lo dice prima” opera autobiografica di Francesca Guffanti. Un romanzo breve che svela una rete di piccoli soprusi, furbizie, e intrighi ai quali tutte le aspiranti artiste/i si sottopongono, nella spesso vana speranza di ottenere un riconoscimento della propria arte, ed offre altresì uno spiraglio a chi crede caparbiamente nelle proprie doti e nell’altrui buona fede.
Scritta in modo “visuale”, quasi filmico, quest’opera si snoda fra diversi quadri, apparentemente disgiunti fra loro, mantenendo un filo conduttore nel reciproco rapporto di amore-odio fra l’artista ed il curatore, vero e proprio catalizzatore di energie creative.
La scrittura è scorrevole ed il linguaggio discorsivo, caratterizzato da frasi pungenti e talora ironiche.
Francesca Guffanti vive e lavora a Monza, nei pressi di Milano. Dopo la Maturità Classica, ha conseguito la Laurea in Pittura presso la Nuova Accademia di Belle Arti a Milano. Da sempre svolge la sua attività artistica all’interno di realtà private e pubbliche e partecipando a mostre collettive e personali presso musei in Italia e all’estero. Sue opere sono presenti in diverse collezioni private e pubbliche. Parallelamente ha insegnato per diversi anni Disegno e Pittura presso la Civica Scuola d’Arte “F. Faruffini” a Sesto San Giovanni. Tiene seminari e conferenze sulla Percezione Visiva e sul ritratto. Attualmente impartisce lezioni di pittura e acquarello presso il proprio atelier e presso l’associazione Apriti Cielo!
In occasione della presentazione del libro
APRITI CIELO! intende anche organizzare un gruppo di riflessione artistica, rivolto a chi, in prima persona, porta avanti questa pratica per trovare insieme un modo diverso di far agire la propria arte, mettendo a confronto le vecchie e le nuove “contraddizioni”.
Info: info@apriti-cielo.it cell 3498682453
Si inaugura l’ampliamento della collezione con “Piu’ luce su tutto”. L’opera, del 2010, e’ un’installazione composta da 150 libri in vetro illuminati e dipinti a mano, ed e’ stata donata dall’artista e dalla Galleria Marie Laure Fleisch.
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna inaugura, Martedì 23 Aprile alle ore 18.00, l’ampliamento della sua collezione grazie alla donazione dell’opera di Chiara Dynys, Più luce su tutto. L’opera del 2010, un’installazione composta da 150 libri in vetro illuminati e dipinti a mano, è stata donata dall’artista e dalla Galleria Marie Laure Fleisch.
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna dedica alla sua collezione un nuovo spazio esponen- do il lavoro di Chiara Dynys, Più luce su tutto del 2010. L’opera, una libreria di grandezza modulabile per l’ambiente espositivo, è composta da 150 libri in vetro suddivisi in gruppi, alcuni dei quali, illuminati internamente, emanano luce. L’installazione è nata con l’obiettivo di privilegiare le opere su carta alle quali la libreria luminosa dell’artista rimanda. E’stata creata specificamente per la mostra dal titolo omonimo presso la galleria Marie-Laure Fleisch. L’opera trovava il proprio senso in rapporto agli spazi della galleria e rappresentava anche l’approdo concettuale di un percorso espositivo che contemporaneamente si svilup- pava presso l’Archivio Centrale di Stato. Le due mostre complementari Labirinti di memoria e Più luce su tutto intendevano infatti riflettere sui significati di memoria e di oblio, passato e presente, come fattori primi per la determinazione dell’esistenza.
L’opera, donata dall’artista e dalla Galleria Marie Laure Fleisch, rappresenta una libreria i- deale, la costruzione della propria memoria personale, interpretata dall’artista come una raccolta di libri illuminati internamente da luci che ne esaltano i colori dipinti a mano e la trasparenza dei materiali. Nella nuova installazione, Più luce su tutto diventa il collegamento tra la fine del percorso e- spositivo del museo e il bookshop.
Biografia
Chiara Dynys lavora a Milano.Sin dall’inizio della sua attivita’,all inizio degli anni 90 ha agito su due filoni principali, entrambi riconducibili ad un unico atteggiamentonei confronti del reale: identificare nel mondo e nelle forme la presenza e il senso dell’ anomalia , della va- riante, della “soglia”che consente alla mente di passare dalla realta’ umana ad uno scenario quasi metafisico.Per fare questo utilizza materiali apparentemente eclettici, che vanno dalla luce al vetro, agli specchi, alla ceramica, alle fusioni, al tessuto , al video e alla fotografia. Tra le presenze museali ricordiamo la partecipazione in mostre personali e collettive quali : Museo di Saint Etienne , Ciac di Montreal,Kunstmuseum di Bonn, Museo di Bochum, Pac di Milano, Museo Pecci Prato e Milano, Rotonda della Besana Milano, Museo Bilotti, Cen- tro D’arte Italiana a Foligno,Museo Mart di Rovereto , ZKM Karlsruhe e al Museo Poldi Pezzoli Milano e inoltre in importanti galllerie e fondazioni italiane e straniere.
Ufficio stampa tel. +39 06 32298328 , s-gnam.uffstampa@beniculturali.it
Inaugurazione martedì 23 aprile 2013, ore 18.00
Galleria Nazionale d’Arte Moderna – GNAM
viale delle Belle Arti, 131 (Disabili via Gramsci, 71), Roma
Orari: Aperto al pubblico dal 15 Marzo 2013
martedì – domenica dalle 10.30 alle 19.30
(la biglietteria chiude alle 18.45)
Chiusura il lunedì
Biglietti ingresso
intero: euro 12,00
ridotto: euro 9,50 (cittadini dell’unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni ; docenti delle scuole statali dell’Unione Europea)
ridotto speciale solo mostre: euro 7,00
(minori di 18 e maggiori di 65 anni)
gratuito museo: minori di 18 e maggiori di 65 anni
a cura di Achille Bonito Oliva
23 aprile – 24 maggio 2013
La grande mostra “Les magiciens de la terre” inaugurata al Centre Georges Pompidou da Jean-Hubert Martin nel 1989 ha portato alla ribalta internazionale l’arte contemporanea africana.
La mostra presso la Fondazione Mudima, che tra gli altri artisti ne ripresenta due tra quelli “scoperti” da Jean-Hubert Martin (Esther Mahlangu, Seni Camara), attinge agli intensi rapporti che la Fondazione Sarenco ha con le collezioni private di Italia, Francia, Germania, Olanda e Belgio e agli innumerevoli viaggi africani compiuti dall’artista Sarenco in terra d’Africa per quasi trent’anni, alla scoperta di tanti talenti artistici.
Lo sguardo attento di Achille Bonito Oliva ha portato alla selezione di 6 artisti: “tre donne artiste straordinarie, e tre uomini, artisti straordinari. Un bel pareggio in terra d’Africa. Questa mostra fa il punto sulla grande qualità e sull’emozione che procura l’Arte Africana Contemporanea a noi addetti ai lavori e, spero, al pubblico del nostro paese”.
In mostra le sculture di SENI CAMARA (Senegal), MIKIDADI BUSH (Tanzania) e JOHN GOBA (Sierra Leone) e i dipinti di ESTHER MAHLANGU (Sudafrica), GEORGE LILANGA (Tanzania) e MARGARET MAJO (Zimbabwe). Inoltre saranno esposte 4 sculture di circa 4 m di altezza dell’artista SARENCO (Marinetti, Apollinaire, Tzara, Breton) e il lavoro fotografico di PAOLA MATTIOLI e FABRIZIO GARGHETTI su questi stessi artisti africani.
In occasione della mostra sarà presentato il catalogo AFRICANA per le Edizioni Mudima, a cura di Achille Bonito Oliva e Sarenco.
A disposizione del pubblico ci saranno altri due libri collegati alla
mostra stessa: I MIEI EROI AFRICANI di Sarenco e MEMOIRES D’AFRIQUE di
Paola Mattioli e Sarenco.
Il Museion di Bolzano omaggia Rosemarie Trockel con una mostra che ne racconta la complessa personalità. Un percorso sapientemente allestito in cui emerge il piacere di mettersi in gioco. E di mettere in questione l’arte stessa. Dalle sculture escatologiche e barocche ai collages e le installazioni irriverenti. Fino a smentire l’idea dell’ “arte di genere”. Con i celebri lavori a maglia che diventano opere classicamente moderniste [A.P.]
MOSTRA DAL 02/02/13 al 01/05/13
In che cosa può consistere il “piacere sfacciato” per un artista di una certa età (61anni), tenace e precisa (c’è bisogno di dirlo?) come, secondo la vulgata comune, sanno essere gli artisti tedeschi? Un’artista che lavora da sola nel suo studio, senza assistenti, schiva al limite dello scontroso (non ama interviste né presentarsi alle inaugurazioni delle sue mostre), che voleva diventare biologa e che agli animali riserva tuttora un’attenzione particolare (si dice spesso che chi ama molto gli animali ami poco gli umani), tanto inventarsi, con Studio 45: House for Lous, il luogo ideale per i pidocchi: una parrucca. Un’artista discretamente cupa (basta notare la reiterata ossessione per l’immagine della cantina, la porta, le scale che portavano al regno dell’incubo infantile) ma anche inaspettatamente ironica? In che cosa consiste, dunque, “Il piacere sfacciato”, titolo della mostra (“Flagrant Delight”) di Rosemarie Trockel, attualmente di scena al Museion di Bolzano (a cura di Dirk Snauwaert, affiancato nella trasferta italiana da Letizia Ragaglia in collaborazione con la stessa Trockel)? Un piacere che, chiosa la direttrice di Museion, è più che altro «capriccioso, disinvoltamente sfrontato», che non ci si aspetterebbe da un artista del genere.
Ebbene, il piacere (e non è una semplificazione) è proprio quello dell’arte. Proprio di un’artista che, nonostante lunghi anni di carriera, attraversamenti di generi e di linguaggi complessi e articolati (la pittura, l’installazione, la ceramica, la scultura, il collage, il video), mantiene ancora quasi intatta non solo la spinta a sperimentare, ma anche a mettere in gioco tutto. Senza tabù, a cominciare da se stessa. Confrontandosi – attraverso la fluidità di quei linguaggi che interseca e una certa, eccentrica sensualità – con temi tosti, di dimensione apparentemente privata: l’arrogante mondo maschile e quello femminile, in realtà molto pubblico, se è vero, come dicevano le femministe negli anni in cui Trockel comincia a lavorare, che “il privato è politico”.
Ma stiamo all’aspetto più propriamente artistico, e dunque anche a un discorso di genere (il “lavoro al femminile”) con cui Trockel è stata parzialmente identificata: i lavori a maglia, quelli con i fornelli installati (accesi!) come grandi cerchi neo pop su basi monocrome e fissati al muro. Trockel non ricama, in questi lavori, tranne che in un caso, non lascia in vista fili, smarginature, il disordine di un ordito che evoca molto, ma afferma poco. No, lei i lavori a maglia li realizza al computer, ne fa grandi tele cromatiche minimaliste, che da lontano potrebbero essere scambiate per severe campiture realizzate da un Reinhardt o da Ryman: nero, grigio marrone, anche i colori concedono molto poco alla presunta fragile creatività che in genere si rintraccia nelle artiste.
La scelta di Rosemarie è di intervenire sui lavori a maglia con la tecnologia, in polemica (neanche troppo celata) con il primato maschile dell’arte, ed elevandoli alla ormai raggiunta classicità del Modernismo. Stesso approccio nei lavori con i fornelli, intervallati gli uni dagli altri con rigore minimalista, fino a farne evidenti “quadri” modernisti e con questo, direi, liquidare anche una certa idea di genere dell’arte.
Ma non basta. Queste opere apparentemente pittoriche sono in realtà delle installazioni messe a parete, con cui l’artista sovverte anche le tradizionali distinzioni (anche qui c’è di mezzo una questione di genere) tra pittura e installazione. Spiega Letizia Ragaglia: «Rosemarie Trockel affronta un discorso sulla pittura, riguardo un certo compiacimento verso questo linguaggio e su che cos’è la pittura, atteggiamento che si ritrova anche in alcuni suoi dipinti più recenti». All’apparenza sciatti (e non solo all’apparenza) realizzati con colori, ma anche con fluidi femminili. Opere quindi desacralizzate o, all’inverso, che consacrano questi fluidi. Così come, nobilitate, sono i “quadri” realizzati da alcune scimmie che «le pongono di nuovo serie domande sullo statuto della pittura e dell’artista», aggiunge Ragaglia. Non capricci, quindi, ma statement in cui emerge una schietta rivendicazione politica, della parte dove stare: l’insofferenza verso i linguaggi accreditati. Un’interrogazione quasi ontologica dell’arte, come del senso dello stare al mondo.
Ma poiché Rosemarie Trockel non ama le retrospettive, a parte qualche vecchio lavoro degli anni Ottanta, tra cui la versione di uno dei suoi temi ricorrenti, Keller (cantina), con le ragnatele che creano un ordito quasi fitto ma al contempo leggero, in mostra a Museion ci sono molti collages (la produzione più recente, realizzati, detto per inciso, non tradizionalmente con la colla, ma a secco e pinzati) che raccontano l’immaginario complesso, tetro e irriverente insieme, “sfacciato”, a volte al limite del cattivo gusto, come quando i collages sono decorati con striscioline argentate che li trasformano in cabinet de curiosités molto kitsch, di questa artista che si nutre programmaticamente del lavoro di altri artisti, così come di letteratura, cinema, filosofia. E molti dei suoi mentori compaiono nei collage.
Chissà se Francis Bacon apprezzerebbe l’essere rappresentato con un occhio solo alla Polifemo (ma potrebbe trattarsi del terzo occhio degli induisti, l’occhio della mente) e la cinta di un accappatoio di spugna a mo’di capelli, il tutto incorniciato da quei festosi lustrini argentati? E, a proposito di pittura e di quella un po’ pompier che ha celebrato e soprattutto usato l’attraente nudità del corpo femminile, ecco che in un collage compare L’Origine du monde, con una vistosa vedova nera che copre il pube. Mentre, in un altro collage che utilizza questa icona della pittura erotica, Raymond Pettibon presta il suo busto a quella parte del corpo che Courbet non dipinse.
E chissà anche come la prenderebbe Robert Smithson vedendo trasformata l’utopia sublime della sua Spyral Jetty in Spyral Betty: installazione luminosa che ritrae (alla maniera eccentrica di Trockel, ovviamente) l’apparato genitale femminile, opera peraltro entrata in collezione di Museion.
Ma non è che Rosemarie Trockel dileggi i suoi colleghi. Tutt’altro. I suoi punti fermi rimangono inalterati in Fontana in testa a tutti, che omaggia con alcuni lavori a maglia con tagli, Richard Hamilton, da cui deve aver preso un certo gusto per la composizione spiazzante dell’opera, Beuys, con cui condivide l’idea della metafora artistica, Gilbert & Gorge.
Ma poi Trockel va oltre. E si cimenta nella scultura realizzando delle ceramiche che incarnano un’escatologia barocca, dove l’idea del rifiuto organico si mischia a un’accesa e visionaria idea del corpo che, in una sintesi ardita, dichiara l’avversione verso il consumismo e i suoi rituali. Da qui, alle opere che raccontano il suo sguardo obliquo attraverso la condizione umana: altre sculture parziali di corpi, la “casa dei pidocchi”, immagini altrettanto parziali e apparentemente strampalate di altre porzioni di corpo che compaiono nei collages, si compie il percorso di questa artista complessa e irrituale che l’allestimento del Museion di Bolzano riesce sapientemente a mettere in scena.
Milano – dal 18 aprile al 15 giugno 2013
MUSEO PECCI MILANO
Ripa Di Porta Ticinese 113 (20143)
A cura di Angela Madesani, Annamaria Maggi, Stefano Pezzato
Realizzato dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
in collaborazione con Galleria Fumagalli e Spazioborgogno
Opere di: Marina Abramovic, Vito Acconci, Vincenzo Agnetti, Giovanni Anselmo, Eleanor Antin, Gabor Attalai, Michael Badura, Dobroslaw Baginski, John Baldessari, Gianfranco Baruchello, Bill Beckley, Joseph Beuys, Günther Brus, Cioni Carpi, Giuseppe Chiari, Giorgio Ciam, James Collins, Roger Cuthfort, Fernando De Filippi, Giuseppe Desiato, Gino De Dominicis, Valie Export, Joachen Gerz, Gilbert & George, Dan Graham, Al Hansen, John Hilliard, Peter Hutchinson, Joan Jonas, Birgit Jürgenssen, Allan Kaprow, Jürgen Klauke, Robert Kleine, Ketty La Rocca,Urs Lüthi,Roberto Malquori, Fabio Mauri, Bruce Mc Lean, Ana Mendieta, Charlotte Moormann, Maurizio Nannucci, Bruce Nauman, Hermann Nitsch, Luigi Ontani, Roman Opalka, Dennis Oppenheim, Gina Pane, Giuseppe Penone,Vettor Pisani, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini, Arnulf Rainer, Cindy Sherman, Rudolf Schwarzkogler, Helmut Schweizer, Stelarc, Aldo Tagliaferro, Franco Vaccari, Francesca Woodman, Michele Zaza.
La mostra costituisce un progetto di ricostruzione storica che raccoglie le sperimentazioni con il corpo e sul corpo effettuate dall’ultima avanguardia artistica del XX secolo, proponendo un insieme significativo di fotografie, film e documenti dei maggiori esponenti della stagione eroica dell’Azionismo, della Body Art e della Performance: analisi linguistiche, riflessioni di matrice antropologica, sociale, plastica. Nella maggior parte dei casi si tratta di lavori di taglio autobiografico dove gli artisti sono anche i protagonisti delle opere.
Una sorta di rivoluzione, all’interno dell’arte, forse l’ultima avanguardia appunto, che parte dall’America e si diffonde in Europa con una certa velocità, dal 1965 al 1980.
Nonostante la Body Art svolga un ruolo determinante all’interno della grande mostra, non tutti gli artisti presenti sono collocabili in questo ambito, un esempio per tutti è quello di Gilbert & George, i quali utilizzano le loro persone per un’indagine più ampia, di matrice linguistica, mediatica, non ascrivibile a nessun ambito artistico particolare. La rassegna offre una rilettura trasversale di quel fondamentale periodo storico artistico, ponendo in relazione tra loro opere assai diverse – solo in taluni casi apparentemente simili – partendo da documenti storici e di studio già esistenti.
Accanto alla parte squisitamente fotografica in mostra sarà anche una zona dedicata al cinema d’artista e ai primi esperimenti della ricerca video, oltre a una parte documentaria, costituita da cataloghi, libri, inviti, e manifesti.
Un’indagine ad ampio spettro attraverso alcuni grandi protagonisti, internazionalmente riconosciuti, ma anche attraverso alcune figure artistiche da riscoprire, alle quali offrire finalmente una giusta collocazione.
da Exibart
Per l’ottavo appuntamento veneziano, Marinella Paderni dialoga con Francesca Grilli, artista “espatriata” in Olanda. Lei e la scelta della performance sono al centro dell’incontro
Sin dagli albori del tuo lavoro nel 2005, giovanissima, hai esordito con la performance quando questo linguaggio non era ancora tornato all’attenzione delle istituzioni museali e della curatela internazionale. Ci racconti la genesi di questa scelta controcorrente e che cosa porta nel tuo lavoro la pratica performativa?
«C’è un Arcano Maggiore chiamato ‘Ruota della Fortuna’, in questa carta si sottolinea il movimento rotatorio e vorticoso della sua superficie e la stabilità del suo centro. Prendo questo come esempio per cercare di riflettere sul significato di corrente, che paragono alla superficie della Ruota della Fortuna e il controcorrente che è il suo centro. Essere controcorrente è semplicemente essere veri con sé stessi. Quando vi è una chiamata, una visione che spinge per prendere forma, un’urgenza espressiva, non può essere ignorata, altrimenti non si e’ fedeli a sé stessi, al proprio centro: questa riflessione è stata per me l’accettazione della performance. La performance è entrata nella mia vita come una necessità, umana e personale prima di tutto. Ora ne ho fatto mio linguaggio, realtà espressiva attraverso la quale mi viene spontaneo esprimere la primordialità e la forza della mia ricerca artistica. Le correnti vanno e vengono, la Ruota può girare in un senso o nell’altro, ma bisogna essere lungimiranti e credere nelle proprie visioni, prendersi le proprie responsabilità, a discapito di quello che ti accade intorno».
Tutta la tua ricerca artistica è pervasa da alcune tematiche centrali collegate all’identità, al tempo, al linguaggio del corpo e alla resistenza dei limiti. Come li hai declinati e sviluppati nei tuoi lavori?
«Credo ad una ricerca incessante della propria verità, che si sfiora solo attraverso un incredibile sforzo, fisico, mentale. Questa fatica non è tuttavia fine a se stessa, ma profondamente appagante, ne si intravedono i confini proprio grazie alla spinta del suo limite, laddove inizia la trasformazione, la liberazione di se stessi per tramutarsi in altro. È proprio sul limite, sul punto di massimo sforzo, che si intravede un’immagine altra, di svelamento, di massima fragilità, di verità. Penso alla performance Enduring Midnight, dove la cantante lirica ormai in una fase conclusiva della sua carriera, cantando ancora nel mezzo della notte, ci rivela se stessa, la sua forza più intima, la sua passione più vorace. È un’immagine che va al di la della bellezza, ma che contiene l’unicità e la forza di esistere, nonostante tutto».
La voce e la musica sono altri due leit motiv presenti nella maggior parte delle tue opere. Esprimono ciò che l’arte visiva cerca oggi incessantemente, dare forma a emozioni e realtà spesso imponderabili come la passione. Che significati rivestono all’interno della tua ricerca?
«La manifestazione, più che la rappresentazione, mi ha sempre conturbata. Cerco quindi di riportare nelle mie opere, proprio questo aspetto. Il suono è immateriale, ma riesce a comporre, dare una voce ai sentimenti, plasmare la materia di cui siamo fatti, senza necessariamente avvalersi di una forma specifica».
In un’epoca contraddistinta dalla smaterializzazione del reale e dall’egemonia dei dispositivi virtuali nella relazione con l’altro, come interpreti la tendenza artistica attuale alla ricerca di “esperienze” in cui la presenza fisica e diretta è messa in gioco e rinegoziata?
«Annuso nell’aria un cambiamento, profondo, nel presente. Spesso le arti contemporanee sono state algide e inaccessibili. La presenza della relazione, dell’emotività era quasi penalizzante. Per quanto mi riguarda vi era un grave scollamento tra umano ed espressione artistica, una mia preoccupazione che questa dimostrazione di distanza e distacco, fosse invece lo specchio proprio di un’umanità persa, imbambolata e inaccessibile. Mi sembra invece che il sangue sia tornato ad intiepidirsi, non ancora a bollire, ma a risvegliarsi. Di conseguenza l’esperienza ci scuote, non ci lascia impassibili, ci cambia. E si ritorna al gesto semplice, all’urgenza di seguire quell’urlo che ci ha risvegliato».
Ora che la performance è tornata ad essere un linguaggio espressivo particolarmente consono alla giovane ricerca internazionale, cosa puoi leggere in controluce del tuo apporto, di quasi un decennio, al rinnovamento di questa pratica?
«Mi auguro per le generazioni a venire, che abbiano le fortune e le difficoltà necessarie per poter scavare il letto del loro fiume. Perseguire l’arte performativa significa accettare i limiti dei mondi che ti possono ospitare, le arti visive, il teatro di ricerca, e cercare appunto di solcare la propria strada. Auguro loro di non farsi abbagliare dalla buona o dalla cattiva sorte, ma di cercare una propria posizione solida, che spesso corrisponde ad una sedia scomoda».
Ci sono delle difficoltà nell’essere un’artista performativa rispetto al circuito delle gallerie? La performance è un’opera d’arte difficile da collezionare, soprattutto in Italia, e talvolta difficile anche da esibire nei musei: penso alla tua bellissima performance Moth (2009) che hai potuto mostrare solo all’interno di teatri, e non nei musei, a causa di una burocrazia rigida in materia di sicurezza. Per alcuni tuoi lavori, ti è stato più semplice operare all’interno del teatro sperimentale d’avanguardia?
«Il teatro sperimentale e’ più versatile quando si tratta di ospitare linguaggi che possono sfociare in diverse forme, anche tecnicamente rischiose. Per altre caratteristiche invece ha una sua rigidità, temporale soprattutto. Tecnicamente alcune performance hanno effettivamente sofferto a causa della loro complessità e pericolosità di esecuzione, ma proprio questi due ingredienti sono la loro forza, non avrei potuto evitare di fare diversamente. L’esistenza di queste modalità espressive sempre più presenti nei linguaggi artistici, che prevedono azioni in vita, vanno a scardinare la staticità museale, suggerendo nuovi formati. Mi sento comunque fortunata, per il supporto che ho avuto alla mia ricerca performativa, talvolta difficile da comunicare al sistema, ma questa e’ un’esperienza personale, non una modalità».
La chiamata al Padiglione Italiano della 55° Biennale di Venezia è stata preceduta da una residenza presso il MACRO di Roma per il quale hai prodotto l’installazione sonora Variazioni per voce (2012). Com’è nata l’opera? E in che relazione si pone con la residenza romana?
«Sono stata felice di ritornare in Italia proprio in occasione di questa residenza. Ho colto l’opportunità per riascoltare l’Italia. Attraverso Variazioni per voce, ho potuto riflettere sul concetto di censura dell’opera e dell’espressione artistica, individuando un importante concetto che sta alla base del presente del nostro Paese, la responsabilità, verso noi stessi, verso l’opera d’arte. Lo spettatore era invitato a scegliere se attivare l’installazione, consapevole della possibilità di distruzione della medesima: ad ogni ascolto la mia voce incisa su cera, si consumava, modificando e cancellando l’opera stessa».
L’invito a partecipare alla 55° Biennale di Venezia ti ha posto di fronte ad una nuova, importante sfida. Come stai vivendo questo momento e cosa ti aspetti da quest’esperienza?
«Mi sono isolata sulle montagne trentine, gentilmente ospitata da Centrale Fies. Ci rimango tre mesi. Stare attaccata alla terra mi fa bene in questo momento. Cerco di fare un lavoro che mi rispecchi, che non mi tradisca».
CARDEDU. La celebre artista Maria Lai si è spenta all’età di 93 anni, nella sua casa nelle campagne di Cardedu, circondata dall’affetto dei suoi cari.
A Ulassai l’8 luglio del 2006 l’artista aveva inaugurato il museo di arte contemporanea la “Stazione dell’arte”, che raccoglie una parte considerevole (circa 140) delle sue opere. Grazie anche alle esposizioni negli Stati Uniti e in altre prestigiose manifestazioni europee, Maria Lai è considerata una delle artiste più importanti della storia sarda.
Il documentario pubblicato sul sito Sardegna Digital Library “Un’ora con Maria Lai”
ASSOCIAZIONE APRITI CIELO
Presenta:
DOPPIO GIOCO
Francesca Gagliardi e Andrea Mazzacavallo
a cura di Alessandra Piolotto
con intervento di Francesca Contini
Inaugurazione
Venerdì 22 Marzo dalle ore 19.00
22 marzo – 13 aprile 2013
DOPPIO GIOCO nasce dall’idea di lavorare sul concetto linguistico del doppio, che richiede la disponibilità all’imprevisto, a seguire un percorso verso l’idea di una mobilità di pensiero. E’ l’esercizio del dubbio e la messa in discussione del pregiudizio, il tutto attraverso lo specifico lavoro di due artisti che hanno in comune l’ironia e il gioco, utilizzando il linguaggio visivo pittorico e plastico di Francesca Gagliardi, quello performativo, musicale e di scrittura delle narrazioni di Andrea Mazzacavallo.
Fare un lavoro sul doppio significa destrutturare dei pensieri cristallizzati, innescare un gioco virtuoso e potenzialmente infinito. Questo processo conduce alla molteplicità di significati, all’accettazione di uno scarto semantico all’interno di un’archivio di accezioni. La realtà è molteplice e proteiforme. E’ qui che la comicità svolge un ruolo sottile, si basa spesso sul doppio, su un meccanismo che permette di svelare, smascherare e di rovesciare la realtà.
Per Francesca Gagliardi quando il simbolo oltrepassa la sua dimensione, invadendo materiali, contesti e colori che lo svuotano persino della sua stessa funzionalità, non può che manifestarsi in tutta la sua potenza tragicomica, col più disarmante dei sorrisi.
Sensibilità e rigore d’indagine hanno trovato in lei la giusta armonia per esprimere una lettura sarcastica delle forme nella duplice accezione di arma di seduzione – arma di difesa dei rossetti-pallottole.
Andrea Mazzacavallo ci introduce nel regno della Sorpresa. Un “viaggio comico-economico per stare bene” fitto di racconti, brani musicali, idee originali che danzano giocose sulla fune dell’ironia.
Lo spettacolo “Ticket” nasce dall’esigenza di mescolare la canzone, nelle sue variegate forme stilistiche, con il linguaggio della comicità e del racconto. Si tratta di uno show divertente, di un recital in cui il pianoforte e la chitarra si alternano alla recitazione per dar vita ad una sorta di “microfilm”.
Alesssandra Piolotto
Apriti Cielo – Via Spallanzani 6 – 20129 Milano
e-mail: info@apriti-cielo.it
orario: dal lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00
la terza settimana su appuntamento : mob. +39 349-8682453
FRANCESCA GAGLIARDI
vive e lavora ad Ameno. Nel 2000 si diploma in Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Brera
Tra le mostre: nel 2012 partecipa alla collettiva Icubarte a Valencia, Artista invita Artista (centro d’arte Villa Eugeni,a Valencia, 2011), Gallery Artist & Guests (Michele Balmelli Gallery, Lugano, 2011); Gallery Collection vol.1 (galleria41artecontemporanea,Torino, 2010) Lapizlabioli (palazzina Ciani, Lugano, 2009) con un testo di Fernando Arrabal; Blues de mon rouge à lèvres, (galleria Alexandre Mottier, Ginevra, 2007), Je m’oublie oblie-moi (Galleria 41 artecontemporanea, Torino, 2007); partecipa al manifesto dalla natura itinerante ‘Ospite Inatteso’, scritto da Alessandra Piolotto, nato da una strategia alternativa dell’abitare. Con partenza ad Ameno (2010), poi Torino (2010) e Buenos Aires (2011).
La ricerca dell’artista Francesca Gagliardi parte dal disegno e segue un percorso che dall’incisione la porta alla scultura, utilizzando la cera, il bronzo e la ceramica.
ANDREA MAZZACAVALLO
comincia all’età di 9 anni i suoi studi musicali, prima sul pianoforte e poi sul canto. Nel 1995 vince il Premio dedicato a Demetrio Stratos Cantare la voce. Nel 2000 pubblica il suo primo album con il quale partecipa a Sanremo 2000 con al canzone Nord-Est classificandosi ultimo. Due mesi dopo si laurea in Storia e Filosofia con una tesi dal titolo Gioco di simulazione e conoscenza umana presso l’Università di Bologna. Nel 2002 pubblica un secondo album intitolato Low-fi relativo ad una produzione di teatro comico. Nel 2003 partecipa al festival della musica uzbeka a Taskent. Dal 2000 svolge l’attività di insegnante di sperimentazione vocale e pianoforte a Bologna, alternandosi come autore di colonne sonore per teatro, televisione e cinema. Nel 2006 vince il Leoncino d’oro alla Biennale teatro di Venezia con la colonna sonora dello spettacolo di Carlo Gozzi Il Corvo. Nel 2007 tiene un seminario sulla Musica e vocalità nella Commedia dell’arte presso L’Università coreana di Seoul. Lo stesso anno firma la colonna sonora dello spettacolo scritto da Tiziano Scarpa L’ultima casa che vince il premio Chi è di scena alla Biennale di Venezia. Nel 2008 realizza la musica dello spettacolo di circo-teatro Cirk per la regia dell’olandese Ted Keijser. Nel dicembre del 2009 firma la regia i testi e la musica di otto cortometraggi per il Premio Nazionale del Lavoro in onda su Rai 1. Nel 2010 pubblica il suo primo testo letterario “Ticket” da cui è tratto l’omonimo spettacolo teatrale.
presso ATELIER GIORGI
via Belfiore 5H, Torino
a cura di NOI 8.3
Le serate del 19 marzo e 16 aprile prevedono la presentazione di
artiste che in qualche modo si sono confrontate, su suggerimento di
NOI 8.3, con la lettura del Manifesto di Rivolta Femminile.* Durante
gli incontri, oltre a presentare il loro lavoro, le artiste
racconteranno al pubblico le loro opere e la loro esperienza con le
tematiche proposte da NOI 8.3.
*Il Manifesto di Rivolta femminile del 1970 è l’atto costitutivo del
gruppo omonimo. Scritto da Carla Lonzi con Carla Accardi e Elvira
Banotti, il “manifesto” contiene in nuce tutti gli argomenti d’analisi
che il femminismo avrebbe fatto propri: l’attestazione e l’orgoglio
della differenza contro la rivendicazione dell’uguaglianza, il rifiuto
della complementarietà delle donne in qualsiasi ambito della vita, la
critica verso l’istituto del matrimonio, il riconoscimento del lavoro
delle donne come lavoro produttivo e non ultimo la centralità del
corpo e la rivendicazione di una sessualità autonoma svincolata dalle
richieste maschili.
PROGRAMMA
19 MARZO
ORE 21
francesca arri (video) / manuela macco (performance)
ORE 22
Incontro/dibattito con le artiste
16 APRILE
ORE 21
valentina murabito (fotografia) / erika fortunato/linda rigotti (performance)
ORE 22
Incontro/dibattito con le artiste
presso ATELIER GIORGI
via Belfiore 5H, Torino
INGRESSO a OFFERTA LIBERA per sostenere le iniziative di NOI 8.3
GRADITA PRENOTAZIONE POSTI LIMITATI
Info e prenotazioni: noiottopuntotre@yahoo.it
338.58.10.572
n o i 8 . 3
Mes concitoyennes, ne serait-il pas temps qu’il se fît aussi parmi
nous une révolution? Les femmes seront-elles toujours isolées les unes
des autres, et ne feront-elles jamais corps avec la société, que pour
médire de leur sexe, et faire pitié à l’autre?
[Olympe de Gouges, 1788]
La galleria Kaufmann Repetto è lieta di presentare la mostra collettiva Revolution from Within, con la quale si intende rafforzare l’attenzione che negli anni la galleria ha mostrato verso artiste donne.
Negli spazi dell’intera galleria saranno esposti i lavori di 12 artiste di generazioni e provenienze diverse, con l’intento di tracciare una mappatura dell’identità femminile, in opposizione ad una tendenza dalle radici storiche profonde, che vede una marginalizzazione della donna all’interno del sistema dell’arte.
In questo senso, Revolution from Within (dal titolo dell’omonimo saggio di Gloria Steinem), è intesa come un’attitudine inclusiva di tutte quelle specificità proprie della sfera femminile, spesso segregate a una posizione subordinata e a uno status di alterità.
La mostra vuole esplorare lo spazio di sovrapposizione di categorie all’apparenza inconciliabili, come femminismo e femminilità, la sfera politica e quella estetica, l’ambito domestico e quello collettivo.
L’attivismo può allora convivere con un ornamentalismo portato alle sue conseguenze estreme, come nel lavoro di Andrea Bowers; la sfera più morbosamente privata, come una chat erotica, diventa l’oggetto del lavoro di Frances Stark, che svelando la sua sfera più intima ci porta a riflettere su complessi meccanismi umani e sociali.
L’autorappresentazione della donna passa attraverso l’immagine di una pila di edizioni dello Scum Manifesto di Valerie Solana, come nel caso di Anne Collier, o nella ricontestualizzazione di oggetti smaccatamente femminili, come il tegame-organismo per Yayoi Kusama e il tacco che diventa arma, protesi o pene per Birgit Juergenssen. Quest’ultima in particolare, come altre artiste in mostra, ha saputo coniugare femminilità e femminismo, concependo già negli anni ‘70 un’immagine di donna che trae forza dai propri contrasti.
La fragilità e l’effimero sono messi al centro della scena, come nel lavoro di Nina Canell, o in quello di Ketuta Alexi-Meskhishvili. Ruvidità e delicatezza si incontrano nelle stampe digitali di Marieta Chirulescu, come nei lavori e nelle performances di Lucy Dodd. La scultura di Lutz Bacher è un enorme fegato ma ammicca allo spettatore e si crede un organo sessuale.
Di contro, il ritratto della mascolinità rivela debolezze su cui poter sorridere: i Bad Boys of Harvard di Maria Loboda sono un gruppo di piante in vaso che, come una gang di cattivi ragazzi, si sposta nello spazio ostacolando il passaggio. Gli uomini rappresentati da Goshka Macuga sono body builders circondati da una natura che li soverchia o sonnolenti militanti del Tea Party.
Al di là della specificità di ciascun’artista, la mostra descrive nuove possibilità di conciliazione e piccole ribellioni quotidiane, attraverso il confronto tra voci di donne che hanno avuto la forza di mostrare le proprie debolezze.
Inaugurazione giovedì 7 febbraio ore 19.00
Galleria Kaufmann Repetto
via Di Porta Tenaglia, 7 Milano
Orario:
da martedì a venerdì ore 11-19.30
sabato ore 14-19.30
DAL 7 AL 10 FEBBRAIO 2013
“Sailing away to Paint the Sea”
Un diario di bordo dipinto a mano. Così si può descrivere il lavoro dell’artista Vittoria Chierici (vittoria-chierici.com, o sunymaritime.edu) Sailing away to Paint the Sea – in italiano Voglio viaggiare su una nave per dipingere il mare.
Vittoria da anni con un piede in Italia ed uno a New York, si è “imbarcata” in un’avventura davvero insolita lo scorso anno, quando ha deciso di navigare da Amsterdam (Olanda) a Cleveland (Ohio) su di una nave trasporto merci – Isolda, per descrivere l’esperienza del viaggio in mare attraverso l’arte. La pittrice, che ha studiato a Bologna dove si è laureata al Dams nel 1979, ha continuato ad arricchire la sua preparazione a New York, presso la Columbia University ed alla School of Visual Arts dove ha studiato fotografia, video e pittura.
Negli anni ’90 ha completato gli studi artistici con un biennio di produzione cinematografica alla New York Film Academy. I quadri della sua ultima collezione cento in tutto, esprimono la grande potenza del viaggio, del mare e del movimento. L’intento della sua esperienza che ha unito navigazione e arte è stato appunto quello di comunicare la forza della natura e anche la sua irrazionalità. La incontriamo per un caffè nel centro di New York, lei arriva carica di entusiasmo e con una borsa contenente dei pezzi della sua collezione, che ci mostra durante l’intervista.
«Il mio mezzo espressivo migliore è la pittura ma non mi definisco un’artista. Ho studiato sto storia dell’arte in Italia ma ho sempre desiderato dipingere fin da bambina, come un gioco. Poi dopo la laurea ho deciso di prendere dei corsi qui a New York in “visual art”. Ho iniziato con la fotografia e poi ho continuato con la pittura». Quando le chiedo del suo ultimo progetto, Vittoria non esita un istante, prende la borsa e ci mostra un pezzo della sua collezione. Il quadro che ci fa vedere è un omaggio al pittore francese Gustave Courbet, «è un personaggio che ho studiato prima di partire, molto affascinante», le chiediamo quindi la tecnica utilizzata «utilizzo fotografie stampate e poi riportate su tela. Ogni tela viene dipinta o montata su di una tavoletta. Volevo utilizzare il supporto in legno, per dare l’idea del diario di bordo. Se guardi dietro poi c’è un’etichetta che cita edizione speciale perché i quadri sono stati venduti prima di partire».
Proprio così, Vittoria è riuscita a finanziare il progetto grazie ai sostenitori – 85 divisi tra l’America e l’Italia – che hanno creduto in lei ed acquistato le opere prima della partenza. La mostra si sposterà in Italia a marzo, presso i Frigoriferi Milanesi (Mi). In quell’occasione, le opere saranno portate via a poco a poco durante la settimana e la mostra verrà “smontata” quindi, dai compratori stessi. Originale lo è davvero in tutto Vittoria, alla quale chiediamo anche, affascinati, come è stato navigare così a lungo ed una sua giornata tipo in mare. «Il progetto è nato nell’estate del 2011, non avevo fondi ma volevo fortemente fare questa esperienza. Così alla cieca, nessuno sapeva come sarebbero venuti i quadri, alcune persone hanno creduto in me e finanziato il progetto» – continua – «ho scelto il tragitto dall’Olanda all’Ohio perché innanzitutto volevo tornare in America su di una nave e non su di un aereo e poi perché ci sono tre forme di acqua: l’oceano, il fiume e il lago. Tre percorsi importanti e diversissimi». Così ci racconta come si è imbarcata, col suo studio portatile, una valigia con pennelli e tavolozza, due telecamere e una macchina fotografica. «La nave ha dei ritmi ben precisi, poi essendo un’imbarcazione cargo eravamo solamente quattro passeggeri più l’equipaggio. Un canadese giramondo, una ragazza olandese di 20 anni in cerca dell’American Dream ed un altro viaggiatore belga. Mi alzavo presto la mattina e come prima cosa facevo delle riprese sul ponte, ore e ore di filmati del mare e di tutto quello che ci circondava».
Il suo lavoro si svolgeva a poppa, su di un tavolinetto di legno ribattezzato “il tavolo del pirata” perché come spiega Vittoria, era pieno di incisioni e scritte di marinai che erano stati su Isolda prima di lei.
«Lì ho dipinto, guardando il mare, ma non volevo copiarlo, in realtà io non lo imitavo affatto. Mi sono ispirata alla rabbia, mia e del mare. Perché abbiamo avuto su 14 giorni di navigazione ininterrotta, almeno una settimana di mare mosso. A me piace molto, soprattutto perché da l’idea del movimento che io volevo catturare, dato dalla direzione delle onde, del vento. Il mare era forza 8 quando eravamo a largo dell’isola di Shirley, la barca si inclinava anche di 15 gradi. Adoravo quelle situazioni. Dipingevo soprattutto in quei momenti, cercando di coprirmi perché tirava un vento fortissimo, la mia idea era capire e rappresentare la rabbia del mare. L’acqua ha un movimento scientificamente studiato, ma è talmente casuale quello che poi noi vediamo, che mi affascina perché c’è una base scientifica e poi il caos».
Ci racconta poi come è stata la navigazione nell’Oceano Atlantico. «Non vedi niente per giorni, solo la linea curva della terra. Quando stavamo andando verso Terranova ho persino pianto. Per me l’Oceano rappresentava finalmente la stabilità. Mi trovavo su una nave – che è come una grande madre, perché è protettiva – però attorno avevo una sensazione di spazio infinito, dove non c’è costa e quindi neanche responsabilità. Non devi arrivare da nessuna parte. Puoi rimanere lì senza avere per forza una destinazione finale».
a cura di Manuela Gandini
La Nuova Galleria Morone presenta “Tracce di un dio distratto”, la personale milanese di Maria Lai, curata da Manuela Gandini.
Nata nel 1919 a Ulassai (Ogliastra), allieva di Arturo Martini e Alberto Viani all’Accademia di Belle Arti di Venezia, Lai – in tempi nei quali le artiste non viaggiavano e non godevano della credibilità del sistema dell’arte – sperimenta nuovi materiali, s’addentra nella poesia della terra e crea mondi fatti di stoffe, di fili, di pane, di legno, di tela.
Dagli gli anni Sessanta in poi, Lai ha un grande successo ma le sta stretto. Negli anni Ottanta torna in Sardegna per liberarsi dalla mondanità. Ha bisogno di spazio, di vento, di pietre e solitudine. Il suo lavoro si nutre di legami ancestrali con l’isola e di una inesauribile “ansia di infinito”.
“L’uomo – scrive Maria – ha bisogno di mettere insieme il visibile e l’invisibile perciò elabora fiabe miti, leggende, feste, canti, arte”. Partendo dalla semplicità delle cose, sentendo i battiti del pianeta, l’artista tesse geografie che si sfilacciano, planisferi bui pieni di stelle, mondi sopra e sotto di noi con meridiani e paralleli che disorientano e rimangono incompiuti come la vita.
Crea libri di stoffa, nei quali sono scritte parole illeggibili, con fili che si intricano ed escono come cascate dalle pagine, oppure illustra, con leggerezza e dedizione, leggende sepolte nell’inconscio collettivo facendole rifiorire. A Ulassai realizza opere ambientali, di land art, con l’obiettivo di legare il quotidiano all’Universo e l’asprezza del territorio alla dolcezza della poesia, perciò – tra le altre opere – trasforma una scarpata in una superficie fatta di frammenti specchianti che portano il cielo in terra.
Suo padre le soleva dire: “sei una capretta ansiosa di precipizi”. Usando la tradizione femminile sarda del cucito, del telaio, della famiglia, delle storie delle janas (le fate), Lai sovverte i punti di vista, non è addomesticabile e, con garbo, rovescia le convenzioni riflettendosi ogni giorno nella vastità dell’altrove.
Inaugurazione giovedì 7 febbraio ore 18.00
Nuova Galleria Morone
via Nerino, 3 20123 Milano
Orario: dal martedì al sabato 11 – 19
She Got Love
Castello di Rivoli
Museo d’arte contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia
10098 Rivoli (TO) – Italy
A cura di Beatrice Merz e Olga Gambari
Dal 30 gennaio prossimo nei suggestivi spazi della Manica Lunga sarà allestita la rassegna Ana Mendieta. She Got Love, prima grande retrospettiva europea dedicata all’artista cubana. Il progetto, a cura di Beatrice Merz e Olga Gambari, si propone di rileggere la figura dell’artista come modello e icona per la performance e il video, la body art e la fotografia, la land art, l’autoritratto e la scultura. Nel lavoro di Mendieta (1948 – 1985) confluiscono, infatti, tutte queste componenti, linguaggi coniugati in un personalissimo alfabeto visionario e materico, magico e poetico, politico e progressista che aspirano a raccontare l’identità femminile a partire dalle radici culturali cubane dell’artista sino ad arrivare alla donna contemporanea. Nel suo lavoro esplora temi come l’individuo, i generi, la morte e la vita, la violenza e l’amore, il sesso, la rinascita, lo sradicamento, sempre trascendendoli, però, in un’organicità che si fa spirituale. Il suo corpo si mimetizza nella Natura, in una ricerca delle origini personali e collettive, con una volontà di ricongiungimento a un’eterna e universale energia cosmica, dove elemento umano, naturale e divino convivono. L’orizzonte concettuale e ideologico che ruota attorno alla figura femminile intesa non come fine a se stessa, ma come lente attraverso cui osservare la vita, muove da una fisicità carnale, impastata nella terra e nella natura, nella protocultura, per elevarsi alla spiritualità dell’essere, passando attraverso l’esperienza quotidiana. Segno inconfondibile delle sue opere è, infatti, una caratteristica silhouette femminile, un autoritratto essenziale realizzato in terra, fango, piume, fiori, foglie, cenere, polvere da sparo, rami, alberi, conchiglie, erba, ghiaccio, roccia, cera, corteccia, muschio, sabbia, sangue, acqua, fuoco.
Nel vissuto di Mendieta compaiono diversi luoghi, da Cuba agli Stati Uniti, dal Messico all’Italia, punti tra i quali l’artista era riuscita a tessere relazioni e scambi su canali alternativi.
Ogni performance dell’artista sarà presentata come una tappa, un ambiente profondo e avvolgente raccontato con video, schizzi, fotografie e documenti che creano un momento di grande condivisione emotiva da parte del pubblico, l’ingresso mentale ma anche fisico in un luogo.
In occasione della retrospettiva sarà pubblicato per i tipi di Skira un esaustivo catalogo con testi dei curatori, apparati bio-bibliografici e una ricca selezione di immagini. Durante tutto il periodo della mostra verrà proiettato un documentario sul periodo romano dell’artista.
La mostra è realizzata in stretta collaborazione con l’Estate of Ana Mendieta.
L’artista Vera Comploj apre il ciclo 2013 della Project Room di Museion, lo spazio dedicato a progetti nuovi, creati per l’occasione o inediti, con una particolare attenzione al territorio.
A Museion Comploj (Bolzano, 1983) presenta il progetto inedito “In Between”: una serie di scatti in bianco e nero e un video che ritraggono le drag queen di New York, Washington e San Francisco nel backstage in cui si preparano prima di andare in scena. La mostra è parte di un progetto più ampio, iniziato dall’artista nel 2009, poco dopo il suo trasferimento a New York.
“In Between”, letteralmente “tra”. Come suggerisce il titolo, l’interesse di Comploj è focalizzato su quel momento di passaggio, di transizione tra uomo e donna, realtà e finzione, vita ordinaria e palcoscenico che caratterizza la vita delle drag queen. Il suo obiettivo è entrato tra i camerini, i corridoi e le stanze private in cui le regine della notte si preparano per entrare in scena. Le immagini rappresentano tuttavia solo il momento finale dell’incontro tra l’artista, la persona ritratta e il suo mondo.
Le drag queen scelte da Comploj sono quelle dei circuiti più “periferici”, lontani dal mero glamour. Negli scatti i bagliori del mondo di tulle e paillettes, trucchi perfetti, acconciature accurate e abiti fascinosi, convivono con gli interni di stanze anguste, prese in affitto nei bar dove spesso le queen si esibiscono. È normale allora che a una gonna frusciante con il logo Chanel facciano da sfondo scaffali di carta igienica. O che una foto scattata in atteggiamento da diva, ma in accappatoio, riveli una brandina sfatta. Questo contrasto si riflette anche sulle scelte compositive. Immagini e tagli studiati interagiscono con la casualità del momento: a ritratti frontali si alternano volti e corpi tagliati, o ripresi da prospettive decentrate.
I soggetti rappresentati dall’artista sono diversi, ogni foto una storia diversa. Fa eccezione il video, che ha come protagonista Tiara, cinquantenne asiatica di Singapore, mentre mette in scena davanti alla telecamera una danza tipica indonesiana, sua terra di origine. Il montaggio del video è costituito da un continuo passaggio tra bianco e nero, trucco e volto scoperto, tra l’immagine di corpo fermo e movimenti sensuali.
Con il suo lavoro Vera Comploj si avvicina alla tradizione fotografica che tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta ha indagato la rappresentazione del corpo, le questioni di gender e l’orientamento sessuale – si pensi al lavoro di fotografi come Peter Hujar, Mark Morrisroe o alla stessa Nan Goldin, presente in collezione Museion. Il racconto di Vera Comploj, pur mantenendo la ricerca sull’identità attraverso i processi di trasformazione, risulta però più esterno e distanziato rispetto alla tradizione che l’ha preceduta.
La sera dell’inaugurazione si svolge un artist talk tra Vera Comploj e Ilaria Bonacossa, curatrice del Museo di Arte Comporanea Villa Croce a Genova.
In occasione della mostra di Vera Comploj viene pubblicato un quaderno con un testo di Ilaria Bonacossa edito da Museion (ita/dt/ eng).
Vera Comploj (Bolzano, 1983), vive e lavora a New York, USA. È stata finalista del concorso americano New Exposure, un premio dedicato ai nuovi talenti della fotografia di moda organizzato da Vogue US/ Bottega Veneta/ RED Camera. Mostre (selezione): 2012: Vogue’s New Exposure, Milk Gallery, New York; Be Hospitable, The Souvenir Collective, Liverpool Biennial, Liverpool; 2009: Biennale GenovaARTE, Satura art gallery, Genova; 2008: 08 Bauer, CFP Bauer, Milano.
Ufficio stampa Museion
caterina.longo@museion.it
Caterina Longo t. +39 0471 223428
Inaugurazione: 24.01.2013, ore 19.30
Museion
via Dante, 6 Bolzano
mercoledì a venerdì 10-22 sabato, domenica e martedì: 10-18. Lunedi chiuso
Ingresso libero
Nicola Davide Angerame
È probabilmente la direttrice di fiera più longeva. Dal 1997 in sella ad Art Brussels, Karen Renders sorride gentile e soddisfatta di questa nuova edizione, che non sembra conoscere la crisi. Nel Paese che è stato per un anno senza governo, e che ora vanta un primo ministro di origini italiane, si vende arte e si fa cultura. E le gallerie fanno a gara per esserci. Anche quelle italiane, aumentate in modo significativo. Meno politica e più cultura del collezionismo: questa è la formula con cui Renders da quindici anni vince le sue sfide.
Art Brussels compie trent’anni…
In realtà ne ha 45 ed è la più anziana d’Europa. Nasceva nel 1968 con una edizione ogni due o tre anni, da gallerie appassionate che facevano arte quasi come un hobby. La formula prevedeva che ogni galleria belga invitasse una galleria straniera.
Poi sei arrivata tu, nel 1997.
Nel ’97 c’erano 6o gallerie e circa 4mila visitatori. Oggi siamo 182 gallerie e 30mila visitatori circa.
Un’evoluzione che rende la fiera una tua creazione…
Si può dire così, forse, anche perché da allora la mia priorità è esclusivamente il suo successo.
Cos’è accaduto in questi anni? Bruxelles è cambiata, ora arrivano anche i parigini…
Adesso tutti ne parlano. È divertente perché i parigini ci sono già da qualche anno, ma questa volta ne parlano tutti, per via delle elezioni in Francia la settimana prossima…
È comunque un fenomeno in crescita.
Per la fiera è un ritorno all’origine, visto che era franco-belga. Le gallerie organizzatrici erano molto legate a Parigi.
È vero che chi di loro si stabilisce qui è solitamente ricco e collezionista?
Penso che sia il nostro punto di vista, ma credo che ve ne siano anche di non collezionisti.
Uno dei trend di Bruxelles è aprire la propria collezione, come fa Maison Particulière.
Quindici anni fa era difficile accedere alle collezioni private, poi gli Stati Uniti hanno lanciato la moda. Noi ci dicevamo: in Belgio non si riuscirà mai. E invece eccoci qui, i belgi aprono le loro collezioni.
La migliore qual è?
Vanhaernts, un museo privato visitabile anche fuori dal periodo di fiera.
Che ruolo deve avere Art Brussels?
Aprire il mondo dell’arte verso l’esterno. Ci dicono che siamo elitisti, che l’arte è per i ricchi. Ma non è vero. La fiera deve avvicinare l’arte contemporanea a un pubblico più ampio.
La fiera è più un mercato o un museo?
L’obiettivo primario è il mercato, le gallerie sono qui per vendere. Il secondo obiettivo, di cui il pubblico deve approfittare, è offrire una panoramica sull’arte contemporanea prodotta oggi a livello internazionale.
Rapporto con le istituzioni. In Italia si tagliano i finanziamenti. Qui come funziona?
I musei belgi non sono viziati dallo Stato. Ve ne sono pochi nelle altre città e a Bruxelles ne manca uno dedito al contemporaneo. Wiels è un centro d’arte e il Bozar è multidisciplinare. Con tutti i collezionisti che abbiamo in Belgio, spero che ciò cambierà.
Per contro, la fiera mette in rete quelli che esistono in Belgio.
Da dieci anni lavoriamo con i musei a Ostenda, Gand, Anversa, Charleroi. Vi portiamo i collezionisti in visita, ma quest’anno non abbiamo il tempo, ci sono troppe cose a Bruxelles.
La città di Bruxelles non è un main sponsor…
No, ma si lavora insieme. Mette un budget di 100mila euro per fare l’esposizione di sculture in città e comprarne una.
Come va il rapporto con i privati?
Sono più che sponsor, sono partner: organizzano esposizioni in fiera, come ING, o application e premi, come Blegacom.
Sei stata la prima a creare un comitato di collezionisti: come va con loro?
Abbiamo un legame molto forte. Credo che un organizzatore di fiera debba conoscere il mercato, ma anche saper ascoltare le gallerie e i collezionisti. Questi non hanno potere sulla fiera, ma sono considerati.
Cosa fanno in pratica?
Sono ambasciatori della fiera nel mondo: invitano i loro amici collezionisti e ci aiutano ad accoglierli come si deve. Organizzano cene bellissime. Ci incontriamo regolarmente durante l’anno, discutiamo del mercato, scambiamo idee. Loro decretano il migliore solo show della fiera.
Vieni in Italia per visitare le fiere?
Bologna non riesco a vederla, ma ogni anno visito Artissima, di cui siamo anche partner. Credo che sia comparabile ad Art Brussels e trovo che facciano un buon lavoro. È in un periodo difficile, perché arriva dopo tutte le grandi fiere d’autunno.
Che novità presenti quest’anno?
Apriamo le porte di nuove collezioni private, inauguriamo l’apertura notturna della fiera. Alle sculture in città si aggiungono i “video in city”.
In Italia, la politica è spesso main sponsor. Voi che relazioni avete?
Da noi no, la politica non sostiene davvero l’arte; sta cominciando e io faccio molti sforzi, ma la città non sostiene la fiera. Parliamo e cerchiamo di sviluppare idee, ma non ci sono sussidi cospicui. Il grande vantaggio è che la politica non è d’impaccio e noi operiamo in piena libertà.
E non hai problemi di budget?
Problemi di budget? Sempre! Devo combattere per realizzare tutto quel che vorrei e, credimi, vorrei fare molto di più.
Più che un serio problema di budget, questo mi pare un “piccolo” limite ai tuoi progetti sempre più ambiziosi…
Ecco, esattamente…
Voi qui non sentite la crisi?
La crisi è ovunque, ma per fortuna non ha ancora attaccato il mondo dell’arte.
In Belgio, forse…
Per ora siamo molto contenti.
La crisi influenzerà le prossime edizioni?
Oggi l’arte è riconosciuta come un valore alternativo alle Borse, ma quel tipo di arte finisce nelle case d’aste. Art Brussels è ancora molto vicina agli artisti e all’arte nascente.
Che profilo hanno i collezionisti di Art Brussels?
È il profilo tipico del collezionista belga, di un conoscitore che vuole scoprire il nuovo e che è davvero appassionato d’arte.
E gli italiani?
Vorrei poter accoglierne di più.
Entrambe le mostre sono dedicate alle opere giovanili della Sherman.
L’opera giovanile di Cindy Sherman
Cindy Sherman inizia a studiare pittura alla State University College di Buffalo nel 1972, all’età di 18 anni. Nel 1975 abbandona la pittura per dedicarsi alla fotografia. Nell’estate del 1976 conclude gli studi e l’anno successivo lascia Buffalo per trasferirsi a New York. Contrariamente a quanto si pensava finora, i suoi primi lavori non sono i famosi Untitled Film Stills (1977-1980); a Buffalo, infatti, tra il 1975 e il 1977 sono nate numerose opere che costituiscono il fondamento della sua produzione artistica successiva.
Sherman si avvicina alle correnti artistiche contemporanee allo Hallwall Contemporary Arts Center, centro espositivo autogestito da artisti, fondato nel novembre 1974 dal suo amico Robert Longo e da Charles Clough. Poiché il centro ospitava molti visiting artists, ella conobbe tra l’altro Vito Acconci, Bruce Nauman e Chris Burden e alcune artiste che per lei furono senza dubbio un esempio. Lynda Benglis, Hannah Wilke, Adrian Piper, Eleanor Antin e Suzy Lake erano – come dice Sherman stessa – „role models“, poichè usavano nell’arte il proprio corpo femminile. I lavori giovanili dell’artista sono stati certamente influenzati dalle forme espressive che stavano emergendo all’inizio degli anni Settanta: il film, il video, la fotografia, l’installazione, la performance, l’arte concettuale e la body art.
L’opera giovanile di Cindy Sherman può essere suddivisa in tre fasi. Nella prima l’artista si dedica al ritratto: ricorrendo al trucco e alla mimica, nel 1975 realizza alcune serie fotografiche che la ritraggono con il volto trasformato. Le foto Untitled (Growing Up)rappresentano i cambiamenti della fisionomia di una bambina che diventa una ragazza e affrontano il tema del processo dell’adolescenza. La seconda fase inizia quando la performance coinvolge tutto il corpo dell’artista. Sherman fotografa se stessa in diversi ruoli e pose, assumendo differenti identità, e poi ritaglia le figure dalle fotografie (cut-out). Nascono così il film Doll Clothes(1975) e vari lavori in cui i cut-out vengono sovrapposti e allineati. Nella terza fase Sherman fa interagire diversi personaggi (caratteri), come nelle serie di cut-out A Play of Selves, Bus Riders e Murder Mystery (tutte del 1976).
A Play of Selves, in cui vi sono 244 personaggi e 72 scene distribuite in quattro atti e un finale, è un’opera teatrale complessa. L’artista mediante caratteri diversi (ad esempio la follia, il desiderio, la vanità, la sofferenza, la donna affranta, l’amante ideale) vi rappresenta il variegato e ambivalente mondo interiore femminile. Nella serie Murder Mystery, con circa 211 cut-out e 80 scene, Sherman costruisce un racconto giallo dal finale incerto, in cui ella interpreta vari ruoli, tra l’altro quello dell’amante geloso, del maggiordomo, della madre e del detective. Entrambe le serie hanno una struttura complessa e seguono uno storyboard raffinato: le singole figure assumono dimensioni diverse a seconda della scena. Il numero delle scene è determinato dallo spazio espositivo disponibile; Sherman le applica direttamente sulle pareti ad altezza d’occhio, creando in tal modo una grande installazione.
La complessa opera giovanile di Cindy Sherman è frutto di un processo creativo concettuale e performativo. A causa del carattere effimero dell’esposizione, molti cut-out, come per esempio i Bus Riders, sono andati persi. Negli anni trascorsi a Buffalo, Sherman per la prima volta eleva il gioco della metamorfosi a progetto artistico e realizza numerose fotografie, fino ad oggi inedite, che riuniscono in sé molti elementi del teatro e del cinema. Da più di 35 anni l’artista interpreta e reinterpreta una tutta l’ampia varietà di ruoli e di identità femminili.
Due giorni a Cosenza insieme a Tania Bruguera. Dopo il workshop, parte il weekend dedicato alla performance per il neonato festival VIVA. Otto artisti internazionali, per una Calabria che non si ferma. Abbiamo intervista la curatrice Cristiana Perrella per farci spiegare il progetto nei dettagli.
Scritto da Giovanni Viceconte
Mentre tutti gli operatori del mondo dell’arte si chiedono cosa fare in un periodo di crisi così profonda e caotica, la Regione Calabria ha le idee chiare e investe 3,5 milioni di euro di fondi europei per finanziare sette progetti – della durata biennale – dedicati all’arte contemporanea.
Fra di essi il VIVA Performance Lab, che vede il Maxxi invitato dal Comune di Cosenza come partner del progetto. Curato da Cristiana Perrella e dall’artista performer cubana Tania Bruguera, Viva vede come partner anche l’UNICAL – Università della Calabria e coinvolge il Comune di Altomonte, piccolo paesino del cosentino, che si distingue per il suo ricco patrimonio artistico e per le numerose attività artistiche-culturali.
L’evento di Cosenza è caratterizzato da un workshop – per otto giovani artisti, selezionati da un bando internazionale – partito sabato 1° dicembre, che si conclude alla vigilia dell’apertura del festival, che interessa tutta la cittadina l’8 e 9 dicembre.
Al festival della performance partecipa, insieme agli otto big invitati (Minerva Cuevas, Francesca Grilli, Núria Güell, Aníbal López, Yoshua Okón, Adrian Paci e Cesare Pietroiusti), anche Tania Bruguera, con un progetto inedito legato al territorio e alle sue problematiche, che si annuncia capace di coinvolgere non solo del pubblico presente al festival, ma l’intero territorio calabrese e non solo. Abbiamo rivolto alcune domande a Cristiana Perrella alla vigilia del festival.
Cristiana Perrella
Come si sviluppa il progetto e come mai la scelta della Bruguera per il festival di Cosenza?
Il progetto si articola in varie attività, di cui il festival è il culmine. La formazione è uno dei suoi focus principali, con il coinvolgimento di studenti delle superiori e universitari in una serie di laboratori e in un ciclo di lezioni sulla storia della performance, che mirano a rendere familiare ai più giovani questo modo di espressione artistica e a formare dei mediatori “peer to peer” che saranno coinvolti nel festival. C’è stato poi un workshop per artisti under 35, tenuto da Tania Bruguera, durante il quale i partecipanti hanno lavorato a un progetto di performance che sarà parte dell’evento finale e che vedrà la partecipazione, accanto ai giovani artisti, di otto artisti internazionali, alcuni già molto affermati, altri più giovani ma già con un lavoro definito e forte. Li accomuna l’interesse per l’azione nello spazio pubblico, che metta in discussione i codici che ordinano la nostra società: codici culturali, economici, comportamentali, politico-sociali.
La scelta di invitare Tania a co-curare questo progetto è stata in tal senso naturale: è una degli artisti che maggiormente ha lavorato a mettere l’arte a confronto con la realtà e che ha fatto dell’insegnamento e del rapporto con le generazioni più giovani un elemento organico e fondamentale della sua pratica artistica.
Questo festival è stato finanziato grazie al bando di 3,5 milioni di euro, dell’Unione Europea attraverso il Por 2007/2013 della Regione Calabria, per la realizzazione di eventi d’arte contemporanea. Quanto di concreto e tangibile un finanziamento così cospicuo e il Festival offrono al territorio?
Credo che l’efficacia di un investimento così straordinario sull’arte contemporanea, soprattutto in tempi come quelli che viviamo, dipenda molto dalla capacità di coordinare i vari progetti che vengono realizzati, di metterli in rete e di proporli insieme, favorendo sinergie e comunicazione, evitando le dispersioni di energie e cercando di lasciare segni duraturi, strutture che possano continuare ad esistere anche dopo l’esaurirsi dei finanziamenti.
Il festival nelle due edizioni che saranno realizzate grazie al finanziamento europeo vuole radicarsi il più possibile nel territorio, vuole coinvolgere, stimolare consapevolezza, fornire competenze, dare inizio ad un format che possa poi esser continuato anche in futuro.
Il workshop ha coinvolto alcuni giovani artisti, selezionati attraverso un bando pubblico internazionale. Chi sono e come si sviluppa il workshop?
Gli artisti sono MaraM (Napoli, 1979), Alessandro Fonte e Shawnette Poe (Polistena –RC, 1984; Varsavia, 1980), Luca Pucci (Assisi, 1984), Franco Ariaudo (Cuneo, 1979), Ioana Paun (Cluj-Napoca, 1984), Diego Cibelli (Napoli, 1987), Leonardo Zaccone – (Roma, 1978) Letizia Calori (Bologna, 1986) & Violette Maillard (Bourg La Reine, 1984). Il workshop si è sviluppato in un’alternanza di momenti di discussione individuale e collettiva dei progetti proposti dai partecipanti per il festival e di fasi dedicate alla produzione.
I giovani artisti in che modo si relazionano con gli artisti internazionali invitati al festival?
Il festival non ha gerarchie, il lavoro degli artisti giovani è presentato insieme a quello dei più affermati. Per Tania e per me è stato un punto molto importante unire tutti i lavori nel momento finale, portare anche i progetti più acerbi a poter dialogare alla pari con quelli più strutturati. Nella scelta degli artisti da invitare al festival abbiamo privilegiato quelli che avessero un interesse nell’insegnamento in modo da poter mettere più facilmente la loro esperienza in dialogo con il gruppo dei partecipanti al laboratorio. Yoshua Okon, ad esempio, ha avuto un ruolo importante per i più giovani.
Tra l’8 e il 9 dicembre nel centro storico di Cosenza otto artisti internazionali si confronteranno sul tema della performance. In che modo e quanto un festival dedicato alla performance può coinvolgere un pubblico come quello cosentino, poco abituato ai linguaggi dell’arte contemporanea?
Per la sua natura ibrida, che incorpora tante forme di espressione diverse, la sua tendenza a cancellare i confini tra diversi campi della cultura e l’impatto spesso molto forte e diretto, la performance credo sia la pratica artistica più adatta ad avvicinare e interessare un pubblico fatto di molti studenti e giovani, come quello cosentino, a suscitare una risposta e un dialogo rispetto a quanto verrà presentato da VIVA. La performance è una forma d’arte che esce dagli spazi deputati e si confronta con la vita quotidiana, con la realtà, che cerca le reazioni di un pubblico non necessariamente informato sui linguaggi dell’arte contemporanea.
In che misura le numerose attività legate al festival sono state recepite e hanno interessato gli artisti residenti, l’Università e i suoi studenti, gli operatori culturali e le scuole della cittadina Bruzia?
Finora abbiamo avuto una risposta entusiasmante soprattutto da parte dei più giovani, i ragazzi delle scuole superiori, che si sono incuriositi e hanno partecipato alle attività con grande attenzione. Anche le associazioni culturali cosentine, coinvolte con un forum di progettazione culturale e messe in contatto con Trans Europe Halles, la più importante rete europea di associazionismo, hanno risposto con grande partecipazione.
Cosa ci offre di diverso rispetto ad altri festival VIVA | Performance Lab?
L’interesse a preparare il terreno , a far sì che un evento del genere non giunga come un’invasione aliena sul territorio ma venga accolto con consapevolezza e partecipazione.
Qualche anticipazione sul programma del 2013.
Il programma del prossimo anno cercherà un rapporto ancora più stretto con il territorio.
Vorrei concludere questa intervista con una tuo pensiero sul ruolo della performance nella società creativa contemporanea.
Agiamo in un particolare momento storico in cui è richiesta una presa di coscienza della crisi del sistema sociale, prima che economico, in cui abbiamo vissuto finora ed energia rivolta al cambiamento. La performance, almeno nell’accezione con cui la presentiamo a Cosenza, è un linguaggio che manifesta un intenso interesse ad esser parte attiva della società, a guardare alla realtà con più consapevolezza. E questo mi sembra qualcosa di cui c’è molto bisogno.
Giovanni Viceconte
Cosenza // 8-9 dicembre 2012
VIVA | Performance Lab
a cura di Tania Bruguera e Cristiana Perrella
artisti: Tania Bruguera, Minerva Cuevas, Francesca Grilli, Núria Güell, Aníbal López, Yoshua Okón, Adrian Paci, Cesare Pietroiusti
www.facebook.com/VIVA.PerformanceLab
Emanuele Trevi
Tra le varie zone in cui si suddivide il centro storico di Roma, le lunghe strade che uniscono via della Lungara alle pendici del Gianicolo, dominate dalla mole del carcere di Regina Coeli, hanno conservato un’atmosfera d’altri tempi, silenziosa e trasognata. Pochi i negozi, pochi i passanti, e anche il rumore che dovrebbe provenire dal traffico che scorre senza tregua lungo il Tevere si riduce a un mormorio remoto e indistinto. Da molti anni Giosetta Fioroni lavora al centro di questa strana isola urbana, in un grande studio che possiede la scabra eleganza di una vecchia officina di riparazioni. Ma al termine di una breve scala, si accede a un bellissimo e inaspettato giardino pensile, con terra sufficiente a farci crescere un melograno. Dall’altra parte della strada, incombe un raggio del vecchio carcere.
A poche settimane dal suo ottantesimo compleanno (il 24 dicembre), Giosetta Fioroni è l’esatto contrario di un’artista serenamente appagata da quello che ha fatto. Ha custodito in sé la fiammella dell’inquietudine e dell’esperimento che forse, di tutte le componenti dell’ispirazione, è la più fragile e insieme la più preziosa. E dire che due anni fa Germano Celant ha dedicato ai suoi dipinti una splendida monografia (edita da Skira), un vero e proprio monumento critico, di quelli che si possono dire definitivi. Eppure, non c’è monumento, non c’è riconoscimento che potrebbe mettere Giosetta al riparo dalla suprema tentazione: che è pur sempre quella di rimettere tutto in gioco, affrontando le nuove idee con la trepidazione dell’esordiente. Questo accade quando si vive la propria carriera come una fiaba, un percorso iniziatico, un sogno. Più che un itinerario rettilineo, una specie di spirale dove le illuminazioni improvvise e i sussulti del cuore contano più di ogni continuità. «Il fatto è — mi dice con l’aria un po’ incerta di chi confessi un peccato invece di enunciare una poetica — che alla mia bella età, invece di accontentarmi di ciò che sono, ho cominciato a covare in me una serie di immagini, che corrispondono ad altrettanti ritratti di ciò che sarei potuta essere, o diventare. Una galleria di identità alternative, o di aspetti di me inespressi, latenti, impossibili».
Da questa difficile ricerca, che si potrebbe definire come una nuova frontiera del narcisismo, è nata un’opera inquietante e sorprendente, portata a termine assieme a Marco Delogu, che — con la sua sapienza di fotografo — ha catturato questo pulviscolo di fantasmi, di identità alternative. La mostra, inaugurata al Macro di Roma il 6 novembre, si intitola L’altra ego. Sono quindici immagini di grande potenza emotiva, come altrettante confessioni provenienti dal nucleo più nascosto e inviolabile di sé, che però è sempre altrove, ama nascondersi e apparire dove meno te lo aspetti, come un bambino innocente e perverso. Esplicito è il riferimento letterario alle Vite immaginarie di Marcel Schwob. Ma mentre il grande scrittore simbolista, antesignano di Borges, scriveva biografie di artisti e celebri assassini del passato, qui l’energia dell’immaginazione è tutta concentrata su un unico soggetto, che ammicca dalla pluralità dei suoi travestimenti. A volte l’impressione è quella della discesa agli inferi, a volte quella di un’improvvisa liberazione. È con il rigore di una vera e propria body artist che Giosetta Fioroni ha scelto i costumi, le parrucche, i trucchi e tutti gli altri accessori che servivano a dar corpo alle sue identità immaginarie. «Mi era capitato in mano un vecchio numero di “Harper’s Bazaar”, dedicato ai rapporti tra arte e moda. Qualche stimolo all’invenzione mi è venuto da lì. Ma è stato un lavoro lunghissimo, pieno di incognite, di incertezze». In fin dei conti, intervenire sul proprio aspetto, evadendo dal recinto dell’apparenza quotidiana, è un’operazione magica ancora più che un processo artistico. E tutte le operazioni magiche contengono in sé una buona dose di imponderabile, una serie di effetti capaci di stravolgere tutte le cause evidenti.
Tutta l’opera di Giosetta Fioroni è condizionata da questo scarto: da un lato c’è il «mestiere», inteso come padronanza tecnica e disciplina; dall’altro si annidano la sorpresa, l’illuminazione, l’allargamento improvviso della conoscenza. Anche quando la conversazione si ritrae dal presente evocando tempi ormai remoti, la sensazione è che Giosetta, raccontando i suoi anni di noviziato artistico, non abbia vissuto un’esperienza molto diversa da quella di Topolino apprendista stregone nel celebre episodio di Fantasia. Come l’eroe di Walt Disney, ha evocato forze superiori, e se ne è fatta trasformare nel momento in cui tentava di piegarle a sé.
Che destino migliore potrebbe auspicarsi un artista? E come in tutte le fiabe che si rispettino, svolgono un ruolo decisivo certi «aiutanti magici», incontrati per caso nei momenti di scoraggiamento. Come quel giorno, a metà degli anni Cinquanta, in cui Giosetta Fioroni, studentessa delusa dai suoi professori e incerta del suo futuro, aggirandosi per i corridoi dell’Accademia di Belle Arti, in via di Ripetta, notò una porticina nera, con un cartello che invitava a iscriversi alla «Scuola libera di nudo». E fu così che avvenne l’incontro col primo, indimenticabile maestro: Toti Scialoja, «più grande ancora come poeta che come pittore. Eravamo una decina d’allievi, oltre a me c’erano Festa, Kounellis. Toti ci insegnava i maestri della regia russa, o i segreti del cinema di Buster Keaton. Era capace di mimare splendidamente tutto quello di cui parlava. Ed era stato uno dei primi a rendersi conto della grandezza dei pittori americani del dopoguerra».
Ed ecco gli incontri con De Kooning, con Rothko, con Twombly… Ascoltandola parlare, viene in mente che se fosse nata nel Settecento Giosetta sarebbe stata una di quelle perfide e deliziose autrici di lettere e memorie, capaci di infilzare un intero carattere con un colpo d’occhio infallibile e una manciata di parole esatte. Ecco Rothko sulla spiaggia di Fregene, molto reticente riguardo ai segreti della sua pittura, timidissimo. «Si tuffava in mare tenendo per la mano la moglie e la figlia, una famiglia di obesi silenziosi, affamati di fettuccine». De Kooning, invece, era «il fascino personificato», e mentre me ne parla Giosetta mi mostra una vecchia foto del pittore americano, conservata in una cornice ovale. «Gli organizzai una festa di compleanno, a casa mia in via delle Orsoline. La mattina dopo ho trovato in giro cento bottiglie di whisky».
Continuerei a lungo a collezionare queste perle della memoria, ma mi accorgo che il gioco la immalinconisce un po’. «Che vuoi che ti dica: sto per compiere ottant’anni, e ancora amo tutto della vita: i giorni di sole e di pioggia, i negozi, gli animali, i peli grigi che vedo sulla tua barba. Non mi sono preparata… Non so accettare che presto non ci sarà più niente!». E non c’è nessuna saggezza d’occasione, nessuna filosofia astratta che potrebbe consolarla. Semmai, c’è da star sicuri che troverà il modo da sola, Giosetta, per allungarsi la vita: continuando a tessere i fili colorati della sua storia, rischiando, mettendo a repentaglio ogni idea di sé troppo comoda e stabile per essere vera.
Emanuele Trevi
di Giovanna Ricoveri
Per evitare che tutto finisca in un calderone indefinito, dobbiamo distinguere e dare priorità alle risorse naturali, decisive per la sopravvivenza dell’umanità. Solo dopo vengono conoscenza e cultura, servizi e internet. Le comunità e i movimenti ambientalisti devono diventare una voce che decide insieme alle altre istituzioni del territorio. I beni comuni naturali, legati ai quattro elementi di Empedocle – acqua, aria, terra e fuoco – possono esprimere, riletti alla luce del presente, un modello sociale e produttivo alternativo, ma non sostitutivo, a quello capitalistico. Hanno questa valenza perché mettono in discussione il capitalismo da tre angolature essenziali: l’economia di mercato e quindi la mercificazione delle cose e delle persone; la proprietà privata e quindi lo sfruttamento del lavoro e della natura; la democrazia rappresentativa, che nella globalizzazione neoliberista non garantisce la partecipazione e il controllo dei cittadini, neanche in misura limitata. I beni comuni naturali sono risorse fisiche essenziali alla sopravvivenza, e sono pertanto diritti universali, come sostengono i giuristi; ma non sono diritti universali, che diventano beni comuni se e quando le risorse naturali, cui i diritti si riferiscono, sono gestiti “in condivisione”. Non è la destinazione dei beni comuni che li rende tali: le risorse essenziali alla sopravvivenza sono beni comuni “a prescindere”, anche se appropriate o “recintate” dal capitale. Né i beni comuni naturali diventano tali grazie alla conversione delle produzioni e alla riterritorializzazione dei mercati, che sono un tassello decisivo dell’alternativa, ma non trasformano in beni comuni i settori produttivi riconvertiti. I beni comuni non sono neanche “il” bene comune, che è invece l’interesse generale di un paese, garantito dai governi. La letteratura sui beni comuni (scarsa in lingua italiana) e il dibattito corrente (spesso ridondante), dividono i beni comuni in quattro categorie: i beni comuni naturali; quelli culturali (il linguaggio, la conoscenza, il patrimonio artistico); quelli sociali (i servizi pubblici e le acquisizioni dello welfare); e quelli digitali (internet in tutte le sue articolazioni). Prendere a prestito una espressione simbolica come i beni comuni è utile, ma a condizione che non si faccia un calderone trattando allo stesso modo quel che è diverso, e deve essere analizzato nella sua specificità. La rilevanza dei beni comuni naturali, a volerla riassumenre in un solo concetto, è proprio la loro diversità e specificità di luogo e di tempo. La cultura sottostante i beni comuni naturali è opposta a quella del capitalismo: mentre la prima valorizza la diversità e il locale, considerandoli la vera ricchezza di un popolo e di una comunità; la seconda li nega in nome dell’ideologia dell’homo oeconomicus che rende un uomo eguale a tutti gli altri, un’ora di lavoro eguale a tutte le altre, la competitività una necessità intrinseca ancor prima che economica, legata al profitto. Non esiste una definizione unica dei beni comuni naturali, la cui forza è proprio la flessibilità con cui le comunità – i soggetti titolari dei beni comuni – riescono ad adattarsi al variare delle situazioni. È possibile tuttavia descriverne i tratti distintivi, uno dei quali è proprio la diversità. Un altro è l’auto-organizzazione della comunità, che è una forma importante di democrazia diretta, capace di correggere e integrare quella rappresentativa. I beni comuni sono infatti sistemi locali, diversi nello spazio anche nello stesso periodo storico, e proprio per questo esprimono una alternativa reale – ancorché parziale – al paradigma del mercato: la loro flessibilità permette di utilizzare al meglio le risorse presenti sul territorio, evitandone il degrado e la distruzione, che sono invece ineliminabili nel modello capitalistico. Sul territorio è inoltre possibile far emergere e valorizzare le risorse umane di creatività, intelligenza ed energia delle persone, che sono la risorsa più scarsa in assoluto in una società ecologicamente e socialmente sostenibile. A sostegno della priorità dei beni comuni naturali, ci sono diverse ragioni: la prima, quella di essere beni di sopravvivenza senza i quali nessuno – né ricchi né poveri – può sopravvivere. Dopo, ma solo dopo, vengono conoscenza e cultura, servizi e internet. Un’altra ragione è che in ciascuno dei quattro elementi vitali di Empodocle si racchiude tutta la realtà, quella di oggi come quella di ieri e dell’altro ieri. L’acqua ad esempio non è solo quella che beviamo ma anche quella per la cura di sé, per lo smaltimento dei rifiuti, per la produzione agricola e industriale, etc. Una terza ragione è che nel terzo millennio le frontiere del profitto si sono spostate sui beni comuni e sui beni pubblici, e cioè sul patrimonio consolidato di beni naturali, infrastrutturali e di servizi, il cui valore è in parte un “regalo” della natura e in parte frutto dell’ingegno e del lavoro delle comunità e delle popolazioni locali. Una ricchezza collettiva molto appetibile per le grandi multinazionali e per la finanza, che è al centro dello scontro sociale in Europa e nelle guerre in corso in molte parti del mondo per le risorse naturali e il controllo del territorio. Nel passaggio dal Medioevo alla Modernità, i beni comuni sono stati appropriati (enclosed) dal capitale e la natura è scomparsa dall’orizzonte delle scelte economiche e politiche, come è successo all’agricoltura contadina nel secolo scorso. La sottovalutazione della natura ha avuto effetti devastanti e duraturi nel tempo: ha legittimato la schiavitù e il colonialismo; l’introduzione su vasta scala della chimica in agricoltura; l’uso generalizzato di energia fossile; l’impiego di tecnologie pericolose e di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro, dove i lavoratori vanno a morire come fossero in guerra. Il caso Ilva ne è la riprova inequivocabile, così come gli incidenti mortali sul lavoro. L’esperienza europea del Medioevo e quella attuale nei paesi del Sud del mondo offrono elementi utili a capire come i beni comuni naturali potrebbero essere riproposti per superare la crisi del capitalismo. Una condizione è che il progresso non sia identificato con il “nuovo” mentre è un misto di presente e di passato: fare terra bruciata del patrimonio di esperienze del passato contraddice infatti ogni regola di buon senso. La crisi del capitalismo potrebbe essere l’occasione per rilanciare questa esperienza storica di auto-regolamentazione delle risorse locali e del territorio da parte delle nuove comunità locali, da identificare nei comitati di lotta e nei movimenti ambientali e sociali che esistono numerosissimi ovunque. Un esempio italiano noto è il Comitato NoTav della Val di Susa. Un’altra condizione è che a questi nuovi soggetti venga riconosciuto per legge il potere di co-decidere sull’uso del loro territorio, avendo pari dignità rispetto alle altre istituzioni già presenti sul territorio, innanzitutto i governi locali. Il ritorno dei beni comuni qui auspicato, o la loro reinvenzione come sostiene la Fondazione tedesca Heinrich Boell, si colloca in questa prospettiva strategica: richiede di considerare i movimenti ambientali e sociali e i comitati di lotta che operano in difesa delle risorse naturali e della giustizia sociale e ambientale come istanze che esprimono le esigenze del territorio e dei suoi abitanti, avendone il potere formale e sostanziale. Questo modo di intendere i movimenti permetterebbe di superare il duopolio stato-mercato immettendo nel sistema un terzo soggetto di democrazia diretta e insieme elementi di democrazia politica, capaci di rompere gli steccati costruiti dal capitale per concentrare le decisioni che riguardano tutti nelle mani di pochi, sempre più lontano dai luoghi dove le persone vivono e possono dire la loro. Si metterebbero così in discussione i pilastri su cui si regge oggi l’economia mainstream – l’oblio della natura, la competitività internazionale, la produttività, la competenza, la crescita. In sintesi, l’ingiustizia sociale e ambientale.
(il manifesto, 2 novembre 2012)
L’intervista/Sissi
Una performer della vita
Tra qualche giorno Sissi inaugura una personale alla Fondazione Volume! di Roma. Come sempre prima delle sue mostre, materiali diversi si sovrappongono e invadono il luogo di lavoro. Perché alla giovane artista bolognese non interessa distinguere i linguaggi artistici, né separare l’esposizione dalla performance, la forma dall’informe. Così come la materia grigia dallo stomaco. L’abbiamo incontrata mentre sta preparando la mostra [di Manuela de Leonardis]
Timbri, inchiostri, tamponi, pennelli. Nell’ufficio della Fondazione Volume al n. 73 di Via di San Francesco di Sales a Roma c’è un grande “Paesaggio Interno” di Sissi (Bologna 1977, vive e lavora a Bologna) sul tavolo. “Pareti corporee”, “camerate gestazionali”, muscoli, tessuti, vene che pompano emozioni nell’intreccio di un paesaggio interiore (quello dell’artista) che trova forma sui fogli di carta. Sarà la stessa Sissi, nel corso della performance del 25 ottobre (alle ore 20:00), in occasione della mostra Volume Interno curata da Claudia Gioia (dal 26 ottobre al 25 novembre 2012), a guidare lo spettatore nello spazio di Volume! trasformato in una grande mappa. Pagine e pagine di un libro anatomico. Intanto sorseggia la tisana del dopo pranzo, le mani sporche d’inchiostro, mentre risponde alle domande.
Partiamo da Volume Interno, il progetto che hai realizzato per la Fondazione Volume!, seconda tappa del percorso di ricerca iniziato con Anatomia Parallela I…
“Anatomia Parallela è una ricerca con cui, dal 1999, approfondisco la mia identità. Non si è mai fermata e continua ad andare avanti. È partita dal mio bisogno di lavorare sul corpo, inteso come paesaggio interiore, quindi capire da dentro quello che accadeva fuori. Infatti il nostro modo di essere, la nostra natura, è condizionata anche da quello che ci circonda. Per me era fondamentale, come performer, avere come punto di partenza l’interiorità, l’anatomia: un paesaggio che sentivo il bisogno di studiare, per poi ritrovare e riconoscere forme, sensibilità organiche nelle cose che mi circondavano. Anche perché ho molto bisogno di manipolare, trasformare le cose e questa trasformazione non è soltanto un cambiamento, ma qualcos’altro. Mi piace il processo di come le cose diventano. Allora, mi sembrava indispensabile averne una consapevolezza profonda. Anatomia Parallela è uno studio sull’emotività ed è un libro d’artista, che oggi emano e proclamo con il mio Manifesto Emotivo, accompagnato dalla performance che presenterò a Volume!”.
“Per me la materia grigia è nello stomaco”, mi avevi detto in occasione della nostra chiacchierata alla Quadriennale del 2008 – “è come se la mia testa fosse nello stomaco”. L’aspetto emotivo riveste un ruolo determinante all’interno di un lavoro in cui il tuo “io” è sempre presente. La sperimentazione, in particolare, parte dal tuo corpo. È una necessità quella dell’introspezione, uno strumento di conoscenza che ti permette di dialogare con il mondo esterno?
“È ancora così, perché le viscere cerebrali sono anche le viscere addominali e sono trattate nel secondo capitolo, che è quello dello stomaco e delle sue voracità. In Anatomia Parallela, infatti, discuto del fatto che le problematiche non risolte a livello cerebrale cadono a piombo nello stomaco, dilatandosi in un peso che viene attorcigliato nella sua complessità e compreso, a livello di nodi e ingarbugliamenti, nel passaggio in arrivo fino allo stomaco. Le viscere possono essere il letto di qualcosa che si è finalmente sciolto. Ancora oggi sono completamente consapevole e convinta di ciò che ho sempre pensato e da sempre ha fatto parte dei miei concetti. L’ho anche scritto in Anatomia Parallela, che è la genesi di una serie di riflessioni che sono – per me – la motivazione per come il mio impulso, la mia poetica e la mia energia si muovono. Quindi è un teorema del mio modo di vedere e sentire le cose. Se, però, prima era filtrato è come se nel tempo avessi lasciato andare parole a pezzi, uno smembramento, una frammentazione – oggi, con questa performance, è una dichiarazione totale e, magari, un congiungimento. Ne discuterò attraverso i quattro capitoli di Anatomia Parallela I, che è l’anatomia dei contenitori dell’emotività: lo stomaco, il cuore, i sessi e l’articolazione”.
La performance è la parte centrale dell’opera, intorno a cui si intrecciano linguaggi, tecniche – scultura, fotografia, disegno – e materiali diversi (nylon, lana, spugna, fili di scoubidou, ecc.). Alla fotografia sembra, in particolare, essere affidata la memoria dell’azione, del momento. È così?
“Uso moltissimo la fotografia, da sempre scatto con la mia F2. Il mio è un uso personale, un modo per guardare le cose che mi dà un’inquadratura, uno sguardo. Sicuramente la performance è un qualcosa di epifanico, che scompare. Questo mi è sempre piaciuto, perché le cose scomparendo possono tornare, ma in modo diverso. Ma, come per il mio ciclo dello scoubidou, che si è esaurito dopo tre anni, nel 2003, quel momento epifanico bisognava fermarlo. Anch’io ho delle mie abitudini e, dato che mi piace molto fotografare, ho sempre preferito usare la fotografia, rispetto al video, come processo di documentazione del lavoro, perché potevo scegliere quel determinato sguardo che volevo lasciare. Quest’anno, invece, ho iniziato a lavorare con il video d’animazione, quindi probabilmente la performance da Volume! sarà documentata da un video”.
Hai sempre con te dei quaderni su cui prendi appunti e disegni. Come avviene il passaggio dall’idea al progetto?
“Non c’è molto spazio tra questi due momenti, sono abbastanza sovrapposta. Un’idea nasce mentre viene progettata, un progetto si costruisce mentre nasce un’altra idea. Non c’è distanza. Sono molto pensiero-azione, quindi penso facendo le cose. Molte volte capisco il mio lavoro quando ormai l’ho già finito. È un’istintualità un po’ animalesca, quella che mi porta a fare le cose. Trovo che sia estremamente liberatoria, non cerco troppo di razionalizzare. Quando però strutturo una ricerca – come per Anatomia Parallela – è come se fosse il corpo-madre che figlia altre progettualità, quindi mi viene naturale pensare a come svilupparlo, farlo crescere. Non è da uno schema che le mie idee escono fuori”.
La manualità – l’aspetto tattile e concreto del lavoro artigianale – in una dimensione rallentata del tempo – sembra avere un ruolo primario all’interno del tuo lavoro. Nella ripetizione dei gesti – lavorare a maglia, tessere, intrecciare corde… – c’è anche un aspetto zen/meditativo?
“No, non sono molto meditativa, anzi di solito non vedo l’ora di finire. Non vedo l’ora di iniziare e non vedo l’ora di finire. È la proliferazione che, probabilmente, mi esalta, quindi la quantità. Il mio lavoro è qualcosa di un po’ “fungaceo”, che si riproduce. Mi piacciono le forme-informi. Fare la maglia non è mai stato un grande amore, ma era l’unico modo per tenere insieme più cose diverse, ecco perché preferisco definirla una catena di nodi”.
La deriva è il nodo della mia gola è il titolo dell’opera che hai presentato alla 53. Biennale di Venezia; Al di là dello sguardo la corda lega quella della Quadriennale del 2008; Il riposo dei miei piaceri (2000), La fantasia morde la piega in bilico (2010)… Titoli che appaiono come frammenti poetici strettamente connessi all’opera stessa…
“Sì, nascono abbastanza insieme, è come se li chiamassi e li riconoscessi. La deriva è il nodo della mia gola è un lavoro di ceramica, terrecotte che ho fatto in maniera molto grezza. Non le ho cotte in un forno appropriato per la ceramica, ma da un vasaio – un piccolo artigiano che si trova vicino al mio studio – che metteva le mie creature tra i suoi vasi per piante. Ho scelto tutto quello che poteva essere il più primitivo possibile, perché io stessa ero estremamente primitiva in quell’avventura. I materiali mi piacciono non tanto perché, alla fine mi piace vedere, dentro di me, una varietà di differenze, ma per il fatto che mentre li incontro inizia la performance. Probabilmente sono più performer nella vita che nell’atto stesso della performance, perché mi piace molto entrare dentro. Quindi essere per un periodo un ceramista, per un altro un fabbro o una donna che tesse, cercando di immedesimarmi all’interno di un’identità. Nel periodo in cui lavoravo per la Biennale, quando toccavo l’argilla sembrava che stessi palpando le mie tonsille, o era come se avessi infilato la mano nello stomaco e con un pantografo avessi riportato le mie misure sulla terra. Era qualcosa di nodoso che veniva da dentro. Poi si accompagnava anche con un periodo abbastanza triste della mia vita personale, quindi non ho potuto nascondere niente”.
Sei l’unica artista italiana che è stata invitata a partecipare, nel 2007, alla collettiva Global Feminism. New directions in contemporary art al Brooklyn Museum di New York. Pensi che oggi abbia ancora senso di parlare di arte al femminile?
“In quell’occasione presentavo una performance che si chiama Le ali non hanno casa, unico site specific della mostra. Come ho già detto in un’altra intervista, secondo me – dal punto di vista del sesso – l’artista non ha un’identità che lo caratterizza. Ha un’identità autonoma, può essere uomo, donna. Ci può essere, semmai, il percorso analitico di una ricerca, in cui certe persone hanno intrapreso comuni sensazioni o svariate modalità di approcciarle. Personalmente non sento quella distinzione, non mi appartiene. Sono molto più giovane, lontana forse da questo bisogno di fare delle differenze”.
Letteratura, viaggio, cucina, cinema e altre arti visive… c’è qualcosa che predilig i per il tuo nutrimento culturale?
“Sono fatta di tutto, non riesco a prediligere molto. Son tutta tanta!”
Progetti futuri?
“Anatomia Parallela II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIX, X…”