Che cosa spinge l’artista afghana Shamsia Hassani, a rischio della vita, a denunciare con i suoi murales le prepotenze e le violenze perpetrate soprattutto contro le donne in Afghanistan? Che cosa spinge l’artista Banksy a usare la sua arte per attirare l’attenzione sulla crisi dei rifugiati e sulle guerre? Che cosa spinge l’artista e attivista cinese Ai Weiwei a sostenere i diritti umani negati dal governo cinese? Che cosa spinge Ruggero Maggi, con i suoi libri d’artista, performance, mail art, a sposare e sostenere la causa del Tibet libero? Che cosa stimola l’agire per portare pace, occuparsi dell’ambiente, preservare i paesi pensando alle generazioni future, ma anche alle presenti per poter continuare a guardare e godere della bellezza della natura? Sono domande che la critica d’arte Katia Ricci qualche giorno fa ha posto all’inaugurazione a Foggia della mostra di mail art, coordinata da lei e organizzata dal circolo La Merlettaia e dalla rete delle Città Vicine. È l’amore per «un mondo più giusto, per i deboli, per il lavoro, per le alterità, per l’ambiente, per la pace. L’amore come sentimento, che diventa una forza politica che può trasformare la società, che contrasta la cultura della prevaricazione, del dominio e fa sperare nel futuro, l’amore che crea unione come la rete di Indra, interconnessa con l’universo, secondo un’antica metafora buddista». È questa la risposta che Ricci ha dato e che sta tutta nel titolo della mostra stessa, “Amore e/è politica” una politica che non guarda al potere, al dominio e alla forza, ma all’amore per il mondo da salvaguardare e di cui prendersi cura, all’ amore per la vita, per gli esseri umani, per la pace, le relazioni, il dialogo, lo scambio di idee, sentimenti, pensieri. «Perché amore e/è politica – si legge nel video sulla mostra realizzato da Maria Rosaria Campanella –, amore è energia trasformativa nell’accoglienza, nell’apertura all’altro, nella cura dell’ambiente, nella ricerca della pace. Tutto questo è politica». È politica delle donne, è femminismo che nasce dall’amore femminile per la madre, per le donne e che spinge, da tredici anni, Katia Ricci a coordinare mostre di mail art e invitare artiste/i, donne e uomini comuni, con cui nascono relazioni, a parteciparvi con opere, pensieri, idee che viaggiano attraverso la posta. È dall’amore delle loro insegnanti che nascono i lavori, che parlano di amore e di pace, di bambine/i di alcune scuole di Foggia e giovani dell’Accademia dell’Arte. Come dall’amore della loro maestra d’arte, la pittrice Ornella Cicuto, e delle sue allieve nascono i lavori, inviati per posta, di ragazze/i “speciali” de “La fabbrica dei Sogni” di Catanzaro. Anche Cicuto, la sua allieva Rosanna Macrillò e l’artista catanzarese Paola Quattrone hanno inviato loro opere. È l’amore che diventa politica che sta all’’origine stessa della mail art, una pratica artistica diffusasi agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, nelle due Americhe. «Mentre i nordamericani – scrive Katia Ricci in un suo articolo – si ribellarono al conformismo, ai critici delle gallerie e alle istituzioni, i latinoamericani invece si opposero ai propri regimi repressivi», come fecero, poi, anche gli artisti perseguitati nell’Europa dell’Est. Dal 1975 al ’79 alcune donne in tutto il mondo «iniziarono a inviarsi piccole opere d’arte con l’intento di unire aspetti del privato domestico e personale con il politico e il sociale». La mail art, da allora, continua a viaggiare per tutto il mondo e a Foggia sono centinaia le cartoline arrivate per la mostra, che dal 31 maggio in poi diventerà itinerante. Tra qualche giorno sarò dalle mie amiche di Foggia e la mostra si integrerà con la presentazione del libro “Femminismo mon amour” della Libreria delle donne di Milano.
da il manifesto
Le fotografie di Fatma Hassouna esposte in diversi luoghi di Cannes – fra cui il Padiglione della Palestina – ci raccontano Gaza le sue macerie, il suo dolore, quel genocidio quotidiano rispetto al quale finalmente, e anche grazie a lei, sembra che stia nascendo una diversa consapevolezza, o almeno ci sia una presa di parola. La narrazione cambia? Speriamo. Sulla Croisette il film di cui la giovane fotografa e giornalista palestinese uccisa a Gaza insieme a tutta la sua famiglia dalle bombe israeliane è protagonista è stato il punto di partenza per una reazione. Non sul Red carpet militarizzato ma nelle parole della serata di apertura dette dalla presidente di giuria Juliette Binoche, con la tribuna firmata da tantissime artiste e artisti e pubblicata il giorno di apertura del Festival perché il genocidio si fermi, nella decisione di altri festival che si sono impegnati a far circolare questo film (Venezia, Locarno, Nyon) per rompere il silenzio, nell’emozione del pubblico che ha affollato le proiezioni (molto controllate dal punto di vista della sicurezza) sempre sold out.
Put Your Soul on Your Hand and Walk – nella selezione di Acid – inizia dalla necessità dell’autrice, la regista iraniana ma esiliata a Parigi Sepideh Farsi di documentare la guerra a Gaza, un gesto contro il silenzio e contro quella disumanizzazione dei palestinesi nel racconto di vittime senza nomi e senza storie. Il 16 aprile, quando Fatem come la chiamavano gli amici è morta – ce lo ricordano i due cartelli all’inizio – è divenuto un’altra cosa, un archivio della sua resistenza che si amplifica e fa risuonare ancora più forte la sua battaglia, quell’essere lì e continuare a testimoniare la brutalità dell’esercito israeliano – che infatti uccide i giornalisti perché il mondo non veda.
Nelle conversazioni a distanza su zoom fra lei e Sepideh Farsi si afferma dunque una parola che è anch’essa negata, e l’immagine nel film di Fatem viva, persistente, ci parla di ciò che i nostri governi continuano a ignorare e che oggi non può più esserlo perché questa complicità sbriciola ogni senso della democrazia. Fatem è lì nella sua urgenza, e con lei ci sono gli abitanti di Gaza anche se fuori dallo schermo, la loro esperienza quotidiana di fatica, paura, tristezza, fame, rabbia, dolore. Sepideh Farsi aveva avuto il contatto di Fatma Hassouna quando era al Cairo, da dove aveva provato inutilmente a entrare a Rafah. Le due donne portano avanti questa conversazione per mesi, la ragazza appena iniziata l’aggressione israeliana, dopo i massacri del 7 ottobre, inizia a raccogliere immagini, documenta, cerca di mantenere una memoria dei luoghi, dei suoi abitanti, di quel quartiere dove vive e degli altri che giorno dopo giorno vengono distrutti, delle persone sono costrette a fuggire, che muoiono inghiottite dalla polvere come già diversi fra i suoi famigliari: adulti, bambini, anziani, una popolazione.
Sullo schermoai loro volti si sovrappongono alcune immagini di Fatem, ma sono soprattutto le sue parole, poesie, racconti precisi, stati d’animo che danno il senso dei sentimenti e della realtà. Fatma che vorrebbe viaggiare ma come dice non lascerà mai la Palestina e tantomeno ora, con un genocidio in atto, il suo compito è rimanere in quella terra, resistere, come hanno fatto da sempre, da quando un altro paese si è arrogato il diritto di distruggerli. I giorni passano, le immagini si sovrappongono, gli schermi si moltiplicano; la linea a volte cade, le connessioni sono difficili, Israele cerca con ogni mezzo di isolare Gaza dal mondo.
L’assedioè sempre più duro, le parole di Fatma ne sfidano la ferocia con la loro gioia, altre volte invece appare distratta, la fame aumenta, gli aiuti sono bloccati. Il telefono riprende a volte la regista rifilma con una piccola camera. Fatma si alza e apre al suo gatto, ascolta qualcuno nella stanza accanto: cosa dire? Come continuare? La stanchezza si fa più forte, come la violenza, la morte. Eppure lei continua a tenere aperta questa finestra – attraverso la quale far uscire l’orrore che accade, è una crepa, e un documento che ci parla e ci interroga, a volte nello sconforto, più spesso col sorriso. «È difficile, molto» ripete allargando l’immagine in quella stanza, da cui sul suo volto appare l’esterno i gesti, il tono della voce anche quando cerca di mascherare rivelano ciò che è fuoricampo, che le sue fotografie hanno fermato oltre il tempo. Lo portano dentro con forza, lo fanno tangibile. Lei ora non c’è più ma c’è la sua immagine, la stessa di migliaia e migliaia di palestinesi uccisi, questa è anche la loro storia, e ci dice che tacere non è più permesso.
da Exibart
Prima io la guerra non sapevo proprio cosa fosse. Ho visto tutti i film e letto tutti i libri che ti consigliano, ma non sapevo nulla. Ci ha provato anche il mio nonno a raccontarmi dell’Italia, del fascismo e delle montagne emiliane che custodiscono il coraggio di chi non si voleva arrendere, ma le sue parole sapevano di storie lontane, da “c’era una volta”, come quelle che ti raccontano quando sei piccolo e fortunato appena prima di addormentarti. Questa volta invece la guerra è vicina e io sono andata a visitarla. Cosa significa andare a visitare un paese in guerra quando il tuo ha il privilegio di essere in pace ancora non lo so, di sicuro la prospettiva te la cambia. Prima banalità: la guerra è uno strumento per vedere le cose in modo diverso, vorrei essere originale, ma a volte la verità è banale. Ho scritto qui di seguito un diario di viaggio delle lezioni super-banali e mai-scontate che la guerra mi ha insegnato in una settimana.
Kyiv, giorno 1 – Il primo allarme drone non si scorda mai
O meglio notte 1, sono le 23.30 e sono molto stanca. Per raggiungere Kyiv da Milano ho preso un treno alle 6.00 del mattino, poi un aereo per arrivare a Varsavia in Polonia e dopo circa sei ore di attesa ho preso il pullman. Quello che sembrava essere l’ultimo step del viaggio in realtà inaugura la mia epopea. Sedici ore di pullman dopo, quattro di controllo alla frontiera e un panino con lisiecka arrivo a Kyiv, capitale dell’Ucraina, paese in guerra contro la Russia dal 2014 e che dal febbraio 2022 si difende dall’invasione su larga scala. Alla fermata del pullman mi aspetta un giovane biondo ucraino, Andrys Lutsiv, vestito con colori camouflage. Seconda banalità, ma la verità è banale. Andrys ha le braccia piene di tatuaggi e le scritte in latino Veni Vidi Vici io le riconosco subito, mi sorride e mi porge un bellissimo mazzo di fiori rosa: «Benvenuta in Ucraina». È tardi, mi faccio la doccia più desiderata di sempre e corro sotto le coperte. Tutti mi hanno sempre detto che ho il sonno pesante, «non ti svegliano neanche le bombe» mi dicevano e invece eccome se mi svegliano. All’improvviso, durante la notte, il mio cellulare squilla all’impazzata con un volume così alto che neanche lo sapevo potesse arrivare a questi decibel. «Allarme-allarme» ripete l’app del governo e qualche secondo dopo si aggiunge anche l’allarme dell’albergo «Pericolo: attacco droni. Correre immediatamente nel rifugio». Mi sveglio di soprassalto, mi ricordo dove sono e capisco quello che sta per succedere. Con una velocità da gazzella mi infilo le scarpe, prendo una felpa e faccio otto rampe di scale volando e corro al rifugio sotterraneo. Io non lo so dove ho imparato a reagire così alle situazioni di pericolo, sinceramente prima di venire qui pensavo di essere una schiappa, una di quelle persone che si paralizza e diventa un cubetto di ghiaccio. Evidentemente no, beh meglio così, penso. Il rifugio è quasi vuoto e ancora il perché non lo capisco, lo scoprirò solo tra qualche giorno. Le ore nel rifugio mentre c’è un pericolo di attacco drone in corso sono noiosissime. Niente a che vedere con i film, dove è tutta un’azione, adrenalina e elaborazione di piani per la fase successiva. Il telefono nel bunker non prende, quindi non puoi neanche collegarti alle news in tempo reale e fare finta che si rivolgano a te. Il libro nel mio scatto da gazzella me lo sono dimenticata e allora prendo una copertina sintetica gentilmente offerta dall’albergo, bevo un tè e mi metto a sonnecchiare sulla sedia. Dopo qualche ora l’allarme passa, possiamo tornare in camera. Che bello finalmente il letto!
Kyiv, giorno 2 – Quando le città vanno a dormire
È tardo pomeriggio e raggiungo lo studio dell’artista ucraino Nikita Kadan. Insieme a me ci sono gli altri compagni che sono venturi a fare visita alla guerra: due artisti (Stefan Klein e Nicola Zucchi), una giornalista esperta di zone ad alto rischio (Marie-Line Deleye), un curatore/artista che studia la danza come strumento di esorcizzazione del trauma in situazioni di conflitto (Bogomir Doringer) e un operatore e educatore culturale di Magnum Photo Agency (Pierre Mohamed-Petit). Insieme a Nikita ci sono altri artisti ucraini, il pittore Yuriy Bolsa, la curatrice Alona Karavai, le artiste Sana Shahmuradova Tanska e Olga Stein. Trascorriamo la serata sul terrazzo del suo studio all’ultimo piano di un elegante palazzo di Kyiv. Se gli artisti hanno studi enormi in palazzine borghesi della capitale significa che il mercato immobiliare è proprio crollato. Mangiamo pizze dal cartone e beviamo champagne. Parliamo di tutto e poi di niente. Di fronte a noi fa capolino la luna, piena come non lo è mai stata. Nel cercare le sigarette faccio un fermo immagine: artisti, una luna piena e discorsi sulla resistenza. La sera di un martedì e una dose di verità dritta in vena. In Ucraina la notte è stata rapita tre anni fa, da quando c’è la legge marziale e il coprifuoco obbligatorio per tutti. Sono le 23 ed è ora di rientrare in albergo. Rientro a piedi e Google Maps mi accompagna a casa passando a fianco a un parco. È notte e buio, eppure io non me lo ricordavo che fosse così buio di notte. Mi guardo attorno e non c’è neanche un lampione acceso, neanche un’insegna luminosa per chilometri. O almeno così penso, sono miope quindi le distanze le calcolo un po’ a spanne. Mi sembra veramente tanto buio, ho paura e inizio a guardarmi attorno. Se sei una donna cresciuta in Italia sai benissimo che dei parchi di notte devi avere paura, che qualcuno arriva, ti assalta, nessuno ti sente e poi ti tocca convivere tutta la vita con il trauma e combattere contro la magistratura che non ti crederà. Poi però mi viene in mente che uno dei compagni che visita la guerra insieme a me aveva già notato il buio e qualcuno gli aveva detto che è una precauzione militare, che anche le città devono andare a dormire non solo gli abitanti, perché se le luci sono accese e i lampioni raggianti, i russi lo vedono meglio dove colpire. Buio per camuffarsi e coprifuoco per tutti. Allora il drone fa più paura di un parco di notte.
Kharkiv, giorno 3 – Il negozio di pennelli con la porta spalancata
Quando penso a Kharkiv la mia mente fa un gioco strano, è come se il cricetino che regola i miei pensieri iniziasse a correre fortissimo e la mia memoria diventa in modalità x4-x6-x8, come quando clicchi il telecomando per velocizzare un film. Immagini di case bombardate, militari mutilati, futuri mancati scorrono velocissimi e poi appaiono immagini del parco rigoglioso della città, Viktor che chiede a Marija di sposarlo in stazione con un mazzo di rose rosse e la panetteria di quartiere. Quel giorno è a frammenti, come tanti pezzi di vetro rotto, non riesco ancora a ricostruire cosa fosse prima di schiantarsi a terra. Forse ci vuole tempo anche per ricordare meglio. O forse il tempo lenisce il ricordo e a un certo punto te ne freghi dei frammenti di vetro pungenti che ti tagliano i ricordi.
Eppure quando penso a Nataliia tutto rallenta. Nataliia Ivanova è la curatrice del centro Yermilov aperto dal 2012 come museo, prima come strip club. Da sempre in un rifugio antibomba, prima una scelta cool per uno spazio di arte contemporanea, ora una scelta salvavita. La direttrice ha curato la recente mostra Sense of Safety e nell’installazione di Thomas Hirschhorn insieme ai compagni che visitano la guerra abbiamo fatto una discussione, una tavola rotonda dove ci siamo chiesti se l’arte può avere un potere curativo, di healing. Mi siedo sulla sedia-opera d’arte del Yermilov Center e mi chiedo cosa ne so io del potere curativo dell’arte, ché prima di venire qui quando parlavo dei musei come spazi sicuri pensavo alla sicurezza del pensiero critico e il libero dibattito, robe teoriche mica spazio sicuro “se no ti esplode la testa”. A Kharkiv ho imparato che più sei vicino alla guerra, più la vita si impone rigogliosa. Siccome di immagini di dolore e di morte è pieno il mondo e anche il web e tanto frega poco a quasi tutti, io vi racconto della gioia e della felicità che ho trovato a Kharkiv. All’angolo con uno dei tanti monumenti impacchettati, non da Christo e Jeanne-Claude ma dallo stato perché alle bombe delle firme degli artisti d’arte pubblica non interessa nulla, c’è un duo rock and roll che canta al bordo della strada e da lì sono vicinissimo alla panetteria per provare «i dolcetti alla cannella più buoni del mondo». Sono seduta fuori dalla panetteria con i miei compagni che visitano la guerra e da quando siamo in compagnia di chi invece con la guerra ci abita, abbiamo tutti abbassato la suoneria del cellulare perché gli allarmi sono tantissimi e non smettono mai e non ti fanno neanche finire una conversazione in pace. Allora meglio abbassare la suoneria e godersi ogni momento, ché quando la vita ti obbliga a scegliere preferisco morire con un biscotto alla cannella in bocca e la luce del sole addosso invece che come uno scarafaggio sottoterra.
Ora di cena, ora di provare la famosissima zuppa boršč di Kharkiv. Per raggiungere il ristorante passiamo in una strada bombardata, dove i palazzi le cicatrici le hanno ancora sanguinanti, ma siccome per le tragedie ci sono i giornalisti e io sono una curatrice vi racconto del negozio di pennelli. Nella tragedia urbana, il frastuono degli allarmi e le cicatrici dei palazzi, il negozietto a conduzione famigliare di tempere e pennelli è aperto. Non vende né acqua, né cibo, né altri beni di prima necessità, solo strumenti per fare arte. Lo so che sembra assurdo ma quando non hai più nulla da perdere, l’arte torna a essere essenziale. Poter disegnare è un modo per sopportare, buttare fuori quello che altrimenti ti mangia dentro. Qualcuno dice che così ti traumatizzi da solo, non lo so forse ha ragione, ma a volte non hai scelta e da qualche parte come ti senti lo devi vomitare. La porta del negozio è letteralmente spalancata, come a voler urlare che le bombe fanno paura, ma da lì non ci si muove, qui si resiste perché se qualcuno oggi avesse bisogno di dipingere, il negozietto di pennelli sul confine con la guerra è aperto.
Kyiv, giorno 4 – Parla come mangi
Da oggi cambio il linguaggio con cui mi esprimo. Non sono più “stanca morta” e non ti “bombarderò” più di mail. Esistono luoghi nel mondo dove queste parole non sono metafore e allora vale la pena fare uno sforzo e pensare a immagini nuove per veicolare idee diverse da questo schifo.
Kyiv, giorno 5 – Pensieri di cui mi vergogno
Stare in una zona di guerra mi è piaciuto. Lo so suona pazzesco e forse perché un po’ pazza lo sono davvero, ma se scrivo è perché ho deciso di essere sincera altrimenti cosa lo perdo io il tempo a scrivere e voi a leggere. Credo che la guerra mi sia piaciuta perché mi ha fatto sentire “la vertigine della storia”. Quando sei in una zona di guerra, non sei più in un paese a caso, a fare cose a caso, con persone che a caso ti trovi vicino, o meglio forse sei comunque tutte queste cose, ma ti senti che un senso ce lo hai. La sensazione è quella di essere nel centro degli eventi, di stare nel nucleo delle cose, di essere parte di qualcosa di più grande e anche la tua piccola azione a caso in realtà ti sembra possa plasmare il corso degli eventi e il futuro delle generazioni che verranno: vertigine della storia. Un artista ucraino durante un allarme drone e una bottiglia di vino rosso affacciati in un cortile di Kyiv mi ha rivelato un altro pensiero di cui si vergogna. Mi dice che vivere in Ucraina è sempre stato piuttosto noioso, che era tutto banale e piatto e che ora in qualche modo è felice perché anche se si muore la sensazione è quella di fare la storia.
La guerra è una dose di verità in vena. Crudele che ti mangia l’anima e che ti ama fortissimo, non lo so come è possibile ma più sei vicino al dolore e più risuona l’amore. È tutto così fragile e temporaneo che i momenti si vivono con il cuore e l’anima aperta verso tutto e tutti. Le anime spalancate come la porta del negozio di pennelli di Kharkiv. Allora chissenefrega se perdo la metro e alla mail magari ti rispondo domani, ora brindo alle dieci del mattino al primo studio-visit della giornata perché anche oggi sono viva io, sei vivo tu e lo studio esiste ancora con le opere che custodisce. Come una droga, la guerra ti entra in vena e dopo che ha iniziato a circolare nel corpo e l’adrenalina pulsa insieme al sangue, allora i pensieri si armonizzano su livelli di amore e di dolore così intensi che quando torni tutto è lento, stupido e inutile. O almeno questa è la sensazione di chi la guerra è andata a visitarla, per chi la abita sono sicura che sarà molto diverso.
Giorno 6 – Studio-visit in guerra
Sono venuta in Ucraina per conoscere la scena artistica locale, fare studio-visit, incontrare gli artisti, i colleghi e le colleghe e immaginare progetti culturali internazionali. Networking, solo in una versione più pericolosa del solito. Non me lo aveva detto mica nessuno che la Sofia che è partita una settimana fa ora non esiste più, che quando vedi la guerra per la prima volta è come se perdessi la verginità e poi ti tocca renderti conto di chi sei e di quale spazio occupi nel mondo. Dopo che vedi la guerra adulto lo diventi per forza, anche se hai otto anni e giochi a palla. Siccome io a palla ho avuto la fortuna di giocarci per tanti anni e di non dover pensare ad altro che correre, ora bisogna che anche io protegga la partita a palla di qualcun altro. Quindi networking, quindi curatrice, quindi fare progetti internazionali con artisti ucraini. Io non lo so se gli artisti ucraini fossero già bravi prima della guerra, forse sì ma io qui prima non c’ero mai stata, quello che posso dire è che – loro malgrado – tra un’esplosione e l’altra, la guerra li ha resi dei maestri. Non ci sono più ricerche che si possono permettere di viaggiare in superficie, di galleggiare fra una tematica e l’altra e di sfiorare i materiali. Fuori dalla finestra dello studio c’è la guerra, la gente muore e i bambini salutano i papà alla stazione del bus per andare al fronte. Come un incantesimo inquietante, tutte queste energie rientrano dalla finestra dello studio e si impossessano della mano dell’artista per produrre opere straordinarie. Uso il termine impossessarsi perché la guerra non è una tematica che gli artisti affrontano, è a tutti gli effetti la co-autrice delle opere. Quando fai gli studio-visit e gli artisti ti mostrano i lavori e inizi a confrontarti, poi devi chiacchierare anche con la guerra che anche lei ha le sue cose da raccontarti. Ho riscontrato che questa co-autorialità fra artista e guerra ha nella produzione artistica la conseguenza di essere un crudele inno alla vita. Sembra paradossale ma è così.
Qui le tensioni ricorrenti fra gli artisti ucraini che abitano la guerra:
1. Sono ossessionati dalla memoria. C’è una generale postura compulsiva alle date e al ricordo preciso. Dimenticare è un peccato perché quando sei morto il mondo si scorda di te.
2. Presenza dei sogni e dell’onirico. Non importa se dipingono nel Medioevo, nel Novecento, a metà anni 2000: se la realtà fa schifo, allora ne inventano di altre.
3. Infanzia. Se la guerra è il fallimento totale degli adulti, allora gli artisti tornano ai bambini, all’infanzia, a chi puro e innocente lo è per forza. Morte e vita si rincorrono sempre.
4. Disegnano tantissimo, forse perché un foglio e qualche pastello te li porti appresso facilmente, anche se devi correre veloce.
5. Molti di loro sono ossessionati dal sottosuolo e dalla terra. Io che la guerra sono andata solo a visitarla ero ossessionata dal cielo, che per me era tramonto e alba con gli amici, mentre qui avevo paura del cielo perché è da lì che vengono i missili.
6. Tanti lavorano con il sonoro, perché la guerra oltre che negli occhi, ti entra nelle orecchie.
7. Mediamente sanno come costruire un drone. Se non lo sai fare te lo insegnano, anche a un techno-party il venerdì sera, perché se i droni li sai fare magari in prima linea ci va qualcun altro.
Kyiv, giorno 7 – Le paure degli uomini
Sul pullman di ritorno siamo tutte donne, alcune anziane altre meno, molte mamme e tanti bambini. Gli unici pullman su cui possono salire gli uomini sono quelli verso la guerra. Sì, perché in Ucraina c’è la legge marziale, nessun uomo lascia lo stato e tutti (almeno fino ai sessantacinque anni di età) possono essere mobilitati. Essere mobilitati, mi spiegano, significa che ti arriva una lettera a casa e in tre mesi se ti va bene o in uno di norma ti insegnano a fare la guerra. Ora che sono ormai dieci anni dall’inizio della guerra e due dall’invasione di larga scala gli uomini servono sempre di più, un po’ perché i militari sono stanchi, un po’ perché altri sono stanchi e morti. Allora la polizia ogni tanto decide di mobilitare la gente per strada. Tu stai camminando per la capitale e la polizia ti ferma e ti manda a fare la guerra, magari volevi solo bere un caffè o leggere il giornale all’aria aperta perché è domenica, ma ora devi fare la guerra. Qui gli uomini sembrano tutti grandi, forti e palestrati eppure io non ci credo che non hanno paura. Forse se sei grande, grosso e palestrato impari a nasconderla bene e le pressioni della società ti obbligano a chiuderla in un cassetto e buttare via la chiave. Certe emozioni non puoi proprio permetterti di provarle, perché devi salvare la famiglia, la madre e la patria. E se hai paura poi ti ricordi che i codardi non piacciono a nessuno e che non esiste neanche un monumento ai vigliacchi, allora deglutisci ti fai un tatuaggio sul braccio e appendi la bandiera della nazione. Forse mi sbaglio, io d’altronde un paese in guerra sono venuta solo a visitarlo e ci sono venuta da donna.
(Exibart, 23 marzo 2025. L’articolo è stato tradotto dall’inglese da Sam Vassallo. La sua versione originale è stata pubblicata su NERO. Fotografie su: https://www.exibart.com/attualita/una-settimana-per-imparare-la-guerra-viaggio-di-una-curatrice-in-ucraina/)
da Erbacce
Lakes International Comic Art Festival (UK) in collaborazione con il fumettista palestinese Mohammad Sabaaneh e con il supporto promozionale di Cartoonists Rights ha pubblicato Safaa and the Tent, il diario della fumettista di Gaza Safaa Odah. La traduzione è di Nada Hodali.
Safaa ha conseguito un master in psicologia che si intreccia con il lavoro di fumettista. Oltre a rivolgersi a un pubblico palestinese, il suo desiderio è di raggiungere altre persone in tutto il mondo e generare un impatto positivo.
Create tra ottobre 2023 e dicembre 2024, alcune delle vignette del libro sono state disegnate su una tenda. Dall’inizio della guerra a Gaza, Safaa è stata sfollata più volte, ma continua a disegnare e a pubblicare ogni volta che può sui suoi social. In Italia è pubblicata da marzo 2024 su Erbacce nella rubrica Una tenda in Palestina in cui abbiamo raccolto fumetti, video, interviste e articoli della psichiatra palestinese Samah Jabr da lei illustrati.
Secondo il fumettista Joe Sacco «alcune delle immagini più potenti e toccanti provenienti da Gaza, che non siano foto, si trovano in questa incredibile raccolta di disegni di Safaa Odah».
«Safaa si è opposta alla brutalità del genocidio con sincerità senza filtri», osserva Mohammad Sabaaneh. «Attraverso un istinto crudo, ha smantellato la narrazione ufficiale che cercava di disumanizzare i palestinesi, trasformando la sua arte in una potente confutazione. Quando la carta è diventata rara come il pane, la sicurezza e il conforto, non si è fermata: le pareti della sua tenda sono diventate la sua nuova tela, a testimonianza di una resilienza che non poteva essere cancellata. Noi palestinesi sappiamo bene che Naji al-Ali, il leggendario fumettista assassinato a Londra nel 1987, ha iniziato il suo percorso artistico anche sul muro della sua tenda».
• Il libro Safaa and the Tent è disponibile su Etsy Store del Lakes International Comic Art FestivalLakes International Comic Art Festival (UK) in collaborazione con il fumettista palestinese Mohammad Sabaaneh e con il supporto promozionale di Cartoonists Rights ha pubblicato Safaa and the Tent, il diario della fumettista di Gaza Safaa Odah. La traduzione è di Nada Hodali.
Safaa ha conseguito un master in psicologia che si intreccia con il lavoro di fumettista. Oltre a rivolgersi a un pubblico palestinese, il suo desiderio è di raggiungere altre persone in tutto il mondo e generare un impatto positivo.
Create tra ottobre 2023 e dicembre 2024, alcune delle vignette del libro sono state disegnate su una tenda. Dall’inizio della guerra a Gaza, Safaa è stata sfollata più volte, ma continua a disegnare e a pubblicare ogni volta che può sui suoi social. In Italia è pubblicata da marzo 2024 su Erbacce nella rubrica Una tenda in Palestina in cui abbiamo raccolto fumetti, video, interviste e articoli della psichiatra palestinese Samah Jabr da lei illustrati.
Secondo il fumettista Joe Sacco «alcune delle immagini più potenti e toccanti provenienti da Gaza, che non siano foto, si trovano in questa incredibile raccolta di disegni di Safaa Odah».
«Safaa si è opposta alla brutalità del genocidio con sincerità senza filtri», osserva Mohammad Sabaaneh. «Attraverso un istinto crudo, ha smantellato la narrazione ufficiale che cercava di disumanizzare i palestinesi, trasformando la sua arte in una potente confutazione. Quando la carta è diventata rara come il pane, la sicurezza e il conforto, non si è fermata: le pareti della sua tenda sono diventate la sua nuova tela, a testimonianza di una resilienza che non poteva essere cancellata. Noi palestinesi sappiamo bene che Naji al-Ali, il leggendario fumettista assassinato a Londra nel 1987, ha iniziato il suo percorso artistico anche sul muro della sua tenda».
• Il libro Safaa and the Tent è disponibile su Etsy Store del Lakes International Comic Art Festival
da La Sicilia
Catania. In occasione della Giornata internazionale della donna La Città felice, La RagnaTela, il Coordinamento donne Cgil, Femministorie e Udi Catania organizzano due mostre particolari nella sede della Comunità di Sant’Egidio, con ingresso da via Garibaldi 89. Si tratta di centinaia di opere di “arte postale”, o “mail art”, lavori di piccole dimensioni, poco più grandi di una cartolina, creati da artiste/i e da persone comuni che si sono impegnate sui temi specifici lanciati negli ultimi due anni: “Trame di vita trame di pace” (2024) e “Donna Vita Libertà” (2023), le parole d’ordine della rivolta delle donne iraniane.
Le opere, “esposte” lungo le pareti del salone che le ospita, appese a grappoli, legate da fili colorati, si possono anche ammirare ingrandite nei video. […] Le mostre sono curate da Katia Ricci e Rosy Daniello con le associazioni La Merlettaia di Foggia, Le Città vicine, e l’Alveare di Lecce.
L’arte postale è una forma artistica nata negli anni Sessanta, e poi sviluppatasi nel decennio successivo, basata sulla libera comunicazione, sulla reciprocità e sullo scambio creativo senza censure. Chiunque ha la possibilità di esprimersi attraverso piccole opere che vengono scambiate per posta creando così una rete di relazioni e rapporti tra il mittente/artista e il destinatario/spettatore. A partire dal 1974 alcune donne, in Inghilterra, hanno cominciato a usare anche vecchi imballaggi, a riciclare oggetti d’uso comune e ad esprimersi in omaggio alle diversità, in particolare a quella femminile, rivendicando un uso politico dell’arte contro ogni genere di discriminazione e per la giustizia sociale. La mail art – dicono le protagoniste – «è una trincea artistica contro le mode, i condizionamenti e tutte le forme di potere». E non è un caso che sia stata utilizzata da molti artiste/i perseguitate/i in varie parti del mondo, da quanti si opponevano alle dittature in Sud America agli oppositori dei regimi nei Paesi dell’Est.
Tema del 2024 è quello della pace nell’attuale drammatico contesto di guerra. “La guerra non ha un volto di donna” è il titolo di un libro di Svetlana Aleksievič che dice che «le donne sono legate all’atto di nascita, alla vita». Tante le immagini proposte dalle piccole opere della mostra “Trame di vita trame di pace”. Ci sono collage, poesie, fiori che nascono dalle ferite della terra, carte geografiche rammendate, mandala di tessuti, cactus fioriti, fili che tramano merletti di donna, scarpe di carta, mani che si stringono, bambini di tutti i colori. Le opere di “Donna Vita Libertà” sono dedicate alla rivolta delle donne iraniane che «apre ad un mondo nuovo in cui la pace è il pilastro di una società improntata ai valori materni, modello di civiltà per donne e uomini». Opere forti, drammatiche. Donne che si tagliano ciocche di capelli, forbici che squarciano chador multicolori, corpi nudi, feriti, legati da un filo rosso, e poi primi piani di donna, e altre donne che corrono libere a braccia aperte sulla spiaggia, che si prendono per mano, che alzano il pugno chiuso sul volto magnifico dell’Annunciata di Antonello da Messina.
«Una mostra – sottolinea Anna Di Salvo, una delle organizzatrici – importante per il suo valore relazionale dal momento che mette insieme donne da ogni parte d’Italia e perché favorisce la circolazione delle opere attraverso i centri in cui vengono ospitate».
(La Sicilia, 7 marzo 2025)
Nota. È ancora in corso, fino al 15 aprile, la raccolta della Mail art 2025, dedicata a “Amore e/è politica”: https://www.libreriadelledonne.it/altri_luoghi_altri_eventi/mail-art-amore-e-e-politica-entro-il-15-aprile-2025/ (Ndr sito)
da L’Altravoce il Quotidiano
Genoeffa Cocconi è la madre dei sette fratelli Cervi – Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore – fucilati a Reggio Emilia uno dopo l’altro dai fascisti repubblichini in una fredda mattina del 28 dicembre 1943. Lei morirà di crepacuore un anno dopo, il 14 novembre 1944. Di lei si sa poco o niente e le storiche e gli storici in questi ottant’anni dalla sua morte l’hanno lasciata nell’insignificanza e nell’oblio. Ma una donna, un’artista anche lei di Reggio Emilia, Clelia Mori, l’ha riportata in vita dopo averla incontrata in una fotografia al Museo Cervi ed essersene innamorata. Visto che lì di lei «non c’era un grande ritratto a figura intera» decise che l’avrebbe disegnato lei. Per due anni l’ha guardata nella piccola foto con la lente d’ingrandimento per disegnarla, provare a capire di più le sue gioie e il suo dolore e trovarne una forma. Ha incominciato a pensare a come sarebbe stata male se fosse successo a lei di vedere morire suo figlio e intanto la disegnava con sguardo libero di donna, staccandola dal contesto familiare e dandole esistenza autonoma. I suoi disegni sono diventati dodici e ha incominciato a esporli in giro per l’Italia, ieri, venerdì, sono approdati a Roma alla Casa della Memoria e della Storia. Con la sua arte ha riscattato la sua morte, assumendosi l’autorità di darle un nuovo senso e riconoscere in lei «l’ottava vittima dei fascisti della famiglia Cervi» e una donna della Resistenza. Una Resistenza, la sua come quella di tante altre donne rimaste nell’oblio, che passa non dalla lotta armata ma dall’aprire, dopo l’8 settembre, la porta della propria casa a sbandati e disertori, dando così «forse, inizio alla Resistenza». Una mostra, la sua, fatta per «cominciare a cambiare il punto di vista da cui si guarda Genoeffa e le molte donne sconosciute che hanno fatto a modo loro la Resistenza, che quasi nessuno e nessuna è andata a cercare». Facendone l’ottava vittima dei fascisti dei Cervi reinterpreta il concetto di “vittima del fascismo” ancora troppo legato a quello di “morire sparati” e ripensa l’idea, ancora troppo presente nell’antifascismo reggiano e non solo, secondo cui «per essere inseriti in un libro sulla Resistenza delle donne si debba aver imbracciato le armi ed essere andate, come e con gli uomini, sui monti». Prova ne sia la “rivalutazione” tardiva delle staffette e il fatto che «una versione sul differente apporto femminile alla Resistenza non è ancora del tutto presente nell’antifascismo reggiano e forse non solo in quello». Genoeffa è stata uccisa dalla «ferocia fascista» che sicuramente nessun’altra donna ha conosciuto nel modo come l’ha conosciuta lei. Il suo dolore, al di là di ogni immaginazione, porta l’artista a farne «una Maria laica». Un dolore abnorme per quei figli che, come ogni donna, ha portato in grembo per nove mesi, li ha partoriti, accuditi, accompagnati nella crescita, educati, vestiti, nutriti facendoli diventare gli uomini che sono stati, amanti della lettura, della conoscenza, della libertà e della giustizia. Lei che «discuteva sempre le prediche del prete quando la famiglia tornava dalla messa domenicale tra i campi». Per un anno portò il peso di quel dolore, accudì il marito malato a cui dopo essere uscito dal carcere disse dei figli due mesi dopo, si fece carico delle quattro nuore e di undici nipoti. Quando i fascisti, dieci mesi dopo la fucilazione dei figli, per la seconda volta le bruciarono il fienile disse «ci vogliono proprio fare morire di fame» e cominciò a stare male fino a morire un mese dopo. Genoeffa, grazie a Clelia Mori, ha trovato il posto che le spetta nell’arte e tra le donne, si aspetta che lo trovi anche nella storia della Resistenza e nelle celebrazioni di quest’anno per gli ottant’anni dalla liberazione dai nazifascisti.
(L’Altravoce il Quotidiano, rubrica “Io Donna”, 1° marzo 2025. L’Altravoce il Quotidiano è il Quotidiano del Sud che ha cambiato nome)
da Il Corriere della Sera
Nella coda delle celebrazioni per i cent’anni del movimento di André Breton, Palazzo Reale di Milano
Nel 2024, anno delle celebrazioni ufficiali per i cent’anni del Surrealismo, l’ondata delle riscoperte aveva (finalmente) toccato Leonora Carrington (1917-2011), Ithell Colquhoun (1906-1988), Remedios Varo (1908-1963), Dora Maar (1907-1997), Dorothea Tanning (1910-2012): artiste irrequiete ma consapevoli del proprio talento, alle quali quel movimento surrealista del poeta André Breton e di Max Ernst, Salvador Dalí, Man Ray, Jean Cocteau, Georges Bataille sembrava andare terribilmente stretto.
Proprio come Leonora, Ithell, Remedios, Dora e Dorothea anche Leonor Fini (Buenos Aires, 30 agosto 1907 – Parigi, 18 gennaio 1996), protagonista della personale che si inaugura il 26 febbraio al Palazzo Reale di Milano (Io sono Leonor Fini, a cura di Tere Arcq e Carlos Martín) riconquista con questa mostra (nata sempre sull’onda del centenario) quel ruolo che in qualche modo le era stato troppo a lungo negato: forse per quel carattere spinoso e orgoglioso che traspare dall’Autoritratto con il cappello rosso (1968); forse per quelle sue figure troppo inquietanti e troppo oscure per un salotto alto-borghese (Stryges Amaouri, 1947); forse per quell’erotismo molto fluido e transgender (Rasch, Rasch, Rasch, meine Puppen warten!, 1975).
L’universo di Leonor Fini è l’universo trasgressivo di Démons et sortilèges (1943), dell’Escalier dans la tour (1952), della Cérémoine (1960), della Grande Racine (1943), di Crâne de poisson africain (1945-1950). Dopo la Biennale di Venezia (Il latte dei sogni) che nel 2022 l’aveva ospitata nel Padiglione Centrale ai Giardini e dopo la mostra Insomnia al Mart di Rovereto nel 2023 che l’aveva messa a confronto con un altro visionario come Fabrizio Clerici (1913-1993), Palazzo Reale propone la definitiva riscoperta dell’universo di Leonor attraverso un centinaio tra dipinti (una settantina), disegni, fotografie, costumi, libri, video che di fatto superano ogni possibile confine di stile, genere, ruolo, convenzioni. Con la sua dedica una retrospettiva alla pittrice che indagò e stravolse genere, identità, appartenenza, ribaltando i ruoli di uomo e donna in società e sulla tela
pittura, pervasa di una nuova mitologia costellata di creature inquietanti e fantastiche (L’ange de l’anatomie, 1949), Leonor rilegge la realtà attraverso una lente intrisa di sensualità, magia e potere. Mettendo in scena un potere tutto o quasi al femminile che trova degna rappresentazione in un’altra opera simbolo della mostra milanese, Femme assise sur un homme nu (1942), dove una donna vestita con un sontuoso abito di velluto torreggia letteralmente seduta su un uomo nudo addormentato, sullo sfondo di un paesaggio neo-rinascimentale: un modo per invertire i ruoli, negando le tradizionali caratteristiche maschili (potere, virilità, stoicismo) ed esplorando allo stesso tempo le tematiche della dominazione e della sottomissione.
Nata a Buenos Aires da Herminio Fini, argentino di origini italiane (proprietario di numerose haciendas) e Malvina Braun, triestina appartenente all’alta borghesia ebraica, all’età di due anni Leonor si rifugia con la madre a Trieste per fuggire da un padre oppressivo. I molteplici tentativi con cui quest’ultimo prova a riportarla in Argentina nel corso degli anni la spingono a camuffarsi da ragazzo, gettando le basi per i suoi travestimenti e le sue inversioni di genere. Durante un breve “passaggio” milanese Leonor conoscerà Carlo Carrà, Gio Ponti (che le commissiona alcuni disegni per la rivista “Domus”), Mario Sironi, Giorgio de Chirico, e poi Achille Funi, con cui stringe una relazione sentimentale e grazie al quale scopre l’arte classica e la pittura quattrocentesca.
Sarà proprio de Chirico che le consiglierà di trasferirsi a Parigi e che le farà conoscere i surrealisti. Pur sviluppando legami significativi con artisti di spicco come André Breton, Luis Buñuel e Max Ernst, Fini rifiuterà l’invito a unirsi ufficialmente al gruppo, rigettando l’idea tradizionale che Breton e gli altri avevano delle donne. Comincia così a lavorare per la stilista italiana Elsa Schiaparelli (per lei inventerà la boccetta del profumo «Shocking» ispirata al busto dell’attrice Mae West) e a disegnare costumi per il balletto, il teatro e il cinema. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, Leonor Fini lascia Parigi e si rifugia in un primo momento nella casa di campagna di Max Ernst e Leonora Carrington (all’epoca amanti assai turbolenti), poi a Montecarlo. Dove conosce il console italiano Stanislao Lepri, che abbandonerà la carriera diplomatica per la pittura. La loro storia d’amore durerà fino alla morte di lui nel 1980, con un (breve) soggiorno a Roma, dove Leonor stringerà amicizia con Anna Magnani, Elsa Morante («Leonor unisce in sé due grazie: l’infanzia e la maestà»), Mario Praz, Carlo Levi, Luchino Visconti, Alberto Moravia.
L’arte di Fini (che guarda sempre ai grandi maestri come Piero della Francesca e Michelangelo e ai manieristi) è dunque un veicolo non solo per esplorare le sfide della condizione femminile, ma anche per contemplare la spiritualità e l’esoterismo. Un destino che ancora una volta avvicina Leonor Fini a Leonora Carrington (il titolo della Biennale di Venezia 2022 era una citazione di un suo libro di favole), un destino confermato dalla scelta di Palazzo Reale di dedicare proprio alla Carrington una grande retrospettiva che si inaugurerà a settembre 2025. Entrambe le artiste hanno fatto «da modello» per intere generazioni di artisti. Non a caso Leonor Fini – Italian Fury era il titolo della mostra che Francesco Vezzoli le aveva dedicato nel 2022 alla Galleria Tommaso Calabro («The Italian Fury» era uno dei soprannomi di Leonor): «Fini è l’antidoto a questo momento storico dominato dal mercato: – aveva spiegato Vezzoli – è identità, eccentricità, messa in scena, tutto ciò che il mercato non può controllare. È insieme la Contessa di Castiglione, Eleonora Duse, Marina Abramović: anticipando la contemporaneità, la sua opera d’arte era la performance della sua esistenza».
da Doppiozero
Paola Mattioli, classe 1948, milanese, ha un posto singolare e di rilievo nella fotografia “al femminile”. Intervistarla è l’occasione per sondare i rapporti tra impegno sociale e politico, femminismo e teoria della fotografia. La sua formazione la segnerà per sempre ed è paradigmatica di un percorso fotografico di grande interesse. Mattioli infatti incrocia e tiene insieme i suoi studi filosofici incentrati sulla Fenomenologia con l’apprendistato fotografico a fianco di Ugo Mulas, cioè al maestro dell’analisi linguistica del medium fotografico. La chiave è acutamente indicata da Mattioli nel tema dello sguardo, che non è solo la visione ma è relazione, è guardare ed essere visti, è pulsione ed è responsabilità. Lo sguardo è al centro della psicoanalisi così come dell’antropologia, del femminismo così come della fotografia, della relazione sociale così come della politica.
Intervistare Paola Mattioli significava per noi chiederci come sono stati generazionalmente e come sono affrontati oggi questi argomenti nell’ambito della fotografia artistica, cioè non solo e non tanto – c’è anche questo in Mattioli – nel soggetto rappresentato, come accade nel reportage, ma anche nella riflessione e nella pratica della forma. Così, in estrema sintesi, se le fotografie probabilmente più famose a cui è legato il nome di Paola Mattioli sono da un lato la serie delle Fotografie del no, dall’altro l’acuto e fortunato Ultimo ritratto di Giuseppe Ungaretti, la chiave – non a caso bifacciale e rotante – ne è l’Autoritratto appeso a un filo.
Merito non ultimo di Mattioli è quello poi di essere entrata in fabbrica, come si diceva una volta, non solo con la macchina fotografica ma, appunto, con il pensiero fotografico. Come la questione politica trovi forma nella fotografia è questione sempre viva e urgente.
Su di lei è uscita una monografia scritta da Cristina Casero intitolata Paola Mattioli, sguardo critico di una fotografa (Postmedia, 2016); ha inoltre recentemente pubblicato una riflessione sul ritratto, e non solo, intitolata L’infinito nel volto dell’altro (Mimesis, 2023).
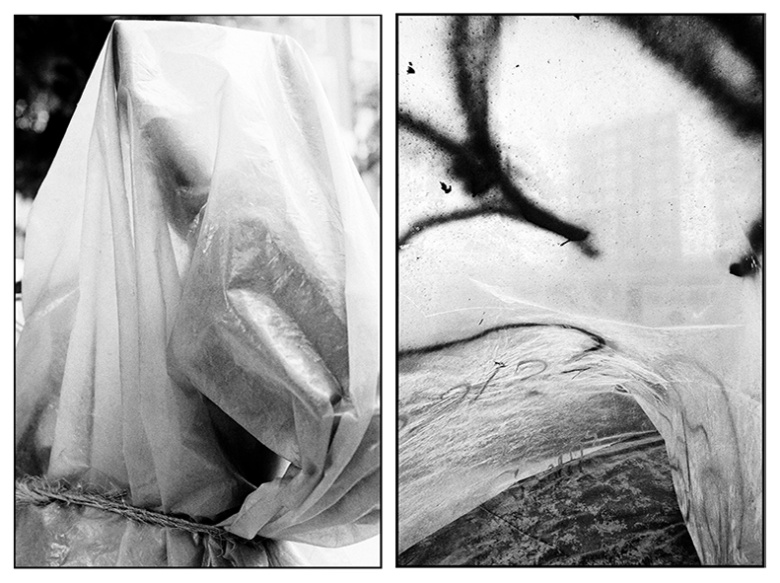
EG: Come hai incominciato?
PM: Per sbaglio! Ero iscritta a Filosofia e il primo esame si faceva con Gillo Dorfles perché dava buoni voti, e cominciare il libretto con un bel 30 e lode fa piacere a tutti. Faceva fare una tesina scritta e io l’ho fatta sulla fotografia, forse anche perché era uscito da poco il libro di Walter Benjamin. Ho riassunto quel dibattito ma mi sono detta: «Certo che vedere com’è, sarebbe meglio». Così ho avuto l’occasione di contattare i Mulas: Nini, alla quale ho spiegato la mia richiesta, mi ha detto: «Guarda, Ugo non c’è, vieni domani». Sono andata all’indomani e Ugo mi ha presentata come la nuova assistente! Ho avuto un tuffo al cuore. Non sapevo neanche che le fotografie si bagnassero nell’acido, zero, e lui è stato molto generoso con me perché se andava fuori a fotografare, io andavo con lui, se stampava, stampavo con lui, e quindi è stata – purtroppo abbastanza breve perché lui si è ammalato presto – un’esperienza entusiasmante arrivare in mezzo a una intelligenza, capacità, serietà, spessore come quelli.
E si può dire che queste prime immagini che hai scelto abbiano un rapporto con questa esperienza?
Direi di sì, perché il mio tema preferito nella gran parte dei lavori, è il tema del vedere. Quindi il cellophane che ti permette di vedere attraverso, che intercetta lo sguardo, o dall’interno o dall’esterno, che ti fa vedere come cambiano le forme, come una cosa velata cambia fisionomia.
Come ti è venuta l’idea della plastica? L’avevi vista da qualche parte o ti è venuta per qualche via?
Credo che mi sia venuta dall’invasione della plastica. Poi sicuramente dal lavoro di Christo, che avevo visto con Mulas.
Eh già, alla grande manifestazione del Nouveau Réalisme in Piazza del Duomo.
Sì, Mulas mi portava spesso alle mostre e mi faceva conoscere l’arte contemporanea. Capitava per esempio che Nini e Ugo commentassero tra loro una fotografia magari dicendo: «È magrittiana», e io poi cercavo subito di informarmi su che cosa volessero dire, nascondendo la mia ignoranza.
Vengo da una famiglia di avvocati e in casa si respirava una cultura giuridica, resistenziale, ma non molto aggiornata sugli ultimi sviluppi dell’arte contemporanea…
Questa mia del Cellophane è diventata una serie che voleva essere una interrogazione sul tema del vedere. Come anche quest’altra.

L’Autoritratto.
Questa fotografia risente dell’incontro con il nuovo femminismo degli anni ’70. Mia mamma era una femminista dell’emancipazione, quindi io trovavo in casa tanti libri e ci ho messo un po’ ad avvicinarmi al nuovo femminismo perché mi sembrava di averlo succhiato col latte. Quando ho fatto insieme ad Anna Candiani le Immagini del no, il grosso delle manifestazioni avveniva alla Palazzina Liberty, che Dario Fo aveva occupato come teatro, e tutto attorno si svolgevano cose varie. Lì ho incontrato la nuova ondata del femminismo. Per esempio un lavoro molto bello che era appeso lì, dove ognuno andava a portare il suo banchetto e faceva quello che voleva, in una situazione molto libera, era di due artiste, Diana Bond e Mercedes Cuman, intitolato Le pezze. Le avevo trovate straordinarie perché facevano un’operazione molto forte: avevano appeso un bucato, e messo fuori dalle mutande quello che ci stava dentro! Le ho conosciute, sono andata a vedere un po’ i loro lavori e ci siamo collegate: è venuto fuori il “Gruppo del mercoledì”, che poi ha pubblicato il libro Ci vediamo il mercoledì, gli altri giorni ci immaginiamo, che ha messo insieme i nostri lavori. Non era esattamente un gruppo di autocoscienza ma si potrebbe definire di autocoscienza attraverso le immagini.
Cioè cosa facevate?
Una faceva un lavoro, lo presentava e lo discutevamo. E poi una diceva: «Mi piacerebbe fare un lavoro su questo, tu poseresti per me?» Cioè c’è stato un intreccio interessante che ha potenziato molto i lavori l’una dell’altra. Poi, sai, la scadenza dello stampare un libro ci ha galvanizzate. Le pezze sono in quel libro e anche Autoritratto è nel libro.
Ti interrompo, perché, anche se non hai scelto per questa occasione una Immagine del no, mi interessa chiederti veramente in estrema sintesi come vedi la distinzione tra il reportage, a cui quella serie potrebbe essere ricondotta, e invece un lavoro artistico?
Le Immagini del no è nato come lavoro di reportage, è stato forse il mio primo progetto. È vero che Anna Candiani era molto più brava di me come reporter, era un’amica e io le avevo detto: «Senti facciamolo a due mani», anche perché era un lavoro intenso, in un mese e mezzo bisognava coprire un po’ tutto. Lei era più brava sul reportage, io sono più attenta alle lettere, al no, no, a questa ripetizione. Lo scrive bene Gerry Badger, quando con Martin Parr nel 2010 ha scelto le Immagini del no tra i cinque libri sulla rivolta per il suo The protest box: dice che aveva trovato molto interessante questa ripetizione dei no, questa modalità che ti conduce quasi alla Poesia Visiva. In questo senso potrei risponderti che è un misto tra foto di reportage e foto che ha, insomma, una tensione alla ripetizione.
Nel tuo libro L’infinito nel volto dell’altro scrivi proprio che la tua attenzione non è nella rappresentazione dell’evento in sé ma che quello ti fa partire per riflessioni che si aggiungono.
Io sono rimasta molto legata al no, perché il no in fondo è la prima cosa che un bambino neonato strilla. Ti identifica e ti permette di non essere acquiescente. Il no è uno stop, un rifiuto, una resistenza, è politica: «Questa cosa non la voglio, questa cosa non deve passare». Il no è un senso di coscienza civile, di coscienza politica. Forse questo è segnato dalla storia delle donne, che hanno dovuto dire dei grandi no.
Veniamo all’Autoritratto, che è molto particolare. Descriviamolo perché dalla riproduzione si può fraintendere.
È nato un po’ diverso, perché stavo facendo la serie sulle donne che si intitola Faccia a faccia, donne allo specchio, per cui a un certo punto mi sono detta che dovevo farla anche su di me, per giustizia, cioè non per esibirmi ma per applicare questo problema non solo sulle altre ma anche su di me. Così è venuta fuori questa foto, l’ho ritagliata e l’ho appesa con un filo bianco vicino a una finestra e l’aria dalla finestra la faceva girare e muovere, in movimenti in cui io ritrovavo i miei gesti del fotografare. Allora l’ho rifotografata, perché vedi che lei ha il filo bianco. A un certo punto questa, che è la numero 6 di quella serie, si è autonomizzata. Un’amica, Elisabetta Longari, a cui volevo regalarla, mi ha detto: «Ma perché non la stampi da tutte e due le facce e non la riappendi col filo?» È stata un’ottima idea, che ho adottato.
Allora, qual è il punto? È che l’obiettivo non è nero, come di solito è un obiettivo che raccoglie la luce, bensì con un po’ di carta d’argento è diventato bianco e quindi illumina. In questo senso è sul vedere, perché di solito la macchina fotografica succhia la luce, non è una torcia.
È molto interessante anche l’alone che c’è intorno.
L’alone è perché l’avevo ritagliata con una forbice a zig-zag. È casuale ma ha funzionato, perché quello era a fondo bianco, che mosso dà una sorta di alone.
Mi pare inoltre che ti nascondi dietro la macchina fotografica in una maniera insistita.
Be’, io sono un po’ timida e stare dietro la macchina mi ripara.
È proprio “ciclopica”, assume un’aria anche mitologica.
Non ci avevo mai pensato.

Passiamo alla terza fotografia, Statuine. Anche in questo caso ti chiedo se hai preso ispirazione da qualche parte, da qualcuno, per parlare delle circostanze e anche un po’ di eventuali fonti di ispirazione.
Sì, dalle bambole Lenci, dalle statuine degli anni ’30 e ’40. E poi è un po’ influenzata da Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto, al quale ho aggiunto il fatto che, se una persona non ti guarda, non incrocia lo sguardo, può diventare una scultura.
Avevo fatto vedere queste foto a Giovanna Calvenzi, che era la photo editor di “Amica”, e lei ha proposto di riportarle alla storia della moda. Così, invece che in casa con mia figlia, ho potuto avere una modella professionista e un appoggio su tutti gli aspetti del set e della produzione. Prendevo un panno di velluto nero, ci facevo un taglio e vi facevo passare la testa, giocando sul fatto che il velluto mangia la luce. Era un po’ come scontornare e soprattutto mi piaceva collegarmi a quelle sculturine. Sembrano degli oggetti, è un rapporto tra fotografia e scultura.
Poi, lavorando con una truccatrice e un assistente, diventa molto più raffinata e sofisticata, perché la scultura deve chiudere il volto. Avevo studiato gli anni ’30 e ’40 per capire come chiudevano le teste. Ed è di nuovo lo sguardo, un ragionamento sullo sguardo che non ti guarda, che fa diventare la figura una scultura.
È un dittico voluto come tale o solo una selezione dalla serie?
Sì, è una selezione dalla serie, perché mi è sembrato che una non bastasse, che si dovesse vedere che non è causale il fatto che non ti guarda, anzi è proprio l’argomento.
Lo chiedo anche perché qui una guarda in alto, l’altra in basso, una sembra estatica, l’altra meditativa…
Infatti a un certo punto mi sono chiesta: «Ma quello sguardo da Bernadette che ogni tanto vedo in mia figlia, le posso chiedere di farlo per me, di interpretare quel ruolo? Quando faccio un ritratto posso chiedere alla persona di stare dentro una idea che le propongo, a una immagine che voglio fare, di recitare in qualche modo?» Quindi non è esattamente un ritratto, è la proposizione di un’idea, di un pensiero. Insomma, queste due fotografie si sono molto sposate tra loro, perché ho un po’ la sensazione che le fotografie si chiamino tra di loro, anche al di là della tua volontà, un po’ da sole, per vicinanza o forse perché ribadiscono un pensiero.

Bene, poi riparleremo di moda. Passiamo alla seguente, che io trovo molto interessante, non solo per il soggetto curioso ma per il discorso che vi fai sopra.
Intanto io sono andata in Africa per merito di Sarenco. Non sapevo degli albini africani e un giorno in una casa vedo un bambino che corre con gli altri e ha una luce che non avevo mai visto in una faccia di bambino, era talmente forte che non riuscivo neanche a vedere bene i tratti. Quando gli ho chiesto da dove venisse questa luce, lui mi ha detto: «Ma non ti sei accorta che è albino?» No, non mi ero accorta, e allora mi ha cominciato a raccontare degli albini che sono considerati o magici o tragici, tragici perché sono delicatissimi. Io mi sono un po’ commossa, ho cercato gli albini e li ho fotografati. Volevo raccontare la luce che avevo visto, pur nella sofferenza, perché vedi lo sguardo di sofferenza.
Poi mi ha colpito enormemente il fatto che sembra un negativo, questo rovesciamento tra il positivo e il negativo e questa doppia…
Doppia negazione, doppio no!
No, doppia differenza, una differenza raddoppiata, perché non sono proprio un negativo. L’essere nero / ma anche bianco / ma non bianco come i bianchi… In effetti in strada quando tu incontri degli albini, non si capisce mai come li guardano, se li guardano come stregoni o se li guardano come persone da proteggere. Ma questo è lo sguardo africano, perché loro sanno di questa esistenza, ma pensa avere questa doppia differenza in un mondo in cui il sole ti mangia. E fotograficamente, anche in fotografia è un rovesciamento, cioè un negativo al posto di un positivo.
E se li stampassi in negativo non apparirebbe un positivo, resterebbe una differenza.
Resta una doppia differenza. E forse, essendo una donna, anche tripla!
Mi interessa ricollegarla al tuo discorso sul no: dunque è una negazione che mantiene la differenza, anzi la valorizza.
Certo, contro il pensiero binario, contro le opposizioni che non portano a niente.

Passiamo dall’albino al colore, se mi scusi la battuta, e alla moda.
La fortuna secondo me sta negli incontri. Tra il ritratto e la moda non c’è un confine preciso, perché è sempre fotografia di persone. Le immagini sono più curate, ci sono molti più soldi per la produzione e quindi ci sono più mani, più teste al lavoro, più disponibilità. L’incontro in questo caso è capitato proprio per quelle prime foto per “Amica” delle Statuine, in cui mi è stato proposto di lavorare con un redattore di grande valore, che si chiamava Mauro Foroni, aveva da insegnarmi tantissimo e soprattutto era d’accordo di pensare delle donne normali, o di ragionare sugli stereotipi. Ecco, la figura della Madonna è una convenzione, ma questa non è una Madonna col mantello blu. Le ho chiamate Madonne per via del fondo oro – e qua c’entra Aldo Mondino, che io vedevo fare i suoi fondi con queste foglie d’oro – ma in realtà sono come delle regine. Non mi dispiace provare a ridefinire delle tipologie iconografiche. E soprattutto quello che cercavo di togliere alla moda è l’ammiccamento, perché le modelle sono abituate a lavorare con i fotografi che tendono a spingerle all’ammiccamento sessuale, che è un po’ degradante. Farne delle persone, delle attrici, cercare di tirar fuori dalle modelle loro stesse come regine.

E concludi la tua scelta con un Capolavoro!
Una delle due si chiama Capolavoro, l’altra no.
Questo è un dittico che hai messo insieme per l’occasione?
Sì. La prima si chiama Capolavoro perché (ha ragione Raffaella Perna che dice che io sono particolarmente legata alle parole) mi divertiva fare una fotografia intitolata Capolavoro e allora ho cominciato a guardare sul dizionario: il capolavoro è l’opera più importante di un artista eccetera, oppure è la condizione per essere assunti per gli operai saldatori che siano capaci di fare il capolavoro, che è una saldatura che non lascia passare l’aria. Come si arriva a non lasciar passare l’aria e fare una buona saldatura? Con il ritmo, il ritmo della mano. Allora sono andata alla Breda dove hanno dei capolavori per poterli vedere e ho trovato questi oggetti che non avevo mai visto. È una questione di ritmo. Mi sono venute fuori delle immagini lievi, di un grigio cipria, di qualcosa che noi non conosciamo, non vediamo.
La seconda fotografia fa parte di un progetto per la Cgil su due città-fabbriche, Fabbrico e Dalmine, che aveva preso spunto dal libro di un’amica, Maria Grazia Meriggi, che mi era sembrato molto interessante anche per quello che dicevano gli operai intervistati. Devo dirti che erano gli anni in cui la vox populi berlusconiana diceva che gli operai non c’erano più. Allora a me è venuto di dire: «No – per tornare al no –, no, io non credo».
Nella fotografia gli elementi in primo piano sono alcuni strumenti di lavoro, delle frese di eleganza novecentesca (che richiamano il logo della Fiom), i cui ingranaggi ricordano il ritmo della saldatura.
Allora questo dittico, che mi è venuto in mente per Doppiozero, è sul ritmo, sull’aristocrazia operaia che conosce l’uso degli strumenti e il loro ritmo interno. È un omaggio alla cultura operaia.
Maria Grazia Meriggi | Un ritratto di Paola Mattioli
Silvia Mazzucchelli | Autoritratto sospeso a un filo
Da La Nuova Ferrara
The Dinner Party di Judy Chicago diventa l’opera simbolo della battaglia. Il suo tributo ai personaggi femminili della storia celebra anche Isabella d’Este
Se “The Dinner Party” di Judy Chicago può essere considerata, a detta di numerosi critici, l’opera artistica che meglio simboleggia il messaggio dell’arte femminista negli anni Settanta, anche Ferrara è presente in tale opera.
Fra le 39 donne che nella storia hanno più efficacemente rappresentato l’universo femminile figura infatti anche la ferrarese Isabella d’Este. Nata nel 1474, «Isabella liberale e magnanima», come la definì Ludovico Ariosto, fu reggente del marchesato di Mantova per quasi un anno durante l’assenza del marito Francesco II Gonzaga e per due anni durante la minore età del figlio Federico. Mecenatessa delle arti, ammirata anche per l’innovativo stile del vestire, venne considera «suprema tra le donne» da Matteo Bandello.
Il fermento Tornando agli anni Settanta, l’universo artistico – nonostante le spinte innovatrici del Sessantotto – si presentava, in Italia e nel mondo occidentale, come una realtà di impervio accesso per le donne. Al grido «Ribaltiamo il patriarcato!» le donne si destarono, sollevando un’ondata di proteste fino ad allora impensabile.
Dal Vecchio al Nuovo continente urlarono il loro dissenso contro chi le pretendeva subalterne, marginalizzate, indifese e silenti di fronte al dominio incontrastato del potere maschile che dettava legge. Dimostrarono invece di avere una forza non più nascosta, lottando per riscrivere la struttura non solo dell’arte ma dell’intera società partendo dalle fondamenta, con le artiste schierate in prima linea come promotrici e protagoniste del cambiamento.
Correva l’anno 1972, quando il sistema dell’arte iniziò a comprendere che le cose sarebbero
cambiate, anche se Judy Chicago (al secolo Judith Cohen) e Miriam Schapiro avevano già proposto il primo programma femminista. A partire dall’inizio del decennio i movimenti femministi avevano dato una robusta spallata alla realtà preesistente, puntando a cambiare radicalmente le vecchie regole del gioco. Le donne avevano trasformato quadri e sculture in gesti performanti, riportando l’attenzione su attività considerate secondarie come la ceramica o la scenografia teatrale, mettendo sotto accusa prassi, regole, convenzioni e assetti gerarchici cristallizzatisi nei decenni precedenti. Al grido ideale di “épater le bourgeois” avevano intenzionalmente disturbato la quiete della società perbenista, dimostrando all’opinione pubblica di non aver bisogno del permesso altrui per operare e di non essere figure secondarie in una società patriarcale superata dai tempi.
Fu proprio nel 1972 che Barbara Zucker e Susan Williams, volendo realizzare un luogo di
scambio, di confronto e di condivisione fondarono, nel cuore di New York, la Air Gallery, che costituì il primo “artist-run space”, come si evince dal ritratto del gruppo Air di Sylvia Sleigh. Ideata e realizzata dalle donne per le donne, la Air Gallery fu certamente la rampa di lancio per numerose artiste respinte da altre gallerie.
Come ricorda Zucker: «Non eravamo accettate dal mondo dell’arte, forse perché eravamo delle outsider. Quindi potevamo fare qualsiasi cosa ci pareva, e così abbiamo fatto. Ci eravamo date il permesso aveva detto no».
L’opera simbolo Se New York vedeva il fiorire di luoghi di aggregazione femminile fino ad allora sconosciuti, con la pubblicazione dello storico saggio di Linda Nochlin “Perché non ci sono state grandi artiste?” (“Artnews”, gennaio 1971), il dibattito raggiunse anche la West Coast. Il saggio, che diede vita alle discussioni sulla disparità di genere, ebbe notevoli ripercussioni come un robusto sasso gettato nell’acqua stagnante, al punto che, secondo l’iperbole utilizzata da Judy Chicago, “trasformò il mondo”.
Fu proprio Judy Chicago, trasferitasi dall’Illinois in California dove teneva corsi d’arte per donne al Fresno State College, a ideare – in collaborazione con Schapiro – un luogo di ritrovo per artiste dove lavorare in libertà. Nacque così il progetto Womanhouse: in soli due mesi un piccolo gruppo capeggiato da Judy e Miriam ripristinò un vecchio edificio abbandonato di Hollywood trasformandolo in uno spazio artistico di aggregazione femminile aperto a tutte le arti. La Womanhouse divenne così in breve tempo il principale laboratorio politico femminista della California.
Anche le artiste nere rialzarono la testa. Fra esse è degna di nota Faith Ringgold (che ci ha lasciato il 15 aprile 2024, a 93 anni) co-fondatrice del “Where We At” Black Women
Artists, un collettivo artistico femminile con sede a New York, associato al Black Arts Movement. Lo spettacolo inaugurale di “Where We At”, che presentava piatti soul (tipici della cucina afroamericana): fu presentato per la prima volta nel ’71 con otto artisti e fu ampliato a 20 nel ’76.
Quanto a Judy Chicago (che aveva scelto tale cognome in omaggio alla città natale ma, soprattutto, per compiere un gesto controcorrente) si era guadagnata un certo riconoscimento con le sue sculture minimaliste “a blocchi”. Una sua opera (“Rainbow Pickett), datata 1965, era stata esposta in una celebre mostra del ’66 al Jewish Museum Primary Structures. Judy fu una delle tre sole donne selezionate su oltre cinquanta artisti. È conosciuta soprattutto per la sua opera The Dinner Party (1974-1979), a cui hanno partecipato centinaia di volontarie, un tributo alla storia e alla memoria delle donne. Essa si presenta sotto forma di un grande tavolo triangolare, che comprende 39 posti apparecchiati, dove ogni posto rappresenta una figura storica femminile.
Fra le altre figure femminili sono rappresentate l’imperatrice Teodora, la regina Eleonora d’Aquitania, Artemisia Gentileschi, Georgia O’Keeffe, Emily Dickinson, appunto Isabella d’Este, Virginia Woolf e la suffragetta americana Susan Brownell Anthony, che disse «Non pagherò nemmeno un dollaro» al giudice che voleva multarla per aver votato in un periodo in cui l’espressione del suffragio per l’elezione del Congresso Usa non era consentita alle donne.
La performance
La nuova aria che spirava agli inizi degli anni Settanta non poteva lasciare insensibili di fronte a stupri e violenze di cui le donne erano spesso vittime silenziose, indotte sovente (come troppo spesso accade ancor oggi) a tacere per la vergogna, il senso di colpa o le regole convenzionali e familiari della società. Fra le artiste più sensibili a tale tema occupa un posto di rilievo Ana Mendieta.
Nata a Cuba in una famiglia dell’alta borghesia anticastrista, nel 1961, appena dodicenne approdò negli Stati Uniti con la sorella Raquelin. Dopo aver studiato al Liceo di Dubuque, nello stato dell’Iowa, si iscrisse nel 1967 all’Università del medesimo stato, seguendo corsi di arte primitiva e di culture indigene, nonché frequentando corsi di pittura e di arti intermediali. Motivata a combattere contro le ingiustizie subite dalle donne tramite la propria corporeità, si impose con la “Scena di stupro” del 1973. Dopo lo stupro e l’omicidio di Sara Otten, avvenuto nel suo stesso campus universitario, Ana chiamò studenti e docenti nel proprio appartamento per quella che sarebbe stata considerata una delle performance artistiche più visivamente traumatiche. Gli invitati arrivarono nell’appartamento di Mendieta e si trovarono dinanzi a una scena da brividi: una porta spalancata e una ragazza – Ana, che s’immedesimava in Sara – brutalmente denudata e sporca di sangue, esattamente come fu ritrovato il corpo esanime della studentessa assassinata. Lo scopo era evidente: Ana voleva sbattere in faccia ai presenti, alle autorità accademiche e all’intera società, lo stupro, la violenza e l’odio contro la donna.
Capì che occorreva sfruttare la potenza espressiva dell’arte con la presenza personale della performance per trasmettere un messaggio o una denuncia: in quel caso una condanna dello stupro e di ciò che ora definiamo femminicidio.
Femminicidio di cui, per un amaro quanto brutale scherzo del destino, fu forse vittima la stessa Mendieta, precipitata in circostanze controverse dal 34º piano nel settembre ’85 dopo una lite con il marito che fu processato ma, alla fine, venne assolto con una sentenza che suscitò molte perplessità.
Nel Belpaese E in Italia come andavano le cose? In una lettera inviata nel 1975 a Lucy Lippard, Ketty La Rocca illustrò le difficoltà e il pesante clima di un ambiente artistico segnato da forti disparità tra uomo e donna: «Ancora, in Italia essere una donna e fare il mio lavoro è di una difficoltà incredibile». La fatica di essere artista e donna di cui parla La Rocca, non era un malessere riconducibile all’individualità, bensì un fenomeno sociale, dato che a quel tempo la presenza femminile nelle grandi mostre, nei concorsi e nelle collezioni pubbliche e private era ridotta ai minimi livelli, rivelando una condizione di subalternità non più accettabile.
In questo quadro alcune artiste ripensano il proprio ruolo nella società e si decidono a rivendicare agibilità nei musei, nelle gallerie e nelle istituzioni, mettendo sotto accusa un sistema che le marginalizza, rivelandosi insensibile alle istanze dalle artiste donne, che non vengono adeguatamente sostenute neppure dai critici e dagli intellettuali più aperti. Siamo nel periodo dei “ghetti rosa”, come venivano chiamate ironicamente le mostre con presenze solo femminili.
Ma fortunatamente la lotta delle donne impegnate nell’arte vide protagoniste di elevato spessore come Lea Vergine, Annemarie Sauzeau Boetti, Romana Loda, Mirella Bentivoglio, Simona Weller e Carla Accardi. Ma, soprattutto, occorre citare Carla Lonzi, di cui è stato finalmente ripubblicato nel 2024 un testo fondamentale: “Taci, anzi parla. Diario di una femminista” 1972-1977, (editrice La Tartaruga).
Con la sua radicalità scuote lo stantio modo di pensare e l’immobilismo culturale di quegli anni, a partire dal luglio ’70, quando sui muri di Roma apparve il manifesto di “Rivolta femminile”, basato su un testo elaborato dalla Lonzi in collaborazione con Accardi ed Elvira Banotti.
A tale proposito vogliamo ricordare la mostra “Altra misura”, tenutasi dal novembre del 2015 al marzo 2016 nella Galleria Frittelli Arte Contemporanea di Firenze, nata dalle ricerche condotte per il libro “Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta” (Postmedia Books, 2013), che vedeva la presenza di Tomaso Binga, Diane Bond, Lisetta Carmi, Nicole Gravier, Ketty La Rocca, Lucia Marcucci, Paola Mattioli, Libera Mazzoleni, Verita Monselles, Anna Oberto e Cloti Ricciardi. Artiste che hanno usato la fotografia contro gli stereotipi di genere e i cliché tipici di una comunicazione inguaribilmente maschilista.
Quale messaggio ci trasmettono, infine, le artiste che si batterono mezzo secolo fa per la rivalutazione della figura femminile nell’arte e nella società? Un messaggio che suona come incitamento a continuare la lotta per l’affermazione del ruolo che compete alle donne nella società. Un ruolo non ancora pienamente riconosciuto nel mondo occidentale (per tacere di paesi in cui la condizione della donna è a dir poco umiliante), ma che otterrà il giusto apprezzamento se sapremo far tesoro dell’esempio personale e dell’audacia artistica che ci hanno lasciato in eredità le protagoniste degli anni Settanta.
Da AP Autogestione e Politica prima
Mail art 2024 organizzata dalla Merlettaia di Foggia insieme alla Rete delle Città Vicine e all’Atelier di artiste dell’Alveare di Lecce: “Trame di vita” “Trame di pace” due temi che si intrecciano tra di loro, si annodano, si rafforzano.
È un appuntamento atteso con le artiste e gli artisti e anche con chi artista non lo è, ma che ci prova e lo diventa per il tempo e nello spazio di una cartolina.
La ricerca delle parole, dei colori, delle immagini, le modalità per rappresentare il proprio messaggio diventano una sfida, una pacifica sfida dove, grazie al cielo, non si vince nulla.
Una sfida con sé stessi e con il proprio desiderio che è anche quello di affidare la propria creazione allo sguardo critico, benevolo, severo, indulgente di chi si fermerà davanti alla piccola opera.
La mail art non è solo il prodotto finito che sono le cartoline.
È una strada percorsa da persone che si incontrano in tanti modi e si lasciano attraversare dalle altrui sensibilità.
Il suo iter, meraviglioso, comincia con le idee, le proposte sugli argomenti da sviluppare e le motivazioni.
Le problematiche che ogni giorno il mondo ci elargisce, con una generosità pari solo alla mancanza di senso di responsabilità in fatto di guerre, ambiente, questioni sociali, libertà, libertà femminile, discriminazioni, sono tante che non è difficile trovare il tema che sta più a cuore (eh sì proprio a cuore) a tutte e tutti sia individualmente che come associazioni.
Scelto il tema, segue la condivisione con il mondo degli artisti e delle associazioni con relativi inviti a partecipare.
La casa di Katia Ricci per oltre un mese diventa punto di raccolta di tutti i lavori, ogni anno più numerosi e di provenienza anche estera.
Arriva di tutto, carta cartoncini collage tavolette metallo ricami uncinetto fiori foglie foto e le previste piccole dimensioni, non sono da freno alle ambizioni artistiche, anzi si aggiungono alle sfide a cui accennavo prima.
Non mi dilungo sulla fase della ricerca dei luoghi dove tenere la mostra e le relative difficoltà, in quanto gli iter burocratici sono sempre un po’ noiosi da descrivere e a volte irritanti da vivere.
Però mi piace anche dire, per mia diretta esperienza, che quando ci si confronta con le istituzioni non solo sulla base dei ruoli, ma come persone, la relazione si fa più agile, più vera e diventa anche piacevole.
Tra una richiesta da un lato ed una concessione dall’altra e scambi più personali, ognuna/o comprende meglio le problematiche dell’altra/o con reciproca soddisfazione.
Con l’installazione delle artiste Rosy Daniello e Anna Fiore, le nude pareti del museo di Foggia, luogo della prima esposizione, hanno preso vita; vita che proseguirà coi successivi itinerari.
Colori, poesie, frasi, foto diventano il prolungamento dell’anima degli artisti/e della loro forza, delle loro fragilità.
Ma c’è un’altra fase artistica, una parte irrinunciabile della mostra che è la realizzazione a cura di Rosaria Campanella del video delle foto di tutte le opere (visibile su you tube digitando trame di vita trame di pace).
La mostra è itinerante e Anna Fiore, con la stessa attenzione con cui ha affisso al muro le opere, a chiusura della mostra, ha provveduto a toglierle, con amorevole cura e rispetto per il lavoro degli artisti/e.
Ciascuna opera l’ha avvolta in un foglio di carta per poi unirle in piccoli gruppi onde evitare che si potessero danneggiare. Ha recuperato quindi diligentemente spilli e pinzette varie, utili per la successiva esposizione e infine consegnandomi il tutto perché lo portassi a Vico del Gargano, successiva sede della nuova inaugurazione, mi ha chiesto, premurosa, se per caso volessi anche il martello (suo).
L’ho abbracciata per tutto l’amore che ci ha messo.
Così come mi viene di abbracciare Katia per la generosità e la pazienza (con gli artisti ce ne vuole, si sa);
Rosy alla quale siamo tutte legate con un tenace lungo filo di stima ed amore;
Rosaria per il video che rende ancora più belle le già belle opere;
e tutti e tutte senza il cui sostegno mai nulla si potrebbe realizzare.
Messaggi, sogni di pace, poesie desideri, esempi di un’altra vita possibile, sono stati espressi nelle cartoline, come nella mia dal lungo fiore azzurro, attraverso la quale desidero che sulla Terra venga seminata la Pace per far crescere e raccogliere la pietà, la speranza e veder rifiorire i sogni in nuove notti d’amore.
Ma questa mia utopia non riesce a lenire l’inquietudine, il disappunto, la rabbia che provo per ciò che accade nei luoghi del potere, dove la pace sembra essere un argomento di rari incontri autoreferenziali e sterili.
Di altro tenore e solerti nelle decisioni, invece, sono quelli sulla guerra e sulle armi vendute dalle ricche case di produzione.
Da qui nasce a mia poesia “Non hanno cieli gli uccelli” che condivido in questo scritto.
Lungi dal chiudersi a ogni speranza, la mia vuole essere una denuncia verso chi, pur avendo prerogative decisionali e strumenti, non si adopera concretamente per far cessare sofferenze e disumanità e non “libera la colomba della pace dalla inutile cornice in cui è stata messa”.
È una poesia che affianca il desiderio di pace, di fiducia, di attesa della mostra stessa, aggiungendosi così alla voce degli artisti e al positivo coinvolgimento emotivo che il pubblico sta esprimendo davanti alle opere e a tutta la manifestazione.
Non hanno cieli
gli uccelli
in tempo di guerra.
Non volano per i campi di grano
tra i rossi papaveri,
né sui paesi a cinguettare stagioni.
Hanno perso il nido
e anche le nuvole nelle quali nascondersi.
Cercano la pace,
la colomba di pace.
Fedele a se stessa, su rami anneriti,
è rimasta ad attenderla, seppur accartocciata,
una tenace piccola foglia d’ulivo.
Ma… non si vedono bianchi voli
in questi cupi cieli,
rumorosi di ferro e di fuoco.
Eppure una colomba c’è.
Proprio lì sulla tela,
l’artista ha dipinto una grande colomba luminosa.
Le sue ali sono … candide
le sue ali sono … aperte
le sue ali sono … ferme.
Sembra una croce e forse lo è.
Una croce che rammenta
il dolore … la morte,
ma non la redenzione.
È lì la PACE
dentro una inutile cornice dorata.
La inchioda
lo sguardo incolore
del pubblico che conversa distratto,
mentre sorseggia, lentamente,
il calice di un fresco prosecco
offerto dalla ricca Casa d’arte.
(AP Autogestione e Politica prima, ottobre-dicembre 2024)
Da il Corriere della Sera
Due mostre in Italia ricordano la figura dell’artista, pioniera di un genere
Se per il centenario del futurismo (nel 2009) in Italia si è fatto poco, le celebrazioni dei primi 150 anni degli impressionisti sembrano non finire mai. E di quella pionieristica mostra allestita a Parigi il 15 aprile del 1874 si continua a parlare anche in Italia e a volte da prospettive poco familiari, per esempio attraverso la pittura delle donne. Avviene così che dopo decenni di silenzio o quasi, due città in contemporanea, Torino e Genova, dedichino una mostra a Berthe Morisot, la prima donna impressionista, nonché una delle figure più importanti del movimento reso famoso da Monet e da Renoir. A Genova “Impression, Morisot” (Electa) sarà allestita a Palazzo Ducale fino al 23 febbraio, mentre la Gam di Torino ospita “Berthe Morisot, pittrice impressionista” (24Ore cultura) fino al 9 marzo.
Non è stata l’unica pittrice impressionista, ce ne saranno altre e famose (per esempio Mary Cassatt), però Morisot è stata l’unica donna a esporre in quella celebre mostra ospitata nell’atelier di Félix Nadar, al 35 di rue des Capucines di Parigi. Al di fuori del Salon ufficiale, Monet, Pissarro e altri decisero di esporre per proprio conto, affrontando le (inevitabili) critiche dalle quali nascerà per paradosso il termine “impressionismo”, coniato dal critico Louis Leroy quando volle parlare male del bellissimo Impression, soleil levant di Claude Monet, del 1872. Berthe Morisot, in quella occasione, espose il suo dipinto più toccante, anche questo del 1872: La culla. Raffigura una madre finemente vestita che veglia con dolcezza il suo bambino nel sonno. Sarà questo dipinto a consacrarla nella storia dell’arte, ma non solo: è proprio qui che Morisot ricava quella “singolarità” di cui scrisse Paul Valéry parlando di lei, quella originalità che permise a una donna di entrare a far parte di una cerchia d’artisti.
Ma forse, per parlare di Morisot, è più utile partire dalla fine, dalla tomba: se andate a visitarla, nel cimitero parigino di Passy, scoprirete che le tombe di Berthe e del gigante della pittura francese, Édouard Manet, non sono tanto distanti. In fondo erano cognati, lei aveva sposato il fratello di lui. Eppure, se a ricordare la grandezza del pittore si erge un alto busto commemorativo, la tomba della pittrice è contrassegnata solo da una scarna epigrafe: «Berthe Morisot, vedova di Eugène Manet». Peggio ancora fece l’anagrafe della capitale francese quando registrò la sua morte, avvenuta nel 1895 a soli cinquantaquattro anni, a causa di una polmonite: nel certificato di avvenuto decesso scrissero «Berthe Morisot, senza professione». Bruciando così, in poche righe, una intera vita dedicata all’arte e alla sperimentazione.
Morisot era nata in una famiglia colta e benestante, nella quale l’arte non era bandita, anzi: sia Berthe che le sue sorelle Yves e Edma avevano preso lezioni private di pittura. Però, nelle intenzioni della madre Cornélie, queste dovevano servire a un intento preciso, cioè renderle “coltivate” e pronte per una vita sociale ricca e brillante.Detto in poche parole: dovevano servire a maritarle bene. Il problema fu che Berthe cominciò a pensare come un’artista vera e dunque quando andava nei grandi musei come il Louvre e copiava diligentemente i corpi pieni di Rubens, non si lasciava ingabbiare in un banale compito accademico. Studiava l’anatomia, le espressioni, le tecniche. Solo così si diventa bravi davvero, copiando con originalità. E allora un artista molto popolare all’epoca, Henri Fantin-Latour, la notò e le presentò Édouard Manet.
Questo, nella seconda metà dell’Ottocento, poteva essere una svolta nella carriera. Perché conoscere Manet non voleva dire solo entrare a far parte di un giro di conoscenze importanti nell’avanguardia, ma era anche come imboccare una direzione tutta nuova, distante dai canoni dell’accademia, considerare insomma l’arte come un territorio di coraggiosa sperimentazione. E i timori della madre di Morisot assunsero una concretezza allarmante: come può una donna dell’Ottocento pensare di fare l’artista e, per giunta, l’artista “sperimentale”, contraria ai dettami della tradizione? Sopravvivrà? Berthe sapeva bene che avrebbe dovuto muoversi con intelligenza: non diventare “di maniera”, ma nemmeno poteva permettersi quello che aveva fatto Manet nel 1863, quando diede scandalo con Le Déjeuner sur l’herbe, un dipinto nel quale una donna completamente nuda si lascia ritrarre in una quieta conversazione con due uomini vestiti, come se fosse stata la cosa più normale del mondo.
Morisot aveva osservato e studiato il lavoro del maestro, anche perché lui la ritrasse in numerosi dipinti. E quindi sapeva che lo “scandalo” in questo caso non stava tanto nel nudo in sé e per sé(le sale del Louvre erano piene di nudi pittorici) quanto nel fatto che quella donna era una cortigiana conosciuta in tutta Parigi, quindi la provocazione di Manet consisteva nell’inserire in una dimensione quasi rinascimentale (tizianesca) il corpo e il viso di una modella molto chiacchierata. Morisot comprende che non bastano l’originalità del tratto pittorico o la tecnica o i temi – peraltro, alle donne era permesso poco anche in questo senso. Comprende che deve trovare una sua “singolarità” e così si colgono bene le parole che a lei riservò un grande critico come Paul Valéry, nel 1941: «La singolarità di Berthe Morisot fu di vivere la sua pittura e di dipingere la sua vita».
Rimase così nell’alveo tematico del femminile: culle, madri, bambini, giovani donne, eleganti signore. Ma torniamo a osservare La culla, il dipinto che venne esposto nella prima mostra impressionista: nulla si ferma al dettame accademico, nulla è stereotipato. Non c’è una madre vestita di retorica, ma nell’osservare la piccola si coglie, assieme alla dolcezza, una certa apprensione, come un presagio dei tempi che verranno. E c’è un’ombra di stanchezza, modernissima perché la figura della madre, idealizzata da secoli di pittura, qui comincia ad assomigliare alla realtà. La maternità è tutt’altro che riposante, come ci dirà più apertamente in seguito Louise Bourgeois. Ecco perché questo dipinto piacque prima di tutto agli uomini, che apprezzarono molto anche le altre opere di Morisot, attenta a calibrare la sperimentazione con un gusto personale, un’attitudine. L’artista restò legata a Manet per tutta la vita e il matrimonio con il fratello del pittore sigillò un sodalizio segreto, quasi carbonaro tra i due. Per Berthe fu come scegliere una strada, quella dell’avanguardia, con un’enfasi e uno spirito critico che le fecero affrontare le inevitabili difficoltà. Infatti le sue opere – come anche quelle degli altri impressionisti – vennero criticate aspramente dai conservatori, ma per lei ci fu una punta di veleno in più in quanto donna. Per esempio, una volta fu insultata in pubblico da un avventore che la chiamò “prostituta”, scatenando la reazione violenta di Camille Pissarro. Morisot non arretrò di un passo, anzi. Negli autoritratti che – via via sempre più di frequente – riservò a sé stessa, la si vede ora madre e ora gran dama a suo agio nell’alta società. Grazie alla pittura, ha raccontato la sua vita e così trovano un senso compiuto le parole di Paul Valéry: «La singolarità di Berthe Morisot fu di vivere la sua pittura e di dipingere la sua vita».
Da il manifesto
Marianne Heier racconta la mostra “La passione” alla Fotogallieret di Oslo. Il nucleo principale tra fotografie, video e libri proviene dalla celebre collezione di Donata Pizzi
«Il mio ruolo è soprattutto di guida per il pubblico norvegese nella conoscenza del femminismo radicale italiano e della sua relazione con le arti visive», afferma Marianne Heier (classe 1969, vive e lavora a Oslo), co-curatrice della mostra La passione (fino al 29 dicembre) insieme a Antonio Cataldo, ex direttore artistico della Fotogalleriet di Oslo, lo spazio istituzionale che la ospita.
Realizzata con il sostegno della Arts and Culture Norway e dell’Istituto italiano di cultura di Oslo, la collettiva offre una panoramica sul lavoro di artiste italiane di diverse generazioni che riflettono l’energia e la forza nella lotta alla parità di genere: Chiara Fumai, Pippa Bacca, Silvia Giambrone, Bingöl Elmas, Betty Bee, Ottonella Mocellin, Marcella Campagnano, Agnese De Donato, Tomaso Binga, Lisetta Carmi, Lucia Marcucci, Alessandra Spranzi e il Gruppo del Mercoledì (Diane Bond, Bundi Alberti, Paola Mattioli, Silvia Truppi).
Il nucleo principale tra fotografie, video e libri proviene dalla collezione di Donata Pizzi, la più importante collezione privata italiana dedicata alla conoscenza del lavoro delle artiste italiane dagli anni ’60 ad oggi. In occasione della serata inaugurale Heier, il cui lavoro artistico è collegato alla tradizione della critica istituzionale, ha reso omaggio alla figura di Carla Lonzi (1931-1982) attraverso una performance-monologo in cui ha raccontato aneddoti e metafore sulla condizione della donna all’interno della storia patriarcale.
Un’altra parte del lavoro sono i poster che affissi in giro per Oslo. «Serigrafie in tiratura limitata con due foto di sculture classiche dell’Afrodite di Knidos che ho scattato una ad Atene e l’altra a Napoli. La venere pudica che si copre o indica i genitali, invita o è intimorita, si protegge o si apre. Un’ambiguità che è ancora oggi alla base della raffigurazione del corpo femminile nell’arte. Sopra ho scritto le informazioni sulla mostra e alcune note che mi sono appuntata leggendo i testi di Lonzi ed altri sul femminismo italiano. Ho, poi, invitato sui social gli abitanti di Oslo a prendere quei poster-opere per appendere una parte di questa mostra nelle loro case, in modo che questo pensiero si espanda anche fuori dalla galleria. Volevo che la mostra fosse il più vicino possibile all’idea stessa di Carla Lonzi sulla porosità dell’arte, sia in termine di creatività che di relazioni. È importante la partecipazione».
In che modo si pone come artista e curatrice di “La Passione”, un omaggio al femminismo radicale italiano?
«In questo caso sono sia artista che curatrice e, allo stesso tempo, né l’una e né l’altra. Una posizione che rispecchia un po’ la mia condizione personale. Infatti, sono nata e cresciuta in Norvegia ma la mia formazione artistica è legata all’Italia, dove ho incontrato le esperienze, le voci e le espressioni delle artiste femministe che mi hanno formata. Quando studiavo all’Accademia di belle arti di Brera a Milano, negli anni ’90, sono rimasta folgorata da quella tradizione di grande complessità e coraggio. Ancora oggi è il mio punto di riferimento nel modo di pormi politicamente come artista. All’Accademia la maggior parte dei docenti erano uomini e i corsi di storia dell’arte erano solo su figure del genio maschile, ma c’erano anche delle artiste che insegnavano e dalle loro conversazioni si coglievano delle frasi. La presenza delle artiste femministe italiane era sospirata ma pervasiva, come fossero spiriti, sotto al monologo costante di quei grandi geni maschili che tutti conosciamo.»
In particolare, cosa la aveva colpita nella lettura di “Sputiamo su Hegel” e degli altri scritti di Carla Lonzi?
«La sua disponibilità e il coraggio nella radicalità. La pratica dell’autocritica è molto difficile, perché si tratta di riconoscere il patriarcato dentro di sé come presenza nella quotidianità, nelle relazioni, nel modo di porsi o di esprimersi. Una pratica continua di cui liberarsi. La stessa Lonzi nel Diario di una femminista scrive: «Vent’anni fa ero una studentessa dell’università/ quindici anni fa ero una dottoressa in storia dell’arte/ dieci anni fa ero scrittrice d’arte e amica di artisti/ due anni fa ero femminista […] Adesso non sono niente, niente assolutamente». C’è questo ridursi, il togliersi di dosso un bagaglio che è la stessa società a proiettarci. M’ispira molto questa richiesta di autenticità che è uno standard altissimo e che funziona come una specie di bussola. Un altro aspetto è la possibilità di trasformare la società. Quella in cui viviamo è una costruzione sociale e politica determinata da determinate condizioni storico-politiche ed economiche, ma che fondamentalmente può essere cambiata, riscritta e ripensata. Questo pensiero, per me, ha uno spazio d’azione e libertà illimitata che riconosco nel lavoro delle artiste presenti in questa mostra. Quante posizioni divergenti, in tensione tra loro, coraggiose, appassionate e che incredibile energia! Come pure l’insistere nell’affermare «io dico io», il peso dell’unicità.»
Ha affermato che in Norvegia si conosce ben poco delle artiste femministe italiane…
«Dopo aver trascorso 11 anni a Milano, durante la mia formazione artistica e personale, nel 2000 sono tornata in Norvegia perché in Italia, per me, era impossibile vivere da artista. Qui la condizione finanziaria e la produzione dell’arte è diversa, ci sono sovvenzioni pubbliche che rendono possibile l’esistenza di un’artista come me che non ha un mercato. Però l’Italia mi manca moltissimo, soprattutto l’energia, il rischio che si riflette – lo sottolineo ancora una volta – nel lavoro delle artiste femministe italiane. Un femminismo che è diverso da quello norvegese che ha ottenuto tantissimo, ma che non ha passione e neanche il fuoco sul lavoro interiore. Il femminismo norvegese è rivolto soprattutto alla ridistribuzione del potere, alla sua accessibilità per le donne, mentre per Carla Lonzi si trattava di ridefinire lo stesso concetto di potere. Due approcci diversi. Molte volte mi sono chiesta se questa radicalità italiana, il dramma, la passione e l’energia quasi febbrile del lavoro femminista derivino dalla presenza del cattolicesimo. Qui non c’è mai stata quell’aggressione, oppressione e controllo sul corpo e sulle vite delle donne.»
Un approccio che si riflette anche nel titolo della mostra?
«La scelta del titolo La Passione deriva proprio da queste considerazioni e implica l’ambiguità di amore e sofferenza. Tutto nasce dalle conversazioni che ho avuto con Antonio Cataldo che è il vero curatore della rassegna, perché la mia è una co-curatela da artista esterna. Anche Antonio, che è uno dei più importanti curatori in Norvegia, si è trasferito qui dall’Italia. Abbiamo scoperto di avere tanti riferimenti in comune. Per me è stato come un ponte tra lì e qui, passato e presente. Per la prima volta c’era qualcuno che poteva confermare quelle figure sulle quali basavo molta della mia pratica artistica. Materiali, voci, donne che esistevano ma di cui in Norvegia non si sapeva nulla. Non si era mai parlato del lavoro di queste artiste, né tradotto e reso accessibile il pensiero di Carla Lonzi, malgrado si conoscessero i movimenti italiani come quello dell’arte povera. Però era tutto declinato al maschile. La storia raccontata è parziale, non è questione di qualità, volontà di sperimentazione o fervore intellettuale, artistico ed estetico. Il modo stesso in cui se ne parla deriva dalla visione patriarcale.»
Da il manifesto – Alias – Nel 1980, in occasione della riorganizzazione delle collezioni africane del Museo Pigorini, venne ritrovato un oggetto di cui si erano perse le tracce: un indumento realizzato nell’Impero ottomano nel 1665 circa e approdato poco dopo a Roma nelle collezioni di Athanasius Kircher. Si tratta di una rarissima camicia talismanica in tela di cotone bianca, con corpetto, maniche e colletto coperti di iscrizioni a caratteri arabi in blu, nero, rosso e oro, disposte in una elaboratissima composizione simbolica che culmina con i 99 nomi di Allah racchiusi nella decorazione del colletto. Un mistico sufi, un astrologo, un calligrafo e almeno un illuminatore hanno concorso alla realizzazione di questa stupefacente pagina miniata in tessuto che aveva la funzione di proteggere dalla malasorte il personaggio di alto rango che la indossava.
La camicia talismanica è il punto di partenza della mostra Tessere è umano: Isabella Ducrot e le collezioni del Museo delle Civiltà di Roma (a cura di Anna Mattirolo, Andrea Viliani con Vittoria Pavesi, fino al 16 febbraio), che raccoglie alcuni straordinari tessuti conservati nelle collezioni del museo assieme a opere di Isabella Ducrot nelle quali i tessuti sono protagonisti.
Nel grande ambiente dove è allestita la mostra attraversiamo cinque continenti e quasi quattro secoli di storia delle collezioni: a partire dal “Teatro del mondo” fondato da Athanasius Kircher nel 1651, attraverso le relazioni diplomatiche vaticane e l’ambiziosa istituzionalizzazione compiuta da Luigi Pigorini alla fine dell’Ottocento, fino alle raccolte dedicate alle tradizioni popolari e alle colonie, nelle quali prendono forma quotidiana irrisolte tragedie novecentesche.
Incontriamo, per la prima volta raccolti insieme, frammenti preistorici, sopraffini kimono giapponesi, evanescenti garze precolombiane e tessuti in corteccia dell’Oceania e dell’America latina.
Tutto si tiene insieme in virtù dell’intreccio di trama e ordito, struttura essenziale di ogni tessuto, e della storia di Isabella Ducrot. Andrea Viliani, direttore del Museo delle Civiltà dal 2022, ha eletto il coinvolgimento di artisti contemporanei a metodo per esplorare e ri-semantizzare le collezioni, ma questa mostra si discosta da altri progetti in corso.
Da vari decenni Isabella Ducrot raccoglie stoffe in tutto il mondo e di tessuti ha anche scritto in varie occasioni. Più che ricerca di manufatti rari o di particolare valore, il suo è un collezionismo di tracce umane rimaste imbrigliate nei pezzi di stoffa, nel quale è centrale l’attenzione ai tessuti che fanno da tramite tra l’umano e il divino.
Non lontano dalla camicia talismanica è esposta una preghiera tibetana blu del XVII secolo proveniente dalla sua collezione, nella quale il testo non è ricamato o dipinto a posteriori ma elemento strutturale del tessuto: ordito e trama. Questo intreccio costitutivo tra la dimensione materiale e quella immateriale è l’elemento ricorrente di tutti i manufatti in mostra.
Negli anni ottanta Ducrot ha cominciato a combinare nei suoi lavori d’artista i tessuti che aveva raccolto, restituendogli il valore d’uso che avevano perduto quando erano diventati pezzi da collezione, come scrisse Patrizia Cavalli molti anni fa. Anche il più prezioso dei tessuti è quasi sempre servito a qualcosa, ma persino il più umile è stato contemplato.
Riuscire a tenere in vita la dimensione d’uso degli oggetti, lasciando spazio alla loro contemplazione, è forse la sfida maggiore per un museo di collezioni etnografiche, e senza dubbio i tessuti che ci accompagnano dalla nascita alla morte sono la categoria ideale per coglierla: palinsesti, documenti e linguaggi; inconsapevoli strumenti di trasmissione e mediazione culturale; frutti corali di imprese collettive; merce di scambio e trofeo di conquista.
In alcuni casi la funzione spirituale è espressa nella struttura stessa della stoffa, vedi il tessuto rituale indonesiano realizzato a Sumatra nel XIX secolo, dove parte della trama non viene completata e i fili dell’ordito non vengono tagliati perché rappresentano la circolarità della vita e conferiscono al tessuto un potere protettivo.
La preghiera tibetana, la camicia talismanica e il tessuto indonesiano, posti al centro della sala e circondati da alcuni lavori recenti di Isabella Ducrot, sono membrane tra la temporalità del corpo e l’atemporalità dello spirito.
Attorno a questo centro gravitano umiltà e potenza, ricchezza e potere di scambio, vita quotidiana e riti di passaggio.
Un punto di raccordo suggestivo con la ricerca di Isabella Ducrot è la vetrina con indumenti e costumi di uso quotidiano provenienti dalle collezioni di arti e tradizioni popolari e dedicata ai tessuti a quadretti. La stoffa a quadri è il titolo di un saggio (Quodlibet, 2018) nel quale Ducrot racconta della sua epifania di fronte all’Annunciazione di Simone Martini (Uffizi, 1333): nel celeberrimo trittico a fondo oro, summa della sinuosa preziosità del pittore senese, il mantello svolazzante dell’Angelo annunciante è foderato di una stoffa a quadretti, pattern domestico e umile per eccellenza e ciò nonostante scelto dell’artista per mostrare la sua straordinaria maestria.
Dal lato opposto incontriamo un rarissimo manufatto tessile mesoamericano cinquecentesco che, secondo la tradizione, probabilmente celebra un condottiero che all’arrivo degli spagnoli scelse di schierarsi dalla parte di Hernán Cortés, e forse per questo è decorato con aquile bicefale di ascendenza asburgica.
In questo caso ordito e trama ospitano delle preziosissime piumette cangianti – i popoli americani consideravano gli oggetti impiumati depositari di forza divina – e danno vita a un tessuto che è monumento e poema del tracollo delle potenze precolombiane.
Pur lavorando da decenni, Isabella Ducrot ha incontrato la fama tardivamente, a ottant’anni compiuti: l’estate scorsa le è stata dedicata una grande retrospettiva al Consortium di Digione e il prossimo anno sarà la volta del Museo Madre di Napoli.
È anche la protagonista di Tenga duro signorina. Isabella Ducrot Unlimited, un documentario di Monica Stambrini presentato all’ultimo festiva di Venezia e in sala in questi giorni, che osserva come persino la vecchiaia, uno degli ultimi tabù, non sia poi così terrorizzante. Rispetto a questi progetti la mostra Tessere è umano va ben oltre la persona dell’artista o la celebrazione della sua opera: come nei tessuti oceanici o sudamericani, in alcuni lavori Isabella Ducrot usa la corteccia, e basterebbe questo per dimostrare che l’umanità è ancora interconnessa.
Da Erbacce – Sono una cartoonist di Gaza. Dal 7 maggio 2024 vivo a Khan Yunis, nel campo di Ain Jalut, in una tenda con mia sorella e con i miei fratelli accanto a noi. Quando la carta finisce, disegno sulla tenda.
Video
https://www.erbacce.org/una-tenda-in-palestina/
Da Doppiozero – Fra i grandi meriti di Omero, nota Hannah Arendt, c’è quello di aver reso immortali gli eroi di cui racconta la storia. Non sappiamo chi fosse Omero, il narratore che chiamiamo con questo nome, ma sappiamo chi fossero Achille, Ettore e Ulisse perché ne conosciamo le storie e non ci stanchiamo di rileggerle e raccontarle. Racchiusa nelle storie, la loro fama è imperitura e li salva dall’oblio. Non sono però solo i guerrieri a guadagnarsi questa immortalità donata dal canto omerico. Penelope, la tessitrice che fa e disfa la sua tela, è la protagonista di una storia davvero memorabile che la tradizione non ha infatti mai potuto dimenticare.
A Roma, promossa dal Parco archeologico del Colosseo, si è di recente aperta Penelope, la prima mostra dedicata al personaggio omerico, a cura di Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni, con l’organizzazione di Electa. Potete visitarla fino al 12 gennaio 2025, ammirando cinquanta opere che, attraverso la tradizione visiva e letteraria, ripercorrono il mito e la fortuna della regina tessitrice, celebre per il suo gesto di fare e disfare. Genialmente, l’esposizione comprende anche un omaggio a Maria Lai, artista che ha messo al centro del suo lavoro la materia tessile. Da Penelope alla grande artista sarda, dall’immaginario antico all’arte contemporanea, la mostra ci invita ad esplorare l’universo, simbolico e operativo, delle donne che tessono, che fanno del gesto della tessitura una trama di libertà, creatività e riscatto.
Racconta il mito che fu la dea Atena a donare alle donne l’arte del tessere, riservando invece agli uomini quella del guerreggiare. Ovviamente la parola greca è techne, un termine che, al contrario dell’italiano arte, non convoca immediatamente la bellezza, bensì una certa rigorosa perizia, una capacità del fare, un’abilità e una competenza fondate su un sapere. In Platone la figura del ‘tecnico’, comprensiva di quello che noi chiameremmo artigiano e artista, implica la conoscenza di un campo specifico o, meglio dell’idea, della forma che è al centro di questo campo – poniamo, l’idea di letto, guardando alla quale il costruttore di letti trae le regole oggettive così come il materiale adatto per la fabbricazione del letto. Ogni tecnico ha un sapere specifico dell’oggetto di cui è competente e che impone un ordine preciso al suo operare, dettandone le procedure, i tempi e la materia. Nel dire che un’opera è fatta a regola d’arte c’è dunque una sorta di ridondanza: l’arte, ovvero la techne, consiste sempre, e di per sé, nella sua regola. Il tecnico è precisamente l’esperto che vede e segue, esegue, questa regola. L’arte del tessere, in cui eccelle la regina di Itaca, sarà quindi un sapere specialistico delle regole, degli strumenti e del materiale, nonché delle modalità di intreccio, trama e ordito, adatti a produrre il tessuto. Diciamo, nel caso di Penelope, a produrre la tela, il sudario per Laerte.
L’algida spiegazione razionale dell’operare tecnico, fatta da Platone, ci aiuta qui tuttavia solo fino a un certo punto. Platone non prevede infatti che il tecnico, una volta fabbricata la tela, la disfi. Il gesto della tessitrice Penelope è anomalo, anzi scandaloso. Penelope possiede certamente un sapere perfetto della tecnica del tessere ma evidentemente sa qualcosa di più, qualcosa che, pur accadendo nella stanza dei telai in cui, come tutte le donne, è confinata, travalica questo confine, questo ruolo, questa specie di prigione femminile, e agisce sull’assetto politico del regno, là dove dominano gli uomini e lei è esclusa. Tessendo la tela di giorno e disfacendola di notte, Penelope per quattro anni tiene in scacco i pretendenti alla sua mano e la sorte di Itaca. Come con l’astuzia, la metis, il marito ha escogitato il trucco del cavallo di legno per sconfiggere il nemico in battaglia, così la metis di Penelope escogita il trucco del fare e disfare la tela per sconfiggere i pretendenti al governo di Itaca. Al contrario del marito, che opera nella propria sfera di competenza, ovvero nella sfera maschile del guerreggiare, Penelope, pur operando nella sfera propriamente femminile del tessere, fa in modo che gli effetti della sua astuzia riesca a travalicarla. Quel che avviene nella stanza dei telai riguarda direttamente la vicenda politica di Itaca, è questo il nucleo memorabile della storia.
Come ci raccontano Omero e la letteratura antica in generale, nella cultura occidentale, al contrario di ciò che avviene in altre culture, la tessitura è riservata anticamente alle donne o, meglio, il loro confinamento nell’ambito domestico prevede che esse vi svolgano il lavoro di tessitrici. Gli esempi testuali abbondano. Basterà qui, per stare ai poemi omerici, ricordare le parole che Ettore, pur dolce e mite marito, rivolge alla moglie Andromaca che, uscita dalla casa, si reca alla porta Scea per scongiurarlo in lacrime di non scendere in battaglia: «su, rincasa e bada ai tuoi lavori, il telaio e il fuso – le dice Ettore – e ordina alle ancelle di mettersi all’opera; alla guerra penseranno gli uomini» (Iliade, VI, vv. 490-93). Penelope stessa, che ha osato parlare nella sala degli uomini, il megaron, viene invitata dall’arrogante figlio Telemaco a tornare nella stanza dei telai. La politica e la guerra spettano agli uomini, la casa in cui si svolgono i lavori domestici e, in primis, la tessitura, spetta alle donne. I ruoli di genere, come oggi si direbbe, sono chiari. Donando alle donne l’arte della tessitura, in un certo senso, è stata miticamente Atena a escluderle dall’ambito pubblico e a imprigionarle in quello domestico. Ciò non implica che, per i Greci, quella della tessitura sia un’arte inferiore o secondaria, visto che di tale arte si pregia, anzi, la stessa Atena e molte divinità femminili. C’è nell’arte del tessere un orgoglio per l’abilità di produrre splendidi e utili oggetti, nonché una riconosciuta creatività che va al di là dell’utile. Dal tessuto, dall’ambito del textum, derivano del resto parole molto significative come testo e trama. Il tessuto istoriato è tale perché, come il grande Omero, racconta storie. Le crea, le inventa e le tramanda.
Si legge nel catalogo della mostra che nella tradizione iconica Penelope appare spesso malinconica. La malinconia, insieme alla fedeltà e alla pudicizia, scrive la curatrice Alessandra Sarchi nel suo saggio illuminante, costituiscono le sue principali caratteristiche. Pudore e riservatezza sono sottolineate anche nel saggio, altrettanto illuminante e documentato, dell’altro curatore, Claudio Franzoni. Sono saggi ricchissimi e avvincenti, indispensabili per chi visiti la mostra o voglia approfondire i vari filoni letterari, artistici, speculativi e simbolici che si stringono intorno alla figura di Penelope o da essa sgorgano.
Secondo un’autorevole tradizione, la casta e malinconica Penelope, modello di tutte le mogli, è un’icona dell’attesa. Forse ha una struggente nostalgia del marito e ancora spera che torni. Forse simboleggia appunto la moglie fedele alla quale manca il marito, ovvero la moglie che l’assenza del marito e l’incertezza per la sorte di lui rende triste e sconsolata. O forse suggerisce che nello stare confinata tutta la vita nella stanza dei telai, in fondo, c’è ben poca gioia. Molto stupore desta comunque il fatto che, quando Ulisse finalmente torna, travestito da vecchio mendicante, al contrario del cane Argo e del porcaro Eumeo, Penelope non lo riconosca. È Omero a raccontarci questo fatto davvero strano, tutt’altro che trascurabile. Quando Ulisse si palesa, lei non gli crede, vuole le prove. Avrà pensato che dopo tanti anni fosse improbabile che Ulisse fosse ancora vivo? (e alquanto forte e vigoroso come si evince dalla prova dell’arco). O avrà pensato che il suo trucco di fare e disfare per tenere sotto scacco il trono e il destino di Itaca, il suo astuto gioco della politica, fosse giunto inesorabilmente alla fine? Dopo tutto, che ne è di Penelope quando Ulisse si reinsedia nel regno? La regina Penelope, protagonista di una memorabile storia, dopo il ritorno del re, suo legittimo marito, ha ancora una storia?
In effetti è plausibile persino ipotizzare che, nel momento in cui la sua memorabile storia finisce, quando il suo personaggio, che ha svolto un ruolo cruciale nella trama del racconto, esce di scena; che quando Omero chiude la vicenda del fare e disfare perché è tornato il re, Penelope abbia nostalgia del passato. Ora sarà come tutte le altre tessitrici, seguirà diligentemente la regola della sua arte, produrrà splendidi e utili tessuti ma non li disferà più. Anche la complicità con le ancelle per fare funzionare il trucco sarà solo un ricordo. La fama che ne ha fatto una delle icone fondamentali nell’immaginario dell’occidente svanirà nella noia casalinga dell’ordinario.
Il segreto dell’arte di Maria Lai è efficacemente espresso dal suo motto secondo il quale «essere è tessere», a cui si accompagna la sua acuta osservazione sulla somiglianza fra il filo della tessitura e quello della scrittura. Lo testimoniano, fra le realizzazioni dell’artista, i celebri libri di stoffa così come i telai, i grovigli e i fili che legano la montagna e l’abitare in un’opera collettiva. Nell’antichità erano le Moire a filare, e filavano la vita singolare di ogni essere umano, dalla nascita alla morte, essendo la morte semplicemente il filo troncato, spezzato. Sì, essere è tessere, anche perché, secondo il mito delle Moire, il nostro essere qui, in questo mondo o, se si vuole, il nostro esistere come singolarità incarnate, è un filo sottile, intrecciato con altri fili, che si dipanano in una trama collettiva, istoriata temporaneamente, per un tratto, per nodi provvisori, dalla storia di ciascuna vita. Notoriamente le Moire si sono guadagnate nella tradizione una fama sinistra perché tagliano il filo, decretano la morte. Si dimentica però che esse sono all’opera anche quando il filo si forma e nasce, al suo inizio. Come ben sa Penelope, c’è un inizio per ogni filatura, così come, intrecciando i fili, per ogni tessitura. Forse anche per questo la regina disfaceva di notte la tela: per ricominciare, per far sì che la sua storia non finisse e diventasse interminabile, perché sempre tornava al senso davvero memorabile e infinitamente ripetuto del suo inizio.
Da Internazionale – “Vi chiediamo visioni di società senza armi, stati senza eserciti, comunità liberate dal lutto della guerra. E vi chiediamo di farlo nello spazio di un poster”. Questa è la richiesta di Cheap nella loro ultima call for artists.
Cheap è un progetto di arte pubblica fondato a Bologna nel 2013 da sei donne che hanno scelto di lavorare con la poster art. Ogni anno lanciano un invito rivolto a chiunque si occupi di arte visiva per realizzare poster da attaccare nelle strade di Bologna. Il tema di quest’anno è stato: Fuck war!
Il collettivo bolognese ha deciso di dedicare questa edizione alla guerra, con un occhio di riguardo alla Striscia di Gaza. “Era inevitabile che il massacro che si sta compiendo in Palestina fosse al centro del lavoro di molte delle artiste che hanno partecipato alla call. Non è nemmeno una guerra: quello a cui stiamo assistendo è un genocidio che il sistema dell’informazione – soprattutto in Italia – si sta in larga parte rifiutando di indagare e denunciare. Abbiamo voluto tentare di aprire una breccia nella conversazione pubblica surreale che sentiamo attorno a noi su quello che sta succedendo in Palestina. Chiedere il cessate il fuoco non è una richiesta radicale come viene bollata: davanti a 40mila civili uccisi è il minimo a cui ci si possa appellare”.
L’invito ai partecipanti è stato quello di disertare l’immaginario bellico e sabotare la retorica che lo sostiene. Sono arrivati 1.120 poster da 41 diversi paesi nel mondo, 662 partecipanti che hanno lavorato con diverse tecniche e mezzi: fotografia, collage, illustrazione, tipografia, intelligenza artificiale e grafica.
I manifesti per le strade di Bologna rimandano a un immaginario non solo di pace ma anche di giustizia sociale, invitano ad azzerare la spesa militare per investire in istruzione e sanità, visioni di società senza armi e di stati senza eserciti.
La artiste di Cheap saranno a Ferrara il 4 ottobre, durante il festival di Internazionale, per presentare il loro ultimo libro Disobbedite con generosità (People).
Da il manifesto – Alias – A MILANO. Triennale, la mostra di Gae Aulenti, a cura di Giovanni Agosti. Il percorso si sviluppa «in pause che liberano lo spettatore alla conoscenza e alla critica» (Aulenti). Edifici negozi mostre musei, e il teatro con Luca Ronconi. E in un gioco di carte, gli «attori» della sua vita professionale e privata…
Come avrebbe immaginato Gae Aulenti una mostra dedicata al proprio percorso creativo? Possiamo dedurlo da qualche suo pensiero: «Il sistema espositivo non può essere un semplice supporto del materiale da rappresentare, ma deve partecipare ad esso, esserne coinvolto e insieme coinvolgere lo spettatore, con chiara volontà». Quanto al percorso, dovrebbe essere immaginato «in modo che l’esperienza spaziale, procedendo per amplificazioni e variazioni continue, si sviluppi con forme autonome successive, in pause che liberano lo spettatore alla conoscenza e alla critica». Si coglie immediatamente un’idea espositiva orientata al teatro; non a caso il visitatore, con un upgrade di status, diventa spettatore. Il coinvolgimento è reale se contempla però anche uno spaesamento: perdersi per ritrovarsi con un’aumentata consapevolezza. Di qui la necessità di cambi di ritmo che interrompano la linearità del percorso e stimolino uno sforzo di conoscenza e di critica.
La mostra che la Triennale di Milano ha dedicato a Gae Aulenti (fino al 12 gennaio) prende avvio da una sala che immediatamente inghiotte lo spettatore nel meccanismo della macchina espositiva: sotto un soffitto di onde di stoffa si procede circondati dalle sagome ritagliate nel legno delle donne picassiane che corrono felici verso il mare. Il prototipo è il piccolo capolavoro dipinto dal malagueño nel 1922 durante le vacanze sulle spiagge di Dinard. La sala ripropone l’allestimento, pensato insieme a Carlo Aymonino e Steno Paciello, per la sezione italiana alla Triennale milanese del 1964, che era valsa a Gae Aulenti il Gran premio internazionale assegnato dalla stessa Triennale. Nel gioco di squadra quell’idea così teatrale è come una firma: infatti quindici anni dopo Aulenti avrebbe voluto un dettaglio di quell’allestimento sulla copertina del catalogo della sua prima mostra monografica al PAC di Milano. Questo impatto trascinante fa subito i conti con il brusco cambio di passo dell’allestimento del negozio Olivetti di Buenos Aires del 1968: macchine da scrivere e oggetti di design disposti su gradoni, ricavati entro spicchi di piramide che precipitano in direzione dell’osservatore. Così siamo calati immediatamente in un territorio aulentiano, nel segno di una calcolata discontinuità.
Una mostra su Gae Aulenti non poteva essere pensata secondo i canoni di una mostra di architettura. Anche per questo la curatela è stata affidata a Giovanni Agosti, che, come lui stesso ammette nell’introduzione alla guida che accompagna i visitatori (in attesa del catalogo, la cui pubblicazione è prevista per l’autunno: l’una e l’altro per i tipi di Electa), non è né storico dell’architettura, né del design, né del teatro, «ma solo uno storico dell’arte che le ha voluto però molto bene». Hanno affiancato Agosti Nina Artioli, nipote dell’architetto e contitolare dello studio Tspoon che ha progettato l’allestimento, e Nina Bassoli, curatrice del settore Architettura della Triennale.
Il congegno drammaturgico del’esposizione prevede una sezione «tradizionale» in cui sono esposti materiali documentari (incuriosiscono i diari e alcune lettere) e disegni, tra i quali spiccano gli splendidi lucidi a china e retino con le piante e gli alzati di alcuni dei progetti più famosi di Aulenti. È un lungo corridoio perimetrale che si innesta nel tratto superstite della Galleria dei disegni, che lo stesso architetto aveva progettato per la Triennale del 1994. Dal corridoio si può gettare l’occhio sulla «macchina evocatoria», come la definisce Agosti, che in tredici spazi incastrati l’uno nell’altro, rispettando l’ordine cronologico, restituisce, con spezzoni ricostruiti in dimensioni reali, altrettante tappe fondamentali della storia di Gae Aulenti.
Per una felice combinazione il percorso aperto dalla corsa delle amazzoni picassiane si chiude con i due progetti per, rispettivamente, la stazione Museo della metropolitana di Napoli (2001) e l’«aeroportino» di Perugia (2012), che è l’ultimo lavoro: una chiusura che suona come un commiato, con il tocco struggente dato dall’apparire sui monitor degli arrivi e partenze dei disegni dell’amatissimo nipote Pietro, inseriti come lampi nell’elenco dei progetti, realizzati e non, di nonna Gae.
Tra l’incipit e l’exit della mostra, lo spettatore ha sperimentato continui spiazzamenti. Davanti a lui si è palesato uno spaccato del negozio Fiat di Zurigo (1973) con le automobili disposte spericolatamente su una parabolica, come se la strada avesse fatto irruzione nel negozio. Ha messo piede nel salotto di casa Brion a San Michele di Pagana (1973), dove il senso di morbidezza dato dalla moquette è chiamato a una resa dei conti con le complicazioni introdotte dai rialzi, dai gradini e soprattutto dal brusco presidio dei pilastri.
I pilastri sono un marchio di fabbrica, una cifra «psichica» più che stilistica che pervade, in modo trasversale, i lavori di Gae Aulenti: dominano con la loro caratura drammatica sulla scena
della celebre Elektra scaligera con la regia di Luca Ronconi (1994); stipano lo spazio aggraziato dell’aeroportino di Perugia; si fanno foresta urbana nel rifacimento di Piazza Cadorna a Milano (2000); diventano elementi attorno ai quali far ruotare lo spazio labirintico immaginato per la mostra dedicata a Christo alla Rotonda della Besana a Milano (1973). Il pilastro è una sorta di costante drammatica che vigila sulla scena architettonica mettendosi di traverso rispetto a ogni rischio di percezione accomodante. È il segno, volutamente invasivo, del pensiero e dell’energia critica che abita ogni progetto della Gae.
Per lei, scriveva Alberto Arbasino, c’è un’equivalenza di piani tra «riflessioni critiche, idee, muri e mattoni», tutti allo stesso modo «strumenti culturali e concreti». Un concetto chiarito nel meraviglioso incipit dello scritto dedicatole in Ritratti italiani (Adelphi): «Gae Aulenti dice, con calma: mai Decoration; soltanto Design. Spiega meglio, criticamente: Struttura non superficie. Cioè Forma, non epidermide, né rivestimento».
Questa visione emerge liberata in tutta la sua drasticità nei due allestimenti teatrali riproposti nella «macchina evocatoria» della mostra milanese: l’Elektra, dove la reggia di Micene era trasformata in un mattatoio insanguinato, e le Baccanti (1977), sempre per la regia di Ronconi, al Laboratorio di Progettazione di Prato. In mostra ci si addentra nello spazio claustrofobico dove davanti a due letti d’ospedale gli spettatori (solo 24) assistevano alla recita di una parte del secondo stasimo della tragedia. La traduzione era di Edoardo Sanguineti, che dopo lo spettacolo ammise di aver capito «per la prima volta cos’è una tragedia greca».
Quello con Ronconi è un rapporto chiave per Gae Aulenti. Si erano conosciuti nei camerini della Scala nel 1974, dopo la prima contestatissima dellaWalkiria con le scene di Pier Luigi Pizzi. Lei si era fatta avanti per esternare tutta la propria ammirazione, e da lì era scattata la voglia di iniziare a collaborare. Ronconi, semplicemente «Luca», non poteva mancare nel mazzo delle 88 carte (disegnate da Giovanna Buzzi) dei personaggi, pubblici e privati, che hanno popolato i mondi di Gae Aulenti. Un «Gioco», in vendita a 20 euro, che è parte integrante del congegno della mostra. Come scrive Agosti «gli spazi sono degli stati in luogo, quasi la realizzazione delle didascalie di un dramma, dove gli attori sono quelli figurati dalle carte da gioco».
Ma sulla scena di Gae Aulenti si poteva entrare anche per vie privilegiate aperte in forza di tenerezza, come testimonia la foto indimenticabile di lei che tiene per mano la nipotina Nina nel tumulto del cantiere del Musée d’Orsay.
Da il manifesto – Hebron Road è la strada che da sempre ha dato la possibilità di raggiungere Al Khalil (Hebron) da Gerusalemme. Se una volta questa via era continua, oggi è interrotta dall’enorme muro che Israele ha costruito dopo la seconda intifada nel 2002. Palazzi abbandonati a fianco di grattacieli nuovi danno vita a un contrasto che assume tratti surreali quando si inizia a scorgere l’immensa struttura di cemento che blocca l’orizzonte.
«Questa strada è un microcosmo, rappresenta la situazione generale in tutte le sue contraddizioni» dice Emily Jacir, direttrice del centro culturale e residenza artistica Dar Jacir. Il centro sorge proprio su questo grande viale a Betlemme. Una struttura costruita nel 1880 da un avo di Emily, che oggi ospita artisti da tutto il mondo e, soprattutto, da tutta la Palestina storica, rendendolo luogo di eredità radicate nella terra. «I palestinesi non hanno accesso ai musei di Gerusalemme dove è conservata la nostra storia», dice Emily, che aggiunge «la nostra comunità è frammentata e disseminata in tutto il mondo, la nostra narrazione è interrotta».
Dar Jacir è un luogo di salvaguardia del patrimonio culturale palestinese: «Quando le persone vedono le vecchie fotografie di questa strada, riconoscono il nostro passato. Noi veniamo da qua». «I nostri vicini sono i campi profughi di Aida e di Azza, qui lavoriamo molto con i bambini, offriamo corsi di musica, agricoltura, arte e danza – prosegue Emily – questo è uno spazio interdisciplinare e transgenerazionale dove le persone si riuniscono per vivere insieme, farsi domande e creare progetti».
Ad Al-Khalil, al capo opposto di questa lunga strada, è stato concepito il progetto Artist + Allies x Hebron (AAH), fondato dal fotografo sudafricano Adam Broomber e dall’attivista palestinese Issa Amro. Il collettivo artistico si propone di preservare l’arte e la natura agricola della Cisgiordania meridionale e di sostenere gli artisti palestinesi e internazionali impegnati nella resistenza culturale contro l’occupazione.
Dalla collaborazione tra Dar Jacir e AAH è nata l’esposizione South West Bank: Landworks, Collective Action and Sound a Palazzo Contarini Polignac, come evento collaterale alla 60a Biennale di Venezia. I territori palestinesi non hanno mai avuto uno spazio all’interno dei Giardini, pur essendo sempre rappresentati da un notevole numero di artisti. Quest’anno le proteste contro il genocidio a Gaza hanno portato alla chiusura del padiglione israeliano.
«Penso che sia molto importante che in un momento come questo la Palestina sia presente alla Biennale» sostiene Broomberg. La mostra South West Bank comprende sia le opere di artiste palestinesi, come Dima Srouji e Shaima Hamad, che quelle di internazionali. Tra queste il progetto fotografico “Anchor in the Landscape” di Adam Broomberg e Rafael González, che riflette sul ruolo totemico dell’ulivo nell’identità palestinese.
L’albero era già stato protagonista di un’altra opera firmata AAH, “H2 – Counter Surveillance”. Per sensibilizzare sull’uso pervasivo della video sorveglianza da parte dello Stato israeliano, gli artisti hanno inserito alcune telecamere di sorveglianza tra le fronde degli alberi, registrando giorno e notte le colonie israeliane. I filmati sono stati proiettati in tempo reale in musei di tutto il mondo, capovolgendo la prospettiva di ipervigilanza militare di Israele.
Adam Broomberg, di famiglia ebraica di origini lituane, è nato e cresciuto nel Sudafrica dell’apartheid, in cui riconosce somiglianze e differenze con l’occupazione nei territori palestinesi. Tra gli obiettivi del collettivo AAH c’è anche quello di portare la comunità internazionale in Cisgiordania, «perché si può parlare e parlare, ma una volta lì, ci vogliono cinque minuti per capire cosa significano discriminazione e apartheid», spiega Broomberg. Il fotografo è stato definito antisemita e ha perso la sua posizione di professore all’università di Amburgo per le sue dichiarazioni a sostegno della Palestina. «Il lavoro culturale come questo funziona, perché altrimenti non vorrebbero fermarci», sostiene Broomberg: «Penso che l’arte sia un modo sottile di rendere le persone consapevoli di ciò che sta accadendo».
A due passi dall’enorme struttura divisoria di cemento armato, Dar Jacir sembra un’oasi in mezzo al caos. Ulivi, diversi tipi di piante e grandi alberi che «nascondono il muro ai nostri occhi per qualche istante», dice Bisho, un giovane artista di Betlemme in residenza. Il ragazzo palestinese, che si occupa di riciclo di tessuti e tinture naturali, racconta di aver trovato un luogo di pace ma anche di incontro, dove gli artisti palestinesi scambiano idee e visioni con quelli internazionali. Bisho crede «nella condivisione delle esperienze. Per noi è difficile spostarsi e quindi siamo molto aperti a scambi con gli stranieri, è una possibilità di viaggiare senza muoversi».
Da la Repubblica – Robinson – Due grandi mostre, aperte alla Galleria Borghese di Roma e al Museo Novecento di Firenze, celebrano finalmente in Italia l’artista vissuta quasi un secolo che ha definitivamente liberato la creatività dal monopolio maschile. E che oggi continua a ispirare
Quanti interrogativi affiorano dal suo ghigno secco e da quel reticolo di rughe che è una matassa di ricordi emersi in superficie. Quanta ironia possiede ogni immagine della sua persona. E di quanta capacità di filtrare, modellare, spezzettare per poi rivisitare le cose del mondo, soffrendo ma anche giocando, si nutre ogni sua opera. Louise Bourgeois è un’artista sovraccarica di rinvii simbolici che esprime dimensioni spesso bipolari per raccontarci l’esistenza con le sue contraddizioni, i suoi traumi, le sue oscenità e i suoi conflitti, addensandola in una sfera traversata dalla psicoanalisi e dal mito. È una portatrice di affondi nella violenza relazionale e un’artefice di dilatazioni barocche degli sconvolgimenti del Novecento. È pure la fattucchiera che in un celebre ritratto di Robert Mapplethorpe reca sottobraccio un fallo enorme. Bellicoso? O difensivo come una clava? Si tratta di una sua scultura, Fillette, cioè ragazzina: «Per fare la foto avevo portato con me una piccola Louise», scrive lei. «Quell’opera mi rassicurava». Brandisci il pene, prima che lui catturi te.
Ora due grandi mostre in Italia, a Roma e a Firenze, celebrano il genio di Louise, nata a Parigi nel 1911 e morta a New York nel 2010. Visse in Francia fino al 1938 e poi in America, viaggiando nel frattempo in Europa e in Italia, dove passò periodi a Pietrasanta e a Carrara, nei laboratori del marmo. L’attuale riconoscimento italiano, forse tardivo vista la mole del personaggio e dei suoi influssi, esalta il segno di un’inventrice prolifica e autonoma, distante dai minimalismi, dai concettualismi e dagli espressionismi astratti del secolo scorso. Alla Galleria Borghese s’apre Louise Bourgeois. L’inconscio della memoria, esposizione votata alla sua prassi scultorea, mentre il Museo Novecento presenta Louise Bourgeois in Florence, progetto sdoppiato col Museo degli Innocenti, sede di Cell XVIII (Portrait), cioè di una delle famose “Celle” di Louise. Questa categoria di lavori anni Novanta consiste in una trafila di paesaggi ingabbiati che contengono emblemi e relitti: specchi, ghigliottine, sedie fluttuanti, sacchi di stoffa, pelli di coniglio, letti, fantocci, ex voto… Illusioni carcerarie o monastiche. Ricettacoli di proliferazioni dell’inconscio. Ma anche sviluppi del tema della donna-casa che negli anni Quaranta era al centro della serie di pitture Femme-Maison, dove i corpi metà donna e metà edifici scavavano nell’identità femminile soffocata dalle prigioni domestiche.
Aveva genitori pesanti, Louise, e li portò sulle spalle per tutta la vita. La sua arte fu una pluridecennale seduta psicoanalitica per affrancarsi da loro, o ridisegnarli a modo proprio. Qualcosa di universale, nella rappresentazione di quegli spettri, oltrepassa di molto l’autobiografia parlandoci di spirito e sesso, vita e morte, anima e corpo, misoginia e fallocrazia. Sua madre era Joséphine Fauriaux, suo padre era Louis Bourgeois. Restauravano arazzi. Lui era dispotico, umiliante e fanatico dei bordelli. Lei teneva insieme la famiglia distogliendo lo sguardo dai tradimenti del marito. Louise impara la cura delle stoffe, la pratica dei colori, la ricomposizione dei pezzi mancanti nei corpi. Inizia studi di matematica alla Sorbonne e li lascia per l’École des Beaux-Arts. Poi trasmigra negli atelier di artisti come Ferdinand Léger, che la spinge verso la scultura. Farà anche installazioni, narrazioni oggettistiche, teatrini onirici, gouaches (scarlatte e colme di senso d’umido, evocative di fluidi corporei) e iperbolici ragni materni. Userà il gesso, il cemento, il lattice, il marmo, il bronzo, il legno e la stoffa, corteggiata con l’antica arma infantile dell’ago. Non si dà confini: indaga materiali e disposizioni delle forme in spazi minimi e massimi, da esploratrice del cosmo. Sposa l’americano Robert Goldwater, che insegna storia dell’arte, e parte con lui per gli Stati Uniti. A New York trova i surrealisti Marcel Duchamp e André Breton, maschi indifferenti all’arte delle donne. «Erano interessati alle donne ricche, questo sì», scrive Louise, «ed erano interessati soprattutto a sé stessi». Lei è rimasta ancorata ai voli azzurri di Joan Miró, scoperto negli anni parigini e descritto come «un magnifico shock estetico». A New York la memoria è il suo racconto: nel ’50 plasma figure totemiche, diciassette sculture lignee che richiamano le persone lasciate in Francia. «Mi mancavano disperatamente».
In tempi successivi privilegia i falli, che però non sono mai soltanto falli. Sono fiabe, sfide, gusci misterici. Escrescenze microbiologiche e aggregazioni collinari. Vedi gli addensamenti di cazzetti in marmo nero dell’opera Colonnata. A volte paiono fanciulline oblunghe e pettorute (Fillette); a volte si miscelano nel bronzo di una forma organica bifronte che mima testicoli e fessure, o insegue mammelle amalgamabili coi genitali maschili (Janus Fleuri). Opposizione, scissione, ansia di risolvere il dualismo.
Risale al ’74 The Destruction of the Father, ritratto di famiglia situato in un antro pieno di protuberanze viscerali. «È l’orrida cena capeggiata dal padre che si siede e gode», scrive. «E gli altri, la madre e i figli? Stanno in silenzio. La madre cerca di soddisfare il tiranno, suo marito». Tramite frammenti di carne macellata allestisce il banchetto cannibalesco. È una vendetta rituale. «Più mio padre si pavoneggiava, più ci sentivamo insignificanti», spiega. «Improvvisamente si creava una tensione terribile e noi lo afferravamo, lo trascinavamo sul tavolo e lo smembravamo. Fantasie, ma talvolta la fantasia è vissuto». Nell’estro di Bourgeois si stagliano scenari da tragedia greca che ispireranno non poco la Abramović, ma non soltanto. Un’ondata femminista di fine Novecento (Kiki Smith, Rona Pondick e altre) prese Louise come punto di riferimento per svelare la corporeità, anche nei tabù e nell’enfasi del rapporto madre-figlio. L’ultima, ossessiva icona di Bourgeois sono i ragni, col loro abbraccio dominatore e protettivo. Di proporzioni abnormi, sorgono in diverse città del mondo. Il ragno è la madre. È intelligenza procreativa. Ma è anche tessitura di una tela, costruzione dell’arte, emanazione della fillette Louise che ammanta con una cupola le nostre paure.
Louise Bourgeois. L’inconscio della memoria è alla Galleria Borghese di Roma fino al 15 settembre, a cura di Cloé Perrone, Geraldine Léardi e Philip Larratt-Smith in collaborazione con The Easton Foundation e l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici. “Esistere come donna” è il programma di incontri e proiezioni a cura di Electa e Fondamenta che la accompagna: galleriaborghese.beniculturali.it Louise Bourgeois in Florence Do Not Abandon Me è al Museo Novecento di Firenze fino al 20 ottobre, a cura di Philip Larratt-Smith e Sergio Risaliti: Cell XVIII (Portrait) a cura di Philip Larratt-Smith con Arabella Natalini e Stefania Rispoli è nelle stesse date al Museo degli Innocenti di Firenze.
Da la Repubblica – Robinson – «Mi diceva: lavora in cucina, in bagno, in camera da letto, ovunque. E mettitelo bene in testa: hai un sacco di tempo davanti a te». Nei ricordi di Tracey Emin, Louise Bourgeois è ancora lì che la sprona, la rimprovera, le dà consigli, condividendo con lei il mistero dell’arte. L’ex ragazza terribile della scena inglese, appena nominata Dame Commander dell’Impero britannico dal re Carlo III, ha vissuto con la madre di tutte le artiste contemporanee un curioso sodalizio. Lontane quasi mezzo secolo per l’anagrafe, firmarono insieme il progetto Do Not Abandon Me, fondendo il loro stile e i colori in acquerelli unici. Tracey ha poi dedicato all’amica un documentario della Bbc e oggi, mentre è alle prese con una mostra a Bruxelles, prepara quella del 2025 al fiorentino Palazzo Strozzi e revisiona una monografia in uscita da Phaidon, si abbandona volentieri al racconto di una Bourgeois vista da molto vicino.
Dame Tracey Emin, quando si è imbattuta per la prima volta nell’arte di Louise Bourgeois?
«Nel 1996: il curatore Stuart Morgan fu il primo a parlarmene. Mi invitò a vedere la mostra della “sua amica Louise” alla Tate, dicendomi che sicuramente l’avrei apprezzata. E così mi ritrovai davanti ad alcune acqueforti. Erano datate anni Quaranta e iniziai a chiedermi perché mai. Guardando quelle opere, ero convinta che Bourgeois avesse la mia stessa età. Non ne sapevo niente, non avevo mai letto nulla di lei. Solo più tardi avrei scoperto che era molto, molto più anziana. E diventammo amiche».
Dove vi incontraste?
«A casa sua a New York, nel 2007. Riuscii ad avere un appuntamento. La cosa assurda fu che la porta era aperta. Entrai e chiamai. L’assistente, Jerry Gorovoy, scese giù dalle scale e mi chiese: come sei entrata? E io: la porta era aperta. E lui: impossibile. Forse era stata Louise stessa ad aprirla. Non lo scoprimmo mai. Lei, già ultranovantenne, era nel suo studio e ogni cosa in quella stanza appariva grigia e monotona, eccetto il pavimento che splendeva del magenta dei suoi disegni. Brillava intensamente. Louise era seduta al tavolo da lavoro. La guardavo e ricordo di essermi resa conto che aveva un seno enorme, gigantesco, e che non ero mai stata nella stessa stanza con una persona così anziana, la più anziana con cui avessi mai parlato. Fu tutto strano e intenso: andammo subito d’accordo».
Bourgeois le chiese di collaborare con lei. Fu una richiesta unica. Non era mai capitato con nessuno.
«Sì, accadde un anno dopo. Una sorpresa enorme per me. Ero abbastanza nervosa per questo. Lei iniziò a dirmi: fa’ quello vuoi, qualsiasi cosa, incasina tutto. Fa’ quello che vuoi. Più lo diceva e più diventavo nervosa. Alla fine, mi ci sono voluti due anni prima che realizzassi la mia parte, aggiungendo il mio tratto alle sue invenzioni. Ho fatto tutto in un solo weekend, ho arrotolato i disegni e glieli ho rispediti. Lei era a letto quando le sono stati recapitati. Jerry glieli srotolava e, ogni volta che Louise ne vedeva uno, esultava. Li ha apprezzati tantissimo. Compresi i peni, gli uomini nudi. Fu molto sorpresa. Voleva che effettivamente il risultato finale della nostra collaborazione risultasse come di una sola mano. L’ego non era contemplato».
Bourgeois iniziò a lavorare in un mondo dell’arte ancora tutto maschile: è stata una pioniera.
«La sua rivoluzione fu di realizzare progetti di qualsiasi dimensione. Dai piccoli disegni alle sculture giganti. Nulla era impossibile per lei. Non si poteva dirle di no. È stata la prima donna artista a ragionare così. Faceva esattamente ciò che voleva, anche se, certo, si muoveva in un mondo
ancora tutto maschile. Eppure manteneva una sua femminilità nei lavori. Nessun uomo avrebbe potuto fare quello che faceva Louise: qualcosa di ultra-femminile e, talvolta, enorme nelle proporzioni. Ha rotto una marea di barriere per noi. È stata un modello eccezionale. Il suo vero insegnamento era dire: fallo e basta».
Che cosa è cambiato da allora nel mondo dell’arte?
«Fino a una decina d’anni fa, il pubblico riusciva a stento a fare il nome di dieci artiste. Ora ci sono tante artiste e artisti black, c’è più diversità. Quando Louise era giovane, c’erano donne nel mondo dell’arte, ma erano più figure legate alle istituzioni o al mercato, penso a Peggy Guggenheim. Artiste come Joan Mitchell hanno impiegato tanto tempo per essere apprezzate. Bourgeois stessa ha dovuto superare la sessantina per essere riconosciuta. E pensare che adesso sono io ad avere sessant’anni! La mia generazione ha vissuto un sacco di cambiamenti».
Louise si sentì più libera di creare dopo la morte di suo marito, Robert Goldwater, nel 1973.
«Decisamente. Trasformò la casa di New York nel suo studio. Ogni singola parte. Amava suo marito, ma come artista credo si sentisse un po’ frenata, durante il matrimonio. Ricordiamoci che era anche madre. Aveva un mucchio di distrazioni domestiche».
Una volta, lei, Tracy, ha detto che per continuare a essere artista non avrebbe potuto diventare madre.
«È vero. Non sarei stata in grado di conciliare entrambe le cose. Alcune donne ci riescono. Ma per me sarebbe risultato impossibile. È il mio cuore che mi guida, che mi sveglia al mattino. Sono i sentimenti. Per questo, se avessi avuto un bambino, non sarei riuscita a separarmene. E non avrei potuto fare anche l’artista. Avrei fatto male una delle due cose, sicuramente. La mia energia funziona così. Il mio tempo è questo. Ma sono una madre di gatti, e va bene così».
Bourgeois ha definito la sua idea di maternità con il ragno: la serie di aracnidi giganti ribattezzati “Maman” che sono nei musei di tutto mondo.
«Per lei il ragno è l’essere femminile che depone le uova, ha più gambe, è in grado di essere qualsiasi cosa, apparentemente fragile ma forte. I ragni che Louise realizza su ampia scala, poi, sono come dei rifugi. Ci si può riparare sotto e sentirsi sicuri. E questa idea di maternità così concreta è geniale. La sua Maman è una creatura che protegge».
Ricorda l’ultima volta che vi siete incontrate?
«Era a New York, un paio di mesi prima che morisse, nel 2010. Guardammo insieme un libro di opere giovanili e parlammo un sacco. Mi diceva sempre: (ne imita la voce) tu hai tempo, tu hai tempo. Era una cosa che mi ripeteva spesso perché effettivamente io non me ne rendevo conto. Non capivo quanto tempo avessi rispetto a Louise. E quanto ancora ne avessi a disposizione per cambiare completamente la mia vita. Louise cambiò la sua a sessantaquattro anni. Io ancora non sono arrivata a quell’età».
L’ha mai sognata in questi anni?
«Sì, uno strano sogno. L’ho vista su una diga, sembrava di essere a Venezia. Louise era in piedi davanti all’acqua, che mi aspettava».