Nell’incipit del suo saggio titolato “Spazi metrici”, Amelia Rosselli scriveva: «Una problematica della forma poetica è stata per me sempre connessa a quella più strettamente musicale, e non ho in realtà mai scisso le due discipline, considerando la sillaba non solo come nesso ortografico ma anche come suono, e il periodo non solo un costrutto grammaticale, ma anche un sistema».
In effetti, non si riflette mai abbastanza sul fatto che la musica e il linguaggio adoperano per prendere forma la stessa materia: il suono. Del resto, in poesia, la rima, l’assonanza, l’allitterazione sono effetti sonori. Non solo, ma nel linguaggio colloquiale esistono emissioni sonore, interiezioni, esclamazioni che non sono parola, fatte di brevi o lunghe sillabazioni, che possiedono una grande forza significante. Altre volte si pronunciano singoli fonemi senza senso apparente, ma che per una sorta di codice secolare, e forse millenario, si fanno subito intendere: ehm, brrr, oooh! In genere, narratori, filosofi, poeti, chiunque scriva per farsi leggere, presta una grande attenzione all’effetto sonoro della propria scrittura. Flaubert leggeva ad alta voce, per sincerarsi della efficacia di ogni sua frase. Lucrezio sostiene, in un passo famoso del suo poema Sulla natura delle cose che musica e linguaggio sono nati insieme. Sant’Agostino, nel suo trattato sulla musica, si sofferma sulle radici del ritmo, sugli schemi metrici della poesia, come fondamento del ritmo musicale.
Ancora oggi, una pagina di Bach ci suggerisce un ritmo anapestico, come nel terzo concerto brandeburghese; e l’ouverture al Coriolano di Beethoven un martellante e ossessivo ritmo giambico. Sull’importanza dell’effetto sonoro del linguaggio insiste in tutti i suoi saggi il grande Émile Benveniste, e in particolare in uno di essi ipotizza che la musica nasca dalla interiezione stilizzata; mentre negli appunti su Baudelaire si concentra sulla venuta a galla del valore simbolico del suono, e dunque del linguaggio. Amelia Rosselli, una delle voci poetiche più intense del Novecento non solo italiano, sembra riassumere splendidamente nei suoi versi questi nessi tra musica e linguaggio. Del resto, la musica era stata forse la sua prima passione, che aveva coltivato al punto di arrivare – come ricorda nella intervista qui a fianco – a frequentare i corsi di Darmstadt, tenuti tra gli altri da Stockhausen. Suonava professionalmente l’organo, oltre al pianoforte. Fra il ’52 e il ’54 pubblicò alcuni saggi su “Diapason” e su “Civiltà delle macchine”, riviste alle quali l’aveva introdotta Leonardo Sinisgalli, l’ingegnere-poeta. Dopo quattordici anni di ricerche presso biblioteche italiane, francesi, inglesi, gli scritti di etnomusicologia di Amelia Rosselli confluirono nel “Verri”. Partiva, per superarle, da tradizioni bartokiane, frequentò gli studi elettronici della Rai, e al Musée de l’Homme di Parigi, dopo essersi concentrata su musiche non temperate, anche orientali, ne spiegò il sistema sottostante, quella struttura universale che era stata fino ad allora solo intuita, e d’istinto «seguita da musicisti non influenzati dal razionalismo leibnitizano, del Sei-Settecento».
Non aveva una lingua principale, e semmai avrebbe potuto essere l’inglese della madre; ma essendo nata a Parigi, la prima lingua alla quale venne esposta fu il francese. Adottare poi l’italiano del padre fu una scelta. Di questo suo plurilinguismo si sente l’eco nella scrittura, e il passaggio da una lingua all’altra sembra a volte aggiungere ferite alla sua esistenza difficile. Nel trentesimo anniversario della sua fine tragica, un convegno internazionale la ricorderà all’Università di Roma Tre e alla Sapienza. Il pomeriggio del 12 febbraio, al Palazzo delle Esposizioni all’Eur, si inaugurerà la mostra titolata Improvvisi per una identificazione e si terranno letture delle sue poesie. Il 13 febbraio, infine, nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre, la giornata conclusiva. Ascoltare, recitate, le poesie di Amelia Rosselli sarà un tentativo di restituirle quella voce che nei trascorsi trent’anni non ha cessato di mancarci.
(il manifesto, 8 febbraio 2026)
Intervista ad Amelia Rosselli
di Francesca Borrelli, maggio 1992
La prima singolarità che si impone al lettore è il suo passare dall’inglese all’italiano al francese, lingue indifferentemente evocabili dal pensiero che le possiede e le manovra dalla prima adolescenza. “Sleep” contiene versi scritti tra il ’53 e il ’66, in inglese, una lingua alta, nutrita di letture di classici…
La credevo un misto di inglese e di americano, ma rivedendo il libro ho scoperto che è molto più legata alla lingua inglese nella quale leggevo a quel tempo; inoltre, ci sono dentro i ricordi indelebili del teatro shakespeariano: ho avuto occasione di vedere Laurence Olivier recitare Amleto, Otello, Re Lear, e non posso dimenticare Alec Guinness nella sua interpretazione tutta diversa di Amleto. Infatti, non possono sfuggire le connotazioni elisabettiane del lessico, della sintassi, della grafia nell’impiego delle maiuscole; persino l’intento appare chiaramente parodistico. È così?
Eccome, c’è una presa in giro del teatro shakesperiano che si esprime, per esempio, attraverso una delle voci parlanti, quella del fool che si burla del re e delle sue corti. Ma poi, seguendo l’ordine cronologico nel quale è organizzata l’antologia, ci si accorge che senza cessare di fare il verso alla lingua elisabettiana, e senza abbandonare del tutto il registro pseudometafisico, le poesie scritte intorno al ’65 esprimono un rapporto con l’uomo più concreto, e assumono connotazioni molto più sessuate. Nel cinque e seicento inglese era l’uomo che si rivolgeva all’amata, e a questo proposito nel mio libro c’è un incontro-scontro con certa critica di tipo femminista che però non condivide nulla con l’ambiente italiano, è molto anglosassone. Nel cinque e seicento per metafisica si intendeva filosofia + dio, mentre oggi si riportano quei problemi al confine con l’ambito sociologico-femminista. Comunque, l’ironia ha cominciato a rompermi le scatole. È triste il fool, non ironico: è un giocoliere. E ho messo molta presa in giro in quel tu che spesso indica me come interlocutrice: non descrivo esperienze autobiografiche – l’unico libro in cui lo faccio, scritto in francese, è Le chinois à Rome. Qui sono solo fantasie, perché le mie esperienze vere le avrei piuttosto trascritte, a questo punto, in italiano. Una volta mi venne l’immagine di me su delle palafitte, che pensavo in inglese ma vivevo in Italia.
E quel titolo di una sola parola, “Sleep”, da cosa viene?
Vuol dire sonno, e credo di averlo preso da un famoso soliloquio di Amleto, quando dice di averne nostalgia, e poi ritorna nel famoso Essere o non essere, quando dice, per esempio «Dormire, forse sognare, si, lì è l’intoppo». Ma sleep ha anche una valenza ironica, perché, in quelle poesie si esprime una attività frenetica, almeno per quel che riguarda l’immaginario. Inoltre, con la sua doppia e, la parola sleep ha una alta densità femminile, il suo suono include in qualche modo sonno e sogni. E per ultimo, allude una ragione autobiografica: a quel tempo soffrivo di insonnie feroci, dunque il sonno per me era un miraggio.
Cosa porta alla scrittura non solo il fatto di possedere interamente tre lingue, ma l’alternare nei diversi idiomi il flusso del pensiero?
È un problema; sospetto che se si pensa in tre lingue vuol dire che non ci si è ancora risolti a decidere dove si vuole vivere; sono stata parecchio vagante e ho avuto più di una esitazione su dove fermarmi. A determinare la mia permanenza a Roma è stato il lavoro di traduttrice, che svolgevo per le edizioni Comunità di Adriano Olivetti, dal ’49 al ’54. Vivevo in camere d’affitto, passai un anno anche in una pensione, fino a quando mia nonna mi lasciò qualcosa che servì per comprare una casa a Trastevere.
Ma la sua vita avrebbe potuto fermarsi altrove, in Inghilterra, per esempio, dove vivevano i fratelli, o a Parigi, dove aveva trascorso parte dell’infanzia…
Finché con l’entrata dei nazisti in Francia dovemmo scappare; stavamo per andare in Algeria con Louis Joxe, allora segretario di De Gaulle, e la sua famiglia, ma partirono solo i nostri bauli, perché qualcosa fece cambiare idea a mia madre. Perciò approdammo in Inghilterra, e dopo i primi allarme dei bombardamenti a Londra, raggiungemmo gli Stati Uniti in nave. Benché non sia mai stata in Algeria, me ne è rimasta una sorta di nostalgia; dopo la fine della guerra avevo una fissazione per la politica mediorientale. Del resto, ho un lato semitico-desertico.
A quale luogo sono legati i ricordi migliori?
I tre anni che passai accanto a mia madre furono il mio periodo più felice; stavamo a Larchmont, un paese di pendolari vicino New York, nella Westchester County dove ha vissuto molto anche Fitzgerald, che ne parla in uno dei suoi primi libri. Non lontano da noi abitavano Enrico Fermi, Toscanini, Salvemini che al sabato veniva a trovare mia nonna: era la società Mazzini, sede di molte riunioni di antifascisti, che da New York indicava i luoghi relativamente sicuri dove sfollare. Durante il periodo del ginnasio e del liceo, d’estate andavamo a lavorare nei campi; ce n’era bisogno anche in America durante la guerra. Una volta andai con tutti i miei cugini nel Vermont, in un campo quacchero; là, imparammo ad andare a cavallo, a fare lavori pesanti, a tagliare gli alberi, e mungere le vacche. Poi, la domenica andavamo a riposarci nei boschi, e chi voleva si alzava e proponeva una discussione su temi che gli stavano a cuore.
Nel corso di una bellissima trasmissione radiofonica a lei dedicata e condotta da Gabriella Caramore lei parlò di un suo tentativo di salvare dallo spreco e dall’esaurimento il nostro flusso interiore di pensieri…
Sì, ricordo che lo dissi per rispondere a Zanzotto, che parlava del corpo a corpo con la realtà nella mia poesia: lo diceva molto bene, ed è vero, nei miei versi c’è anche questo. Ma sotto sotto abbiamo tutti paura di sprecare la nostra interiorità, ed è questo che volevo dire con quella frase nella quale, implicitamente, citavo Virginia Woolf: fu lei per prima a occuparsi dello stream of thought. È una tecnica che, dal punto di vista della descrizione psicologica non mi interessa affatto e tuttavia, nella vita è quel che ci salva. Per me scrivere serve, in un certo senso, a portare nuova ricchezza alla mia e alla altrui interiorità: sta anche in questo la valenza etica della poesia.
Uno tra i tanti luoghi comuni della critica ha individuato nel lapsus una componente quasi organica alla sua poesia. Alcuni esempi tornano anche nei versi dell’ultimo libro, e tuttavia il rimando freudiano è spesso improprio, perché non di errore involontariosi tratta, quanto di sovrapposizioni delle diverse lingue. È d’accordo?
Sì, il primo a parlarne fu Pasolini in un saggio scritto come postfazione alle mie prime poesie, pubblicate da Vittorini e Calvino su Menabò n. 6 del ’63. Gli avevo consegnato un mio personale glossario, spiegandogli il perché di queste fusioni di parole, di questi giochi linguistici; ma non tutti i critici erano così intelligenti come Pasolini. Si continuò a parlare dei miei lapsus anche quando non ce n’erano. Per esempio, già nel mio terzo libro e n’è uno solo, mnemonico, quando per nominare l’albero di una nave uso un inglesismo e dunque lo chiamo masto da mast. Sarebbe meglio abbandonare il termine lapsus, che non appartiene alla filologia e che necessita sempre di aggettivi che lo definiscano, introducendo così una complicazione in più: molto spesso non si tratta che di invenzioni di parole, incroci di lingue, slang o anche di grafismi; e sono chiari, in tutto ciò, gli influssi della poesia di Cummings e di Hopkins, autori che a quel tempo leggevo molto. Anche Emmanuela Tandello, la traduttrice di Sleep, torna sul lapsus; ma intende parlare di parallelismi tra le due lingue, come quando uso shallop per riferirmi alla scialuppa invece di tender.
In margine alle poesie pubblicate su Menabò, che sarebbero andate poi a far parte della raccolta Variazioni belliche, una nota biografica dice che «Svolge professione, come teorica e compositrice, di musicista». Fu dunque questa la sua prima inclinazione?
La mia scelta musicale sembrava una follia, perché la mia famiglia era rimasta senza soldi e mio padre, che all’origine ne aveva, decise di spendere tutto per finanziare Giustizia e Libertà e l’attività clandestina. Poi, quando scoppiò la guerra di Spagna, finanziò un battaglione dove confluirono molti esuli francesi. Pensava che i figli dovessero lavorare, giustamente; ma, insomma, non avevo abbastanza soldi per svolgere studi regolari. Avevo cominciato a suonare il violino a Londra, a sedici anni, poi continuai a Firenze, dove studiai anche pianoforte. Incontrai Luigi Dallapiccola, che mi introdusse ai libri di teoria dodecafonica, e fu a lui che presentai le mie prime composizioni. Ma era stato Petrassi a indicarmi quello che sarebbe diventato il mio maestro. Lo strumento che avrei, più avanti, potuto suonare in modo professionale era l’organo: adoravo la musica del cinque e seicento, prendevo lezioni private a Roma a piazza del Popolo. Ma, poi, come per istinto, smisi di suonare. Allora, non mi era stato ancora diagnosticato il morbo di Parkinson. Decisi di dedicarmi agli studi di composizione: ragioni di ordine fisiologico mi spingevano verso un lavoro creativo piuttosto che interpretativo. Andai a Darmstadt, come usavano fare i compositori. Lì insegnavano, tra gli altri, Stockhausen, Boulez e Tudor, il pianista di John Cage, che in seguito mi chiamò a lavorare con lui a uno spettacolo al Sistina al quale collaborava anche Merce Cunningham. Io mi
esprimevo piuttosto tramite una gestualità improvvisata, e a un certo punto mi misi a cantare un canto gregoriano, finché, qualcuno dal pubblico gridò: «Amen». A Cage non fece per nulla piacere. Ero una postbartokiana, dunque con le tesi di Cage non andavo d’accordo, ma lui era straordinariamente intelligente, forse un po’ troppo dogmatico; comunque quel che ha distrutto (del sistema tonale, temperato, dodecafonico) l’ha distrutto bene. Una volta, a Darmstadt, mi era stato dato un lavoro sulla sua musica e passai cinque nottate a capovolgere le sue tesi: a forza di fare grafici ebbi una allucinazione sonora, arrivai a sentirmi dentro tutta la partitura. Davvero, ascoltai l’intero pezzo. E mi presi un enorme spavento.
C’è almeno uno studio di etnomusicologia, che rimarrà nella storia delle sue pubblicazioni a pari diritto con la sua poesia: è un saggio uscito su “Civiltà delle macchine” prima e poi sul “Verri” di Luciano Anceschi, frutto di quattordici anni di ricerche in Italia, in Francia, e a Londra.
Volevo studiare quali erano le vere sottostrutture, non ancora trascritte o analizzate, dei canti e degli strumenti del terzo mondo e di quello orientale, dove il sistema temperato non ha avuto influsso. Un lavoro di taglio strutturalistico, che si basa sulla rivalutazione della musica folk di ascendenze sia africane che orientali: partendo dallo studio della teoria dodecafonica e da quello della musica di Bartók, ho tentato di introdurre ciò che si potrebbe chiamare un allargamento della teoria in rapporto con la musica popolare; e in particolare con la costruzione di strumenti le cui scale differiscono da quella del pianoforte, poiché sono basate sulla realtà fisica e le leggi acustiche, diversamente da quanto accade nella scala temperata. A questo scopo ho fatto costruire da una fabbrica italiana, la Farfisa, un piccolo pianoforte per riprodurre ciò che comunemente viene chiamata la serie degli armonici, e che comprende sei ottave. E ho osservato così almeno due fattori che convalidano la mia opinione circa il fatto che una grande parte della musica orientale, certi tipi di musica popolare e molte tradizioni di musica temperata, siano ispirati, e istintivamente basati sulla serie degli armonici, che possiamo considerare un apriori o una forma ideale.
A parte ciò che comporta l’avere un orecchio esercitato, e alle spalle studi di armonia e soprattutto di contrappunto, come descriverebbe l’influsso della musica sul verso?
Non si sovrappone agli studi classici delle varie metriche, ma mi ha influenzata talvolta per esempio nella scrittura di un lungo poemetto, La libellula, quando avevo ventotto anni… non mi ricordo bene quand’è che l’ho scritta…
E ci sono invece poesie che mette in una relazione diretta con musiche ascoltate o studiate?
Sì, mi è capitato con le prime poesie di Variazioni belliche; allora suonavo sempre al pianoforte i 48 preludi e fughe di Bach e i Preludi e i Notturni di Chopin e mi capitava di girarmi dal pianoforte al tavolo di lavoro… certo non trascrivevo…, ma sa, le mie sono poesie in verso libero o quasi… Quando lei legge sottolinea molto la metrica e, a volte enfaticamente, anche il senso…
Talvolta anche troppo, ma ho notato che il grande pubblico non capisce una lettura fredda com’è quella della nostra voce interna: ispirata intellettualmente sì, ma non emotivamente. Allora cerco di rivivere l’esperienza che ha provocato la poesia, e quel che ne viene fuori non è tanto enfasi, ma colorazione. Di solito, ho in mente l’immagine che ha dato origine ai versi. Però vorrei tornare a letture un po’ più fredde.
Nel primo capitolo di Diario ottuso ha detto di considerare un “mini-romanzo”, c’era un tentativo di portare a compimento un’opera di narrativa. Crede che la cosa sia finita lì?
Non lo penso affatto, spero di no. Ho in mente da tanto tempo un romanzo umoristico, e il mio grande modello è il Tristram Shandy di Sterne; ma sono anni che non riesco a scrivere. La prosa di Diario ottuso è un esperimento di prosa ed è l’unico mio scritto in italiano ad essere indirettamente autobiografico. È un esercizio della memoria, alla Proust, ma certo non dal punto di vista stilistico, questo no. È anche la storia di un breakdown, una storia vera che ho camuffato. Quando ho chiuso il primo capitolo l’ho considerato più un esercizio di stile che altro.
Cosa ne pensa, riprenderà a scrivere?
E come posso prevederlo: per sei anni non ho scritto nulla, poi d’un colpo, in modo improvviso è venuto fuori il poemetto Improptu. Cominciai tentando una scrittura in prosa, ma tornavo sempre alla mia personale metrica. In Improptu c’è un salto tematico: ho cominciato a parlare di politica in modo larvato e anche il modo è mutato. Con la scrittura di Documento avevo esaurito una certa carica energetica, e dunque ora scrivevo con maggior leggerezza e in cerca di una risposta a un problema politico. Ero iscritta al Pci dai ventotto anni, facevo lavoro di base; alternavo nettissime sentenze politiche a frasi a bella posta censuranti. «II borghese non sono io». Certo sono più malinconica senza la scrittura, che è legata alle molte mie letture, e alla necessità di non avere ossessivi problemi di sussistenza. La musica è stata il mio grande conforto, e il mio grande riposo, ma sono più felice adesso che non suono: non si possono avere due professioni così impegnative. Ero arrivata al punto di comprare anche un violino, ma lo riportai il giorno dopo. Alla fin fine, ho regalato tutta la mia musica.
(il manifesto – Alias, 8 febbraio 2026)
Il numero doppio della rivista AP (Autogestione e politica prima) n.4, ottobre-dicembre 2025/ n.1, gennaio-marzo 2026, meriterebbe una menzione solo per il titolo, Con GENTILEZZA stante i tempi bui; e per l’immagine di copertina, due mani che si stringono: due mani, una di donna e una di uomo. Non credo sia casuale. Perché AP da sempre, pur essendo profondamente femminista per i valori e le battaglie e le azioni che sviluppa, non ha mai assunto una posizione di rifiuto verso le figure maschili che ha sempre accolto, ne è stata ospite o addirittura alleata. Siamo, in questa rivista, impegnati a cercare aldilà, o nel profondo, a mostrare, svelare delle realtà che la stampa in generale nasconde e trascura: quella realtà che solo le donne riescono a svelare, che è appunto fatta di gentilezza e di forza. Questo doppio numero ne dà una testimonianza vivida: ci sono le lotte dei braccianti e la rabbia verso le cieche burocrazie che rendono faticosa e difficile ogni azione sensata; la consapevolezza del difficile scambio con le giovani, travolte da un sistema tecnologico ancora profondamente patriarcale e minacciate da guerre sempre più insensate e crudeli specie per le donne… E a fronte di questo la volontà di non perdere i legami col passato, con le madri, nella storia vivente, che è l’unica che ci può restituire il senso profondo dell’esistenza. Insomma, un numero che assume e rilancia, con il contributo delle Città Vicine che hanno pubblicato qui le riflessioni nate dal loro incontro “Testimoniare il male senza dimenticare il bene”, una parola forte, che ci libera da tanti piccoli pregiudizi e paure per la sorte del femminismo: che, come testimonia questa rivista, è più vivo che mai.
(www.libreriadelledonne.it, 5 febbraio 2026)
Risale a Patrizia Cavalli, dopo la morte della scrittrice, l’idea di questo “Album” che ora vede la luce a cura di Emanuele Dattilo (Einaudi): foto, note biografiche, lettere, brani dai romanzi, testi inediti
Sfogliare un album di foto di famiglia significa compiere un rito specifico, assai più codificato di quanto normalmente sospettiamo. «Dov’era qui?», «Chi era questo?», «Cos’era successo quella volta?», chiede il bambino all’adulto di fronte ai volti di quanti, pur essendogli familiari e vicini, gli appaiono d’un tratto lontani, quasi irriconoscibili.
Ma si deluderebbero senza dubbio le sue aspettative se ci si limitasse a rispondere a questi interrogativi, ripetendo magari quanto riportato già dalle didascalie. La vera domanda che infatti il bambino vorrebbe porre, e che pure resta spesso sospesa e non detta, è: «Come eravate/come eravamo allora?».
È la questione che Emanuele Dattilo pone felicemente al centro dell’Album Morante di cui è curatore (Einaudi “Saggi”, pp. IX-263, € 52,00), prendendo sul serio la più vitale delle curiosità infantili (ma qui “bambino” e “adulto” indicano due diverse condizioni epistemiche più che anagrafiche – due ruoli o due finzioni). L’“Album”, che raccoglie fotografie, documenti ed estratti spesso inediti di Elsa Morante, ha una storia travagliata, come si compete a un libro tanto importante. Concepito già all’indomani della morte della scrittrice (1985), è rimasto in fase embrionale per oltre trent’anni. Una gestazione mostruosa che si spiega con il compito altissimo affidatogli originariamente da Patrizia Cavalli: nientemeno che strappare, tramite il ricordo, l’amica Elsa alla morte! Un’impresa forse impossibile, che ora Dattilo ricalibra, piegandola nella direzione dell’arte divinatoria.
Attraverso il montaggio di immagini e testi, al di là di ogni imposizione cronologica, si tratta non tanto di ricostruire la vita di Morante (per quello esistono già le biografie), né tantomeno di restituirgliela, ma di evocare Elsa, lasciando che sia lei stessa a mostrarsi, a rivelarsi al lettore. E con lei il suo mondo, il suo modo di essere, il suo pensiero. Sì, perché una delle premesse fondamentali del libro è che Morante ha un pensiero – un pensiero che, naturalmente, non si è espresso nella forma sistematica del trattato, ma innerva i racconti, i romanzi, le conferenze, le poesie, le lettere, e finanche i paratesti, quegli umili apparati grafici e testuali che accompagnano un libro.
È infatti proprio in una notarella autobiografica apposta sulla quarta de “Il mondo salvato dai ragazzini” che Morante ci si presenta con ineguagliata lucidità. «E.M. – scrive – è tuttora vivente, e abita a Roma nell’unica compagnia di un gatto. Le sue amicizie (poche) le trova di preferenza tra i ragazzini, perché questi sono i soli che si interessano alle cose serie e importanti. Gli adulti, in massima parte, si occupano di roba trita e senza valore. In politica, E.M. è (fino dalla nascita) anarchica: CIOÈ ritiene che il potere degli uni sugli altri viventi […] sia la cosa più squallida, miserabile e vergognosa della terra».
Vi è molto di Elsa condensato in queste poche righe. La disposizione selvatica e quasi saturnina, ma anche l’amicizia, quale culto assoluto da prestare a un pantheon di divinità comuni (Rimbaud, Simone Weil, Platone, Mozart, Spinoza…). Il rifiuto di ogni forma di sopraffazione e la passione smodata per i gatti – le uniche creature alle quali Elsa accorda una sorta di primazia naturale («Potere ai gatti!», grida, una fredda notte di capodanno, facendo piovere macinato su una colonia felina). E, infine, la contrapposizione netta, insanabile, tra la Storia, il mondo degli adulti, degli Infelici Molti, da una parte, e l’Isola, la patria dei ragazzini, dei Felici Pochi, dall’altra.
Quale delle due è reale e quale irreale? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, per Morante, la realtà è tutta dalla parte dell’Isola; è la Storia, per usare le parole di un altro grande scrittore del Novecento, “l’incubo” dal quale dobbiamo cercare di risvegliarci.
Si tocca qui, come suggerisce persuasivamente Dattilo, uno dei nodi che insieme stringono e separano Morante dall’amato Pasolini. Anche per Elsa, ai margini della società, il Paradiso esiste; ma esso non è di per sé votato all’estinzione, per via di un’inesorabile dialettica storica. Sempre vi sono e vi saranno Poeti, capaci di cogliere la vita come una rosa da un prato. Lo dimostrano gli esempi speculari di Sandro Penna, «il più grande poeta del mondo», e di Leonor Fini, pittrice, che vivono senza conservarsi, in maniera tenera e feroce – il che vuol dire, in una parola, innocente, come il fuoco, che brucerebbe il mondo, ma non brucia in primis che sé stesso. Appartiene anche Elsa a questa felice, eletta schiera?
Lo ricordava già uno dei più grandi critici letterari del secolo scorso, Cesare Garboli: Morante, che per tutta la vita non ha fatto che adorare indefessamente la grazia, la leggerezza, l’ala di rondine che passa senza lasciare traccia, si è sempre imputata la qualità che più le era odiosa – la pesanteur. «Io futile minotauro negato al volo», dice di sé nella poesia conclusiva di “Alibi”. È questa la tragedia di Elsa: scorgere l’Isola, persino frequentarla, senza però essere in grado di restarvi davvero; vedere una donna in spiaggia con in braccio un bambino ed essere solamente colei che la osserva a distanza. «Mi pare ormai di aver capito il segreto della felicità… – scrive in una lettera a Rodolfo Wilcock – L’ho capito, MA non sono capace di trasformarmi in quello!». Ed è probabilmente proprio questo capire il grande ostacolo. Per quale ragione? Perché bello, per Elsa, è solamente chi non sa di esserlo; felice è solamente chi non sa cosa sia la felicità. Come scrive a proposito dei Felici Pochi: «la vostra grazia, ultima, è che la vostra bellezza NON VI RIGUARDA».
Ma forse, come suggerito da Giorgio Agamben – un altro degli amici le cui testimonianze sono raccolte nell’“Album” – proprio l’adesione tenace al proprio destino, alla propria finzione tragica, consente a Elsa di aprire «un varco» oltre ad essa, «verso qualcosa che non è più tragico». Una commedia o anche solo uno scherzo (“Tutto uno scherzo” è il titolo originario de “La Storia”). Sembrano confermarlo al lettore alcuni ritratti, in cui la consueta, intransigente serietà di Elsa si scioglie finalmente in un sorriso sottile e pieno di mistero. È il «sorriso degli etruschi», come ebbe a scrivere Raffaele La Capria, di chi «ha stabilito che la Felicità deve essere in qualche parte, in un’Itaca remota e vicina, e bisogna soltanto essere abbastanza intrepidi per andare a scovarla». Infatti, solamente «chi questa idea ha in fondo alla testa, e niente elude, conosce il Naufragio».
C’è un momento, un solo momento, in cui questo spiraglio oltre la propria sorte, altrimenti votato a rimanere invisibile a Elsa, sembra divenire anche per lei trasparente, facendo filtrare un po’ di luce. È un testo inedito, in cui Morante immagina un dolce scambio con Stendhal: «Lo sai benissimo che non sono il tuo Angelo Custode. Il tuo Angelo Custode è Arthur Rimbaud. Costui ti porterà alla morte; ma al momento di morire, ti ricorderai di quest’altro vecchietto, che t’ha indotto a vivere, e che sono io. Io sono il tuo Santo Protettore. Sono un sorrisetto».
(il manifesto – Alias, 1° febbraio 2026)
La pratica poetica ha salvato le donne deportate dalla perdita della loro umanità: lo raccontano le poesie raccolte dal lager femminile di Ravensbrück nel libro “Boschi cantate per me” curato da Anna Paola Moretti. Il 29 gennaio (ore 17.30) se ne parlerà a Bologna all’Istituto Storico Parri con le e gli studenti dei licei Galvani e Archimede, introdotti da Elda Guerra.
Raccontare la storia dell’incontro con Anna Paola Moretti, studiosa marchigiana della Resistenza e della deportazione femminile, è importante per capire la genesi di questa antologia, che è assieme un libro di ricerca e resistenza, di poesia e di storia, su come le donne deportate siano riuscite a non farsi strappare e a conservare la propria umanità.
Anna Paola Moretti, pesarese, da oltre vent’anni si è dedicata a ricostruire biografie di donne deportate, attraverso lo studio scrupoloso delle fonti, documenti e diari. In questa operazione pluriventennale, è venuta a conoscenza dell’esistenza di un corpus di circa 1200 poesie prodotte da donne durante la prigionia nei lager, grazie a Giovanna Massariello, figlia di Maria Arata, deportata e autrice de Il ponte dei corvi. Diario di una deportata a Ravensbrück.
Massariello le aveva parlato della tesi di dottorato di Constanze Jaiser sulla poesia delle donne internate a Ravensbrück, ma numerose altre poesie si trovano disperse in blog, disseminate in rete, in siti di musei, quasi in un lavoro collettivo transnazionale di trasmissione e cura che è giunto fino a noi e a cui abbiamo aggiunto un ulteriore tassello, raccogliendo il testimone di Ventotene per una Europa di pace.
Studiosa delle donne, oltre alla necessità di rendere fruibili in lingua italiana le poesie composte da donne deportate, Anna Paola voleva, seguendo la metodologia delle storiche femministe, in particolare di Natalie Zemon Davis, interessarsi alle singole soggettività, sottraendole al ruolo stereotipato di vittime e restituendo loro identità e biografie. Era necessario però un accurato lavoro di squadra, possibile solo attraverso il lavoro congiunto di un gruppo di traduttrici e traduttori che avrebbero potuto riportare in italiano le poesie che si presentavano nelle lingue più diverse, spesso ritradotte dall’inglese o dal tedesco, e afferenti alla babele linguistica tipica del lager. Ambra Laurenzi, Presidente del Comitato internazionale di Ravensbrück e consigliera dell’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED), ha sottolineato l’internazionalismo di queste poesie, scritte da donne francesi, tedesche, polacche, olandesi, spagnole, russe, ovvero di quindici nazionalità diverse presenti nei circa cento testi del libro.
La tesi di fondo è che la poesia è stata una pratica di resistenza delle donne, un atto di creatività impensato, che ha fatto fallire il tentativo di cancellare l’umanità delle persone deportate. Resistenza e creatività che erano anche nella pratica fra le deportate di ripetere tra loro brani a memoria, formule matematiche, canzoni da non dimenticare, pratica che le ha unite, oltre che salvate dall’annichilimento e dalla disumanizzazione, e che ha creato legami e capacità di resilienza, come hanno testimoniato molte superstiti.
Come scrive Anna Paola Moretti, il linguaggio maschile usato nella storiografia per raccontare l’esperienza del lager ha occultato l’esperienza femminile, che questo libro in parte restituisce, anche attraverso il lavoro di cura, sia nostro, sia delle donne che si occupavano l’una dell’altra nei lager.
Il libro si prende dunque cura delle vite, le restituisce, con accurate note biobibliografiche per ciascuna autrice e con la restituzione dei testi originali e in traduzione.
Alla marginalità del campo di Ravensbrück come campo femminile, Moretti ha risposto restituendo una memoria condivisa, che soprattutto i testi accolti ricreano dal vivo, memoria pulsante e parola frutto di una rete di relazioni, così come spesso è relazionale il lavoro delle donne.
Per noi che abbiamo raccolto questa sfida traducendo, Daniela Maurizi dal tedesco, Maria Luisa Vezzali dal francese e io stessa dall’inglese i testi spesso ritradotti dalla lingua originaria, con a volte perdite o lievi spostamenti del significato originario, il lavoro di lettura e confronto è stato fondamentale, non solo per ribadire la necessità di una memoria collettiva femminile, ma anche per restituire quella visione collettiva e relazionale che le poesie avevano.
Anche Primo Levi, in Così fu Auschwitz, dirà: «Ho desiderato che i miei scritti, anche se li ho firmati io, fossero letti come opere collettive, come una voce che rappresentasse altre voci».
Recitate per le altre, nascoste e protette dalle amiche, in modi fortunosi e originali, come quello di Grażyna Chrostowka, nascoste in barattoli o sotto le baracche, le poesie volevano dare forza alle altre, per questo a volte appaiono ironiche, sferzanti, poesie che spesso ricreavano l’aria di casa, l’odore di certi cibi, di certe pietanze, di certi paesaggi oltre che gli affetti familiari lasciati.
I temi presenti nell’antologia rimandano alla quotidianità della vita nel campo, dalla sezione dedicata all’arrivo a quella dell’appello, agli oggetti, al lavoro, alla desolazione e alla morte, ma sono ben presenti anche gli sguardi su altre donne, gli affetti lontani, le compagne, la resistenza e la speranza di un ritorno.
A cura di Anna Paola Moretti, Boschi cantate per me, traduttrici Loredana Magazzeni, Daniela Maurizi e M. Luisa Vezzali, Enciclopedia delle Donne editrice, 2024
(Letterate Magazine, 28 gennaio 2026)
Giorno della memoria. Le poesie di Ravensbrück a cura di Anna Paola Moretti e la pièce teatrale di Charlotte Delbo su Auschwitz
Dal 1939 al 1945, a Ravensbrück, il lager ha contenuto circa 130mila donne, di cui 90mila sono morte, mentre statistiche incomplete indicano 882 bambini deportati. Per dare conto della evoluzione materiale del campo, basti pensare che nel 1944 risultavano 32 baracche dormitorio, 4 infermerie, bunker di punizione, crematorio (le ceneri venivano gettate nel lago di Schwedt trasformato in fossa comune), laboratori industriali. Il Frauenkonzentrationslager di Ravensbrück è stato l’unico del sistema concentrazionario nazista destinano appositamente alla deportazione femminile.
Anche per questo, leggere oggi Boschi cantate per me (Edizioni Enciclopedia delle donne, pp. 416, euro 23) significa accedere a un materiale prezioso: si tratta infatti dell’antologia poetica che proviene proprio da Ravensbrück. Dobbiamo ad Anna Paola Moretti la curatela di questo volume, che l’ha impegnata per vent’anni nel reperimento delle poesie (oltre novanta con testo a fronte), riportate per la prima volta in traduzione italiana (grazie a Loredana Magazzeni, Daniela Maurizi, Maria Luisa Vezzali e di Paul Benjaminse, Mirko Coleschi, Krystyna Jaworska, Elisabetta Ruffini, Jessy Simonini, Luciana Tavernini). Cinquanta sono le autrici presenti, quindici le diverse nazionalità: le più numerose sono polacche, quasi 40mila, poi francesi, austriache, tedesche, slovene, olandesi, danesi, russe, spagnole e italiane.
Quando possibile viene indicata la data di composizione della singola poesia, quando la lingua originale non è invece ricostruibile si traduce da una versione intermedia (tedesca o inglese). Il valore eterogeneo dei versi non osta con la qualità storica e umana ed è un bene che possiamo leggerle, soprattutto se consideriamo che molti componimenti sono andati persi perché distrutti dalle guardiane o dalle stesse detenute per evitare punizioni.
Ebree, rom e in prevalenza politiche, i versi delle deportate mostrano il luogo di annientamento da cui scrivono per poterne intravvedere la comunità che vi era rinchiusa. Fame, freddo, botte, corpi bruciati, lavoro fino allo sfinimento, morte quotidiana e obbligo di spogliare i corpi delle altre per portarli a morire. Se i lager erano progettati per distruggere moralmente e fisicamente le prigioniere, riducendole a numeri, a «pezzi» (Stück), è esattamente dentro Ravensbrück e nei sottocampi che si sviluppa una produzione artistica (e poetica) come forma di sopravvivenza e resistenza alla disumanizzazione.
Provvisto di apparati storici e critici, oltre che le schede biografiche di ogni poeta, il libro ci accosta alla pluralità linguistica che ha composto la trama del Novecento, dal crollo degli imperi agli spostamenti di confini, fino alle deportazioni e alle migrazioni forzate. È una voce, la loro, che interpella, domanda dialogo, invita a non sprecare la vita e a interrogare il nostro tempo. Anche le contraddizioni sono radicali: libertà e costrizione, dipendenza e relazione, fragilità e forza. In particolare occorre sottolineare quest’ultima, perché di forza femminile si tratta, di alleanza contro la frammentazione, le une con le altre insieme, così che da numeri si potessero pensare come un “noi”.
Una trasmissione della memoria che diventa un modo per rendere comunicabile ciò che altrimenti resterebbe muto o impronunciabile.
Tra le deportate rimaste scrittrici anche dopo il ritorno dal lager si ricordano i nomi di Micheline Maurel, Violette Maurice, Zofia Górska, Halina Golczowa e Charlotte Delbo. Le edizioni Ets, grazie alle sapienti cure di Cristina Galasso e nella traduzione di Federica Quirici, propongono la prima traduzione italiana del capolavoro teatrale di Charlotte Delbo Chi porterà queste parole? (pp. 80, euro 10) unico testo teatrale scritto da una sopravvissuta che racconta l’esperienza vissuta nel campo di concentramento di Auschwitz, cominciata per lei il 2 marzo del 1942, dopo ci sarà Ravensbrück fino alla liberazione il 23 aprile 1945.
Scrittrice e partigiana francese, la tragedia in tre atti di Charlotte Delbo vede la luce nel 1966, e mette in scena ventitré partigiane che sono altrettante compagne di prigionia a restituire, guardandolo insieme a chi legge le loro parole e senza mai nominarlo, il lager. Soprattutto consegnano il senso della vicinanza tra donne, Cristina Galasso parla di consapevolezza e sentimento solidale che consente loro di «stringersi una all’altra e a confidare nella resistenza di ciascuna “affinché una ritorni per dire”».
L’aspetto testimoniale di Charlotte Delbo, che in apertura fa dire a una delle sue personagge di essere «reduce dalla verità», è qui puntellato dalla quotidianità: dagli appelli alle percosse, dal freddo agli stenti per fame e sete, dalle selezioni alle marce e le camere a gas. La scenografia non c’è, non serve perché i luoghi sono rappresentati dalle luci e dal movimento delle protagoniste: all’interno della baracca, nel tragitto e infine nel piazzale dell’appello. Il campo contiene quindicimila donne di varia provenienza ma quelle che Delbo fa emergere sono ventitré, arrivate tra le duecento francesi totali. Françoise, Mounette, Yvonne, Gina e Madeleine, poi Claire, Reine e altre, spalancano le loro vite, lottano «a mani nude, a cuore nudo. A pelle nuda».
Raccontano le loro paure, si confrontano: «Bisogna che ce ne sia almeno una che sopravviva, tu o un’altra, poco importa. Ognuna di noi si aspetta di morire qui. È pronta. Sa che la propria vita non ha più importanza. Eppure si affida alle altre. Bisogna che ce ne sia una che sopravviva per parlare. Tu vorresti che tutti i milioni di esseri umani che sono stati distrutti qui, tutti questi cadaveri, restino muti per sempre, che tutte queste vite siano state sacrificate per niente?».
La potenza del testo scritto da Delbo risiede nelle parole, quelle capaci di dire «le cose semplici». Per fare ritorno a una esistenza che non si immaginava più disponibile né praticabile. Ci si riconosce in quel Tu che le ha accompagnate in questo canto di sopravvivenza e attesa, un Tu che sa tenersi vivo nella presenza di un altro volto o un’altra mano, compresa quella che arriva quando il tempo del vivere si è ormai chiuso.
(il manifesto, 27 gennaio 2026)
Critica letteraria e saggista, Liliana Rampello ha insegnato estetica all’Università di Bologna ed è fondatrice dell’Italian Virginia Woolf Society. Ha scritto di Marcel Proust, Simone De Beavoir e, chiaramente, Virginia Woolf. Ad accomunarla alla Woolf è anche la capacità di leggere e amare Jane Austen. Alla scrittrice inglese ha dedicato i testi “Sei romanzi perfetti”, edito Il Saggiatore, e “Un anno con Jane Austen”, uscito nel 2025 per Neri Pozza. Non è un caso che sia stata scelta come curatrice dei Meridiani Mondadori, la più importante raccolta di opere per autore, il cui ultimo dei tre volumi dedicati a Jane Austen è in libreria da maggio 2025.
In questa intervista, interamente dedicata alla figura di Jane Austen e alla sua scrittura, Liliana Rampello ripercorre i suoi studi sull’autrice partendo proprio dall’esperienza di lavoro sui Meridiani Mondadori, portandoci poi dentro il mondo dell’autrice, maestra di lettura e di scrittura da cui abbiamo ancora molto da imparare.
Partirei proprio dai Meridiani. Oggi di Jane Austen si parla moltissimo. Complici le numerosissime riedizioni, i film e le serie tv dedicate ai suoi libri, il successo che le sue storie e lo stile del suo tempo stanno avendo sui social media e tra le nuove generazioni, è un’autrice che sembra essere sempre in voga ma di cui c’è ancora moltissimo da scoprire. Il Meridiano Mondadori che, lo ricordiamo, non è un’edizione critica delle opere di un autore ma una raccolta analitica delle stesse, inserisce l’autrice nell’Olimpo dei “grandi”. Ti chiedo quindi quanto sia stato complicato per te lavorare su un autore, in questo caso su Jane Austen, con l’intento di curarne un’opera importante come il Meridiano? Nonostante la tua conoscenza della Austen fosse già consolidata, questo lavoro ti ha consentito di scoprire ancora altro su questa autrice?
Certamente. Io ho scritto la prima monografia su Jane Austen lavorando circa tre anni. Quando poi la proposta è arrivata da Renata Colorni, che allora dirigeva i Meridiani prima di Alessandro Piperno, è stato tutto un altro mondo. Innanzitutto perché i Meridiani hanno un loro formato e una serie di regole già determinate: introduzione, cronologia, notizie sui testi, traduzione, bibliografia, ecc. Avevo una grande, meravigliosa scatola da riempire.
Il primo momento è stato il progetto: come distribuire i materiali? Perché da un lato sono pochi e dall’altro sono tanti. I romanzi sono sei, ma c’erano i famosi incompiuti, le 161 lettere, le avvertenze del fratello, la memoria del nipote… Bisognava capire come distribuire tutto in modo da non far perdere efficacia né al primo né al secondo volume. Questi testi vanno su un mercato, non servono solo a noi studiosi. L’impresa mi ha affascinato innanzitutto perché, come dicevi tu, così Jane Austen entra nell’Olimpo dei grandissimi e non la confondiamo più con mille altri rivoli eventuali.
Poi una cosa importante era trovare la connessione giusta con la traduttrice. Io penso che il lavoro di traduzione sia un lavoro critico. Nel caso di Susanna Basso, avevo di fronte una competenza straordinaria e una grande gentilezza mentale oltre che intelligenza. Le ho mandato per prima la mia introduzione per capire se c’era lo stesso sguardo sull’autrice, per non essere divaricate. Devo sottolineare anche che la redazione dei Meridiani è magnifica: Marco Corsi per la redazione interna e Francesca Pinchera per la revisione. Sono persone estremamente competenti, gentili e attente a qualsiasi necessità o aiuto.
Ho cominciato con l’introduzione e la rilettura di tutti i testi per rinfrescare la memoria, considerando che, come accade per tutti i classici, ad ogni rilettura si trova qualcosa di nuovo. La mia idea iniziale era presentare tutti i sei romanzi nel I volume; quindi, c’era da tener presenti molte cose.
Poi c’è stata cronologia e il discorso è stato diverso. Le biografie di Jane Austen sono molte, soprattutto in lingua inglese, e più o meno tutte simili: la vita di Jane Austen apparentemente non presenta eventi significativi o traumi straordinari. Però bisognava correggere questa visione di una vita “priva di eventi”. Non è vero: leggendo le biografie e accostandole, si scopre che ha viaggiato, seppur in un’Inghilterra ristretta geograficamente, ma aveva moltissimi parenti (cinque fratelli maschi, la sorella Cassandra, zii, amici). Era una zia divertente e aveva un rapporto speciale con le nipoti. La sua era una vita priva di enormi avventure ma ricca di incontri, conversazioni e letture. Nonostante all’epoca le ragazze non andassero all’università, lei aveva una formazione colta, era una grande lettrice ed era sostenuta, sia nella lettura che nella scrittura, dalla famiglia. Leggeva tutti i suoi primi scritti nel salotto di casa da bambina e poi il primo a credere in lei è il padre. Si può pensare a questo proposito ai padri vittoriani, attenti a non modificare le regole dell’educazione delle fanciulle, ma il suo è anche un padre che dà fiducia, che le regalò il primo raccoglitore per i suoi scritti e l’attrezzatura per scrivere. Questo è l’ambiente e studiandolo insieme ai romanzi sono nate le prime ipotesi di interpretazione critica, cosa era riuscita a fare rispetto al contesto, alla letteratura del suo tempo, alle forme di costume della sua epoca. E qui ci sono invenzioni e scoperte continue. Tra la mia prima lettura e i sette-otto anni di lavoro sui Meridiani, la mia visione di lei è cambiata e si è approfondita moltissimo.
Ho sempre pensato che tra le cose che rendono unica, e amabile, la scrittura di Jane Austen ci sia la sua capacità di costruire i dialoghi. Mi ha colpita un passaggio inserito nella prefazione del II volume dei Meridiani – tema che si ritrova approfondito anche in Sei romanzi perfetti – in cui parli del rapporto tra i dialoghi austeniani e quelli teatrali, in particolare del suo amore per Shakespeare a cui indubbiamente si ispira. Che rapporto c’è, quindi, tra Jane Austen e il teatro e quanto secondo te questo amore per Shakespeare ha contribuito alla creazione di dialoghi perfetti, ritmati e ancor oggi coinvolgenti ad ogni pagina?
Partiamo dalle sue avventure di ragazzina. Tutto nasce in quel fienile in cui, per divertimento, lei, la sorella, i fratelli e gli allievi del padre mettevano in scena piccoli sketch scritti da loro o commedie dell’epoca e Shakespeare. Quindi non solo lo ha letto, ma lo ha “attraversato” fisicamente con la messa in scena. È lì che lei comincia ad amare il teatro di Shakespeare ma anche il teatro in genere. Sappiamo che da adulta, quando andava a Londra dal fratello Henry e per seguire le vicende legate ai libri, andava a teatro spessissimo. Era un’attentissima spettatrice di forme anche diverse di teatro, oltre che essere un’attenta osservatrice delle arti in genere. Era una persona sensibile a tutti i linguaggi artistici, in particolare quello teatrale.
Di Shakespeare, secondo me, la colpiscono i personaggi femminili: autonomi e indipendenti. Le donne di Shakespeare non sono bambole manovrabili dall’uomo. Lei intuisce le potenzialità del personaggio femminile. Capisce che si possono disegnare personaggi femminili capaci di autonomia, riflessione, invenzione e scontro verbale con l’uomo e di dire la propria sul mondo. La letteratura a lei contemporanea non andava in quella direzione, c’era più la passività e la sofferenza femminile. Lei sceglie la strada della protagonista indipendente, autodeterminata, libera e soprattutto con una lingua. L’avere una lingua, che significa avere un pensiero, diventa con il dialogo il modo in cui lei ci fa vedere come può funzionare il rapporto fra i sessi, nel conflitto e nell’amore, ma in un dialogo in cui il confronto è vivo e in cui entrambi prendono la parola. Questa è una novità straordinaria per la sua epoca. Poi ruba al teatro l’idea che la “parola è azione”. Lei trasferisce il dramma nel dialogo e qui fa comparire ragazze – le sue protagoniste sono tutte giovanissime tranne Anne – capaci di nominare il mondo in cui vivono. Questa è una scoperta austeniana straordinaria che arriva fino a noi. Fino a noi non arrivano carrozze e balli, ma qualcosa di più intenso, vero, contemporaneo e moderno, per la capacità che lei, come i grandi artisti, ha di “vedere prima”. Lei vede prima molte cose e ciò fa sì che nei suoi romanzi i dialoghi siano spumeggianti, sempre intelligenti e ironici. E questo è un altro tratto importante. Qui ha ragione Virginia Woolf quando dice di lei: «Una donna che all’inizio dell’Ottocento scrive senza odio, senza amarezza, senza fare prediche e senza lamentarsi». Questa libertà profonda lei la sente in sé stessa, se la concede senza seguire consigli. È un salto straordinario che lei fa e penso che lo faccia assolutamente attraverso la comprensione profonda del senso del teatro, di che cosa il teatro può comunicare semplicemente attraverso la parola.
Jane Austen, come racconti qui e nei tuoi testi, scrive dopo aver letto tanto, aver ascoltato e guardato il teatro. Ha cominciato da bambina a mettersi alla prova leggendo ai familiari e il suo percorso probabilmente dimostra quanto sia importante l’esercizio dietro la scrittura. Oggi può essere un esempio concreto, e purtroppo per nulla scontato, di come solo studiando a fondo l’arte si può poi creare arte.
Lei insegna innanzitutto a leggere. Essendo una grande lettrice, scopriamo quanto sia formativa la lettura per uno scrittore. Poi insegna a scrivere: aiuta a capire che la lingua va lavorata a lungo per arrivare a quella leggerezza. Da questo punto di vista assumono importanza i due incompiuti che abbiamo pubblicato [con il terzo volume dei Meridiani Mondadori “Romanzi incompiuti” ndr]: si vede che nella prima stesura sistema i personaggi, ma non tutti hanno ancora una lingua; è attraverso lo stile che lei riesce a dare una restituzione complessa sia del singolo personaggio che dell’antropologia sociale che lo circonda che è complessa e ricca. Non utilizza mai il “tipo”: anche il seduttore – da Wickham a Willoughby – non è un tipo fisso, sono forme di seduzione diverse con ambizioni diverse. Non c’è mai il carattere nel senso della tipizzazione dello stesso. Anche questo è molto moderno. Invece che darci una generalizzazione, ogni personaggio è visto in sé e per sé ed è questo che le consente di non essere ideologica. Abbiamo personaggi come Darcy o il colonnello Brandon capaci di sanare una ferita inferta da altri uomini alle ragazze con un’idea molto moderna della rottura dell’omertà, ma abbiamo anche una moglie cattiva come all’inizio di Ragione e sentimento. Ci sono tematiche di grandissima profondità, il tutto raccontato divertendoci. Il che la colloca in una sfera superiore.
Altra cosa importante, che molto insegna alla letteratura contemporanea, è l’impersonalità. Non c’è bisogno di mettere l’Io in scena per scrivere un buon romanzo. Jane Austen insegna che raccontare un mondo non significa non dire ciò che si pensa di quel mondo ma trovare la forma per dirlo in modo diversificato a seconda dell’esperienza di ogni personaggio.
Qualcuno dice che nelle storie di Jane Austen il contesto storico pare non essere importante, che appare poco in favore della sola trama e degli intrecci tra personaggi. Io personalmente mi sento di dissentire e ritengo che Jane Austen abbia, anzi, una capacità unica di raccontare il mondo in cui i suoi personaggi si muovono, dando uno spazio e un tempo precisi a ogni storia.
Assolutamente, la grandezza sta proprio nel saper raccontare e interpretare il suo mondo. Quella collocazione storica, sociale ed economica ci permette di capire i comportamenti dei personaggi. Se li sottraiamo a quella società, diventano burattini, non hanno quella concretezza anche visiva.
Quando Elizabeth Bennet attraversa la campagna e si infanga lei lo racconta e noi lo vediamo al di là dell’averlo visto in un film. Questa capacità visiva è legata a un contesto che non è sfondo. La campagna non è uno sfondo. Quando le sue ragazze camminano per pensare – perché le case avevano poco spazio per la solitudine – la passeggiata è un elemento che indica l’autoriflessione. Anche questa è un’intuizione potente.
E poi c’è il rapporto tra necessità e libertà. Se togli la necessità sociale dell’epoca, non c’è più quella libertà cercata e trovata che passa attraverso l’errore e la vergogna.
Un altro aspetto in cui letterariamente Jane Austen è bravissima è la capacità di descrivere i rapporti familiari. In ogni romanzo, sebbene i rapporti con madri e padri non siano al centro della trama, influenzano moltissimo le vicende. Oggi ce ne sono moltissimi di romanzi che hanno al centro i rapporti tra genitori e figli, ma probabilmente nessuno sa parlarne come ha fatto Jane Austen.
Sì e lo fa sempre con un’attenzione precisa. Prendiamo l’esempio di Mr. e Mrs. Bennet [in Orgoglio e Pregiudizio ndr]. Lui è più simpatico, ironico, è il preferito di Elizabeth. Mrs. Bennet è insopportabile, sbaglia tutto, è petulante e non sa stare al mondo in modo adeguato. Però, fin dall’inizio, sappiamo che Mrs. Bennet deve occuparsi di cinque figlie che, essendo senza dote, rimarrebbero sul lastrico alla morte del padre. Mr. Bennet la irride e nelle prime pagine di Orgoglio e Pregiudizio ci divertiamo molto, ma in realtà l’unica che si preoccupa del futuro delle ragazze è la madre. Molto spesso poi i padri, in Austen, vengono messi a posto. Per quanto riguarda Mr. Bennet, per esempio, verso la fine, Elizabeth dice al padre due cose: che non è stato in grado di educare Lydia [altra figlia dei Bennet, ndr] sebbene lei lo avesse avvisato del pericolo che correva nel lasciarla agire e che un genitore non ha il diritto di prendere in giro l’altro genitore davanti ai figli. Sebbene la madre potrebbe meritarlo, Elizabeth riflette su come un bravo genitore non dovrebbe mai farlo davanti ai figli. In Mansfield Park, poi, Lord Bertram deve fare autocritica perché ha affidato l’educazione delle figlie a Mrs. Norris senza capire che i valori che lei stava trasmettendo erano vacui. E c’è poi Fanny che è in grado di dirgli «non mi sposo se non amo». Altro che romanzi di formazione, questi sono romanzi di costruzione di amore vero e sensato e anche di un amore reciproco. Anche questa è un’assoluta novità in un’epoca di matrimoni combinati. Se penso a Charlotte Lucas [personaggio di Orgoglio e Pregiudizio, ndr], che dice chiaramente di non credere al matrimonio, penso a ciò che io definisco l’inesorabile materialismo di Jane Austen.
Poi c’è il tema delle “sostitute” delle madri: in Persuasione c’è una vicemadre esplicita, ma anche in Emma è un tema presente. Jane Austen ha ben presente il rapporto tra le ragazze tra loro e le figure femminili adulte che consentono loro di andare nel mondo in maniera più sicura.
I temi dei romanzi di Jane Austen l’hanno fatta arrivare fino a noi. Tuttavia oggi, probabilmente, questa scrittrice e la sua fortuna sono vittima di un equivoco. La Austen viene presentata infatti, ancora troppo spesso, come una scrittrice di romanzi romantici e di lei, complici molte copertine piene di ghirigori e fiorellini e alcune trasposizioni, emerge un’esaltazione del romanticismo che la allontana dai contemporanei concetti di emancipazione femminile. Si tende a confondere il romanticismo austeniano con la centralità del matrimonio come unica ambizione femminile. Oggi si parla tantissimo di emancipazione, a volte anche in un’accezione che sembra porre le donne in conflitto con l’altro sesso. Jane Austen, invece, al concetto di emancipazione ha sempre preferito quello di felicità femminile. Ha messo al centro, per quelle che tu giustamente più volte hai definito protagoniste e non eroine, la capacità delle donne di fare i conti con sé stesse, di capire ciò che vogliono andando anche contro i dettami del patriarcato, quindi di innamorarsi per davvero in un confronto reale e diretto con gli uomini. Sono forse le donne di Jane Austen le vere femministe cui dovremmo ispirarci?
Lei lavora sul tema della libertà, tema che la porta fino a noi con una velocità che supera i secoli. Se noi pensiamo a Jane Eyre e alle sorelle Brontë siamo già in un’epoca in cui una ragazza lavora e lì c’è già un romanzo di formazione emancipatore, sebbene sia un’emancipazione che ha bisogno di una serie di soluzioni romanzesche che la Austen non avrebbe mai ammesso. Non c’è in lei l’amore travolgente e incapace di limiti di Cime tempestose. Jane Austen è prima del romanticismo inteso anche a livello scolastico, non apprezza il sentimentalismo. In tutti i suoi scritti giovanili c’è l’irrisione dello svenimento, dell’eroina che mostra la sua debolezza. Questo la rende moderna. Relativamente a come arriva a noi sono anticipazioni straordinarie di ciò di cui discutiamo oggi. Ultimamente faccio spesso l’esempio della proposta di matrimonio di Mr. Collins a Miss Bennet [Orgoglio e Pregiudizio ndr]. Per lui una donna vale l’altra, basta che dica sì. Inoltre quando lui fa la proposta, lei rifiuta con una precisa presa di posizione di fronte alla quale lui dice che sa benissimo che le donne dicono molti no prima di dire un sì e che quindi ogni “no” nasconde un “sì”. Se noi trasportiamo questa cosa dal tema matrimonio al tema consenso oggi capiamo come la Austen avesse capito come nella testa di un uomo un no potesse essere un sì. Lei aveva intuito che gli uomini fossero così sicuri delle loro capacità di seduzione da potere pensare una cosa così. Tramite Miss Bennet lei invece sottolinea il tema della felicità come centrale, non della realizzazione di sé. Questo desiderio messo in capo a una ragazza è una cosa molto potente e che arriva ad oggi.
C’è poi il fatto che la si traduca spesso come una scrittrice di sentimenti e di amore e questo è dovuto anche a film e serie che spingono più sul lato romantico, nei film ci sono moltissimi baci che non esistono nei libri. Così come nei libri non c’è Dio, nonostante lei fosse un’evangelica, ma Dio non esiste nei suoi romanzi. Non esiste neanche l’idea di una maternità oblativa e non esistono i bambini come centro del mondo, come accade oggi, anzi nei suoi romanzi sono o solo oggetto di conversazione o ragazzini che scocciano. Non c’è idealizzazione del ruolo della maternità e dell’infanzia, però c’è questa sua capacità di guardare le cose per quel che sono e di raccontarle. Certamente quando al posto della sensualità sotterranea, dell’erotismo, del primo avvicinamento tra i ragazzi, del ballo come metafora di questo avvicinamento vediamo baci e abbracci e stritolamenti siamo fuori dal vero universo di Jane Austen. Secondo me se la si legge quando si è molto giovani magari si sta attenti solo alla trama e alle coppie, però quando la si rilegge o la si legge da adulti tutto questo non toglie niente alla lucidità del suo sguardo. Indubbiamente bisogna leggerla con attenzione, non pensare che sia una lettura di evasione perché in ogni frase c’è ironia, precisione e puntualità. Non si possono sottovalutare le posizioni che lei prende rispetto ai mutamenti – facile pensare alla sua contrarietà al modificare il panorama in favore del pittoresco in Mansfield Park – o la capacità di parlare di soldi, tema quanto mai attuale.
Ripercorrendo i suoi romanzi e la loro fortuna, vorrei concludere concentrandomi su un romanzo in particolare che è Persuasione. Io ci sono arrivata da adulta grazie a Virginia Woolf ed è il suo romanzo che preferisco. Tu hai scritto a tal proposito che contiene «una delle riflessioni sulla relazione fra i sessi più alte, belle, equilibrate, è segno di una mente profondamente libera, fino a quel momento mai udite, quasi un piccolo trattato che apre la tempesta romantica, lì trasportando, per bocca di una donna, il meglio della tradizione settecentesca, ma soprattutto la sua idea di un nuovo possibile ordine nel rapporto fra i sessi e il suo preciso giudizio sulla divisione dei ruoli nel patriarcato. Consapevolezza della parzialità di ciascun sesso, della loro diversa collocazione socio-simbolica, della possibilità di uno scambio autentico se basato su una sincera autoconsapevolezza, e dunque sul rispetto reciproco». È un romanzo diverso, più maturo, con una protagonista adulta. Perché secondo te è un romanzo che arriva ancora poco?
Forse perché quello che si sa più “in superficie” di Jane Austen è che sia allegra, che i suoi personaggi sono piacevoli anche quando, come Emma, sbagliano tutto. Circa Persuasione, non so se la parola “maturo” sia la più appropriata. È sicuramente il romanzo di una donna che non è più in età da marito (Anne ha quasi trent’anni) e questo sposta i riflettori sulla coscienza di questo personaggio, che non è più la ragazza vivace e avventurosa cui eravamo abituati. È una ragazza che ha rinunciato all’amore e che ha deciso che quella scelta non è più valida. Ha già rifiutato due proposte di matrimonio perché era ferma al suo primo grande amore. Questo farci vedere una protagonista sempre lucida e piena di autocoscienza forse conquista meno rispetto alla percezione più “superficiale” che si ha degli altri romanzi. Catherine Morland [protagonista di L’abbazia di Northanger ndr] è una ragazza simpaticissima che non sa far nulla ma è più divertente di Anne.
Ma in assoluto, il romanzo che arriva meno è Mansfield Park, perché è complicato e perché non è facile affezionarsi a Fanny, così inerme e silenziosa. Man mano Fanny diventa un grande personaggio.
Per di più in Persuasione la possibilità di fraintendere il titolo, capire cosa significa “persuasione”, potrebbe aver allontanato dalla lettura. Si pensa che Anne sia stata stupida a seguire quel consiglio. Bisogna entrare bene nel meccanismo di questo romanzo, capire la fedeltà che Anne ha nei confronti delle donne più adulte, il ruolo che lei assume nelle famiglie essendo da un lato una calimera dall’altro assumendo il ruolo di zia. Anne è un personaggio bellissimo, cui Jane Austen fa dire «non credo alla storia perché raccontata dagli uomini» e che ha prese di posizione bellissime.
Se poi leggi Sanditon, vedi che lei sta cambiando di nuovo, sta vedendo con lucidità cosa sta capitando all’aristocrazia: la finanziarizzazione del denaro ereditato che viene investito nell’immobiliare. Qui lei sta vedendo di nuovo con molta lucidità cosa sta capitando all’aristocrazia. Siamo ai giorni nostri.
(Minima&moralia, blog di approfondimento culturale, 26 gennaio 2026)
Ogni romanzo è un sopravvissuto. A un editor goffo, a un editore stupido o stronzo o modaiolo, a una miseria del tempo in cui viene pubblicato, a una maledetta sfortuna e, prima di ogni cosa, al genere di chi lo ha scritto. La domanda che è sempre affascinante e ragionevole porci, quando leggiamo una scrittrice, è: lo avrebbe scritto così, se non fosse stata una donna? Fatto salvo che la differenza sessuale conta, assegna uno sguardo e un sentire (chi scrive si colloca con agio nel femminismo della differenza), e quindi la prima risposta è sempre no, c’è poi la più complicata questione di quello che a una scrittrice viene detto, consigliato, talvolta imposto di scrivere proprio perché è una donna. Le storie dei rifiuti editoriali dei capolavori di grandi scrittrici spesso costituiscono romanzo a sé, sebbene siano meno note e tracciate rispetto alle storie dei rifiuti editoriali subiti dai colleghi: quando si parla del fenomeno, e lo si fa nella sciagurata chiave «Coraggio, non desistere, anche Stephen King è stato messo alla porta», si rimanda quasi soltanto ai no assestati agli autori. Il rifiuto editoriale archetipico è sempre Il Gattopardo, mai Via col Vento.
Delle scrittrici, tuttavia, sono più intriganti le storie delle correzioni, i consigli che hanno dovuto ascoltare, gli snaturamenti delle loro opere. Alle scrittrici è successo di più che agli uomini, e in un modo preciso: dovevano dar conto di essere donne, e a lungo ci sono state cose che le donne potevano scrivere e cose che, invece, no, perché avrebbe nuociuto alla loro reputazione, perché avrebbe scandalizzato, perché avrebbe pervertito (aha!) adolescenze, etiche, ruoli. Se in molte hanno usato uno pseudonimo anche quando essere una donna è diventato, ai fini della pubblicazione, un bonus, è anche per non doversi sentir dire a quale categoria corrispondere: fino agli anni Settanta per pubblicare era tanto meglio essere (e/o scrivere da) morigerata borghese, santa, pettegola, guerrafondaia (Sibilla Aleramo non avrebbe probabilmente mai pubblicato se, ai suoi esordi, non fosse stata – non avesse scritto da – accesa interventista); ultimamente conviene aver subito quello che si racconta, soffrire di un qualche disturbo, avere un qualche cronico travaglio. È divertente che le più libere da questo giogo siano ora le autrici di romance, che non proprio a caso usano solo pseudonimi (Erin Doom, Felicia Kingsley, Stefania S.), visto che il romance è un genere al quale le autrici sono state relegate per decenni ritenendo che solo di quello potessero occuparsi e che quindi essere una scrittrice significasse fare romanzi rosa (era per smarcarsi da questo orribile sinolo che Morante ordinava di chiamarla scrittore). Per difficile che sia da immaginare, vista la mole di pubblicazioni, i rifiuti e le correzioni, anche autoindotte, a fini di performance, capitano ancora, e si intuiscono alla semplice lettura. Molta letteratura femminile contemporanea risente ancora del bisogno, tutto editoriale, di inscrivere una scrittrice nelle storie che racconta, e di decidere per quali storie di donne c’è o ci sarebbe mercato. Quanto sarebbe utile un esaustivo volume che raccontasse tutte le volte che una romanziera, dal 1726 al 2026 si è sentita dire «questa storia ti rappresenta?». Alarico Tassè, nome dietro cui è rimasta ostinatamente celata
l’autrice di alcuni dei racconti più precisi e spietati del ’900 italiano, Il topo Chuchundra (nel 1963 per Feltrinelli e nel 2017 per Elliot, grazie all’eroica Giulia Caminito), si astenne dallo svelare chi fosse e pure dallo scrivere altro per non doversi sedere a discutere con un editore. Per non dover dire «mi veda, sono brava», come fece per tutta la vita Dolores Prato, che esordì a ottantotto anni con il capolavoro Giù la piazza non c’è nessuno, falcidiato da un corposo taglio imposto da Natalia Ginzburg. Prato, che per decenni chiese e a volte supplicò, ma non cambiò mai una virgola, cedette solo con Ginzburg, perché era Ginzburg. […]
(La Stampa – TuttoLibri, 17 gennaio 2026)
In libreria “Safaa e la tenda”, Fandango editore, gennaio 2026
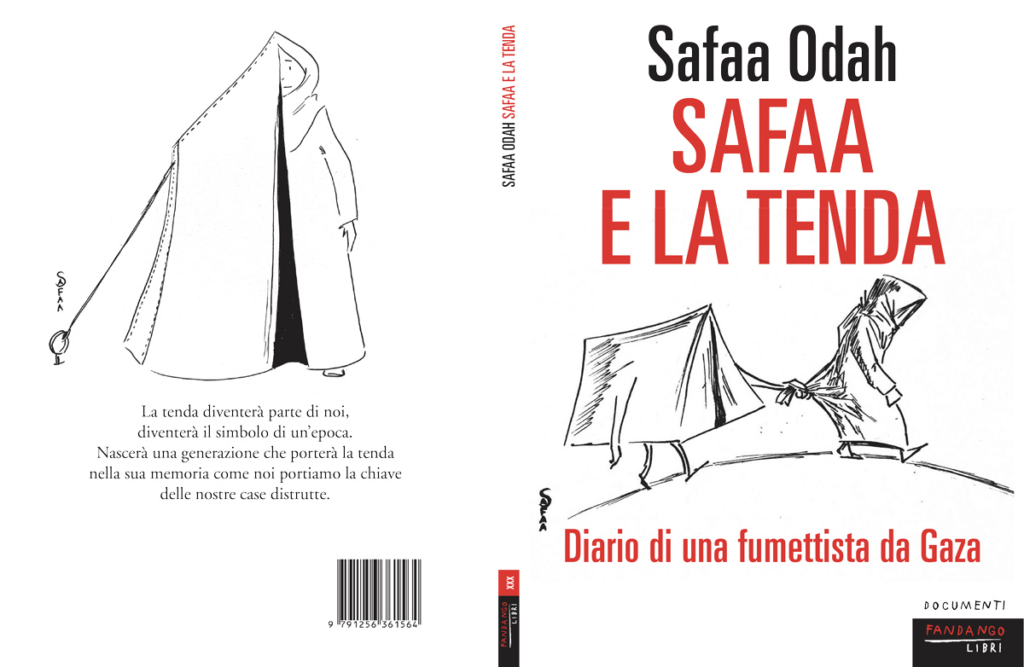
Dopo il 7 ottobre 2023, la fumettista di Gaza Safaa Odah è stata sfollata più volte, ma dal campo profughi di Al-Mawasi continua a disegnare, usando le pareti della tenda quando la carta finisce. «La tenda diventerà parte di noi, diventerà il simbolo di un’epoca. Nascerà una generazione che porterà la tenda nella sua memoria come noi portiamo la chiave delle nostre case distrutte», scrive sotto un disegno. Safaa racconta due anni di genocidio attraverso immagini straordinarie dal tratto essenziale, cogliendo il dolore e la resistenza del popolo palestinese nei dettagli della vita quotidiana, e intrecciando emozioni diverse, sguardo femminista, senso dell’umorismo, forza della controinformazione. Con un tratto morbido ritrae l’inferno di Gaza per metterne in luce l’aspetto semplicemente umano, capace di parlare a tutte e tutti noi. «Una telecamera da sola non riesce a catturare abbastanza bene quello che sta succedendo, mentre il disegno può aiutare a mostrarlo», dichiara. Fandango Libri raccoglie le opere realizzate da Safaa Odah tra ottobre 2023 e dicembre 2025, insieme a una postfazione di Pat Carra con intervista all’autrice.
Nata nel 1984 a Rafah nella Striscia di Gaza, Safaa Odah è una fumettista e artista dell’animazione, con un master in psicologia. Nel 2025 ha ricevuto lo Special Award di LICAF (Lakes International Comic Art Festival) per Safaa and the Tent 2023/2024, di cui il libro italiano è l’edizione estesa 2023/2025. Ha un grande seguito sulle sue pagine social e pubblica su giornali arabi, tra cui Al-Araby Al-Jadeed,e in Italia sulla rivista Erbacce, nella rubrica “Una tenda in Palestina”.
(Erbacce, 12 gennaio 2026)
È difficile scrivere su Simone Weil. Molto è stato scritto su di lei in varie lingue, ma forse più intrigante è il fatto che Simone Weil ha spesso indotto a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a farsi ispirare nella propria attività di pensiero e di scrittura dal suo irripetibile modo di essere. Ciò è accaduto a scrittrici come Ingeborg Bachmann, Elsa Morante, Cristina Campo, per citare solo alcuni nomi. Viene da pensare che scrivere su Simone Weil dovrebbe assomigliare a ciò che lei affermava a proposito della filosofia: «cosa esclusivamente in atto e pratica. Per questo è tanto difficile scrivere al riguardo, difficile così come un trattato di tennis o di corsa a piedi, ma in misura superiore» (Quaderni IV, p. 396, Adelphi 1993).
La raccolta di saggi curata da Isabella Adinolfi, Necessità e Bene Intorno al pensiero di Simone Weil (il melangolo, pp. 350, euro 28,00), è dedicata a Giancarlo Gaeta, uno dei principali studiosi italiani dell’opera di Simone Weil al quale dobbiamo la traduzione dei Quaderni e un’instancabile riflessione sul suo pensiero. Nel saggio dello stesso Gaeta che apre il volume, Il testamento politico di Simone Weil, troviamo la conferma del fatto che scrivere su di lei non può essere che «cosa in atto e in pratica». Gaeta racconta di aver riletto alcune pagine di La prima radice, l’ultima opera di Simone Weil pubblicata postuma nel 1949 da Albert Camus, su suggerimento di un amico pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina. E commenta: «Sono rimasto anch’io preso dalla lettura di quelle pagine e me ne è venuta l’impressione di non aver mai letto davvero l’opera di cui sono parte». Quel come se non avessi mai letto davvero pagine che sicuramente gli erano note ha la forza di una scossa.
Gaeta ha più volte ribadito il rifiuto di un’attualizzazione del pensiero di Simone Weil e allude a qualcosa di molto diverso, alla «vera attualità, quella cioè che racchiude in sé tutte le attualità», come l’ha chiamata Ingeborg Bachmann nel suo saggio radiofonico del ’55 (La sventura e l’amore di Dio. Il cammino di Simone Weil, in Il dicibile e l’indicibile, Adelphi 1998, p. 116). La sua nuova lettura di un testo «rimasto politicamente lettera morta» parla dello «scarto» dell’ultimo pensiero politico weiliano, del suo «scorgere nella tragica vicenda in corso ciò che ben pochi furono disposti a vedere». E definisce la consapevolezza di Simone Weil rimasta estranea ai suoi diretti interlocutori con le parole di Patrice Rolland: «Il fallimento della civiltà europea reso manifesto dalla ripetizione di due guerre mondiali richiede un giudizio ‘religioso’ o ‘spirituale’». Gaeta suggerisce di leggere quello scritto, che si presenta come un «flusso ininterrotto di scrittura», come una «sinfonia mahleriana: una sequenza di temi e motivi che si sommano e s’intrecciano, cosicché sta all’orecchio di ciascun lettore cogliere i passaggi, gli stacchi, le riprese». E conclude che bisogna accettarne l’«incompiutezza», l’«arresto brusco che non acquieta in una conclusione e dice comunque a qual punto l’esistenza dell’autrice vi fosse implicata». Aggiungerei «a qual punto» l’esistenza di ciascuno di noi dovrebbe esserne implicata.
La scossa sperimentata da Gaeta ha una notevole forza di propagazione nella raccolta di saggi curata da Isabella Adinolfi. Il volume si chiude con un saggio di Maria Concetta Sala, studiosa, traduttrice e curatrice di testi weiliani, dedicato al «farsi orecchio», alla pratica di ascolto delle «voci dell’esperienza» di Svetlana Aleksievič. In appendice si può anche leggere la sceneggiatura del film di Serena Nono, Sventura. L’inferno di Jaffier (2019), sequel di Venezia salva (2011-’12). La regista è anche pittrice e sulla copertina del libro c’è un suo ritratto di Simone Weil (2001).
Adinolfi, profonda conoscitrice di Simone Weil, ha scelto di intitolare il libro Necessità e Bene, termini che indicano i due bracci della Croce (immagine chiave dell’universo weiliano) che si incontrano in un punto, quello di ogni fragile e sventurato essere umano. Nel saggio introduttivo spiega la sua scelta come il frutto della ricerca di un fulcro, di una chiave di lettura in grado di cogliere il movimento di un pensiero che si articola su una molteplicità di piani e di prospettive e si alimenta di una pratica di traduzione di Omero, Sofocle, Eschilo, di amore per la poesia, di letture di Platone, del Vangelo, della Bhagavadgītā. La relazione tra Necessità (la «spietata regolarità dell’ordine del mondo») e Bene (l’amore di Dio) attraversa l’intero pensiero weiliano e si collega al «grande enigma» della sventura umana nella forma, a un tempo, di contraddizione insolubile, e di «fragile passaggio» a un altro ordine, quello della Bellezza, della Verità e della Giustizia. Si tratta di un tema che contiene il pathos e l’esattezza di Simone Weil, il suo essere stata una pensatrice poetica e insieme una mente che si è spinta coraggiosamente al confine con la trascendenza, che in lei è diventata esperienza vissuta dell’esigenza assoluta di giustizia, dell’aspirazione alla purezza e alla bellezza.
I saggi raccolti nel volume approfondiscono i temi principali del pensiero weiliano, dal pensiero politico alla concezione della poesia, della religione, della giustizia, del diritto, dell’insegnamento, dell’attenzione e della compassione. Viene inoltre esplorato il rapporto con i pensatori (Descartes, Pascal, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche) con i quali Simone Weil si è confrontata. In alcuni, in particolare in quelli più specialistici, il tema del rapporto tra Necessità e Bene resta in controluce. La sua luce esplode tuttavia improvvisa, quasi inaspettata, in un profilo dell’attività weiliana apparentemente marginale e poco noto, quello della produzione poetica (otto poesie, la pièce Venezia salva).
Nel saggio Andare mediante le parole al silenzio. Poesia e poesie in Simone Weil Domenico Canciani riporta l’affermazione di Simone Pétrement, autrice di una ormai classica biografia, che Simone Weil fosse disposta a «sacrificare la sua opera per le poche poesie che aveva scritto». Canciani ha ricostruito le fonti e in particolare la relazione delle poesie con gli scritti filosofici, con il lavoro di traduzione e la riflessione sul linguaggio e nel suo contributo offre una lettura della poesia Il mare, composta nel 1932. Consiglierei ai lettori e alle lettrici del libro di partire di qui, da questa poesia, che è una preghiera, per non perdere nella complessità del pensiero weiliano l’essenza, vorrei dire la scommessa, insita nel rapporto tra Necessità e Bene. Ne cito alcuni versi nella traduzione di Domenico Canciani: «Oscillanti e fisse le onde del fondale, / Ove a tempo debito ogni goccia discende e risale, / Per la legge sovrana restano giù in basso. / La bilancia dai segreti bracci d’acqua trasparente, / Pesa se stessa, la spuma e il ferro, / Giusta, non vista, verso ogni barca errante. / Sullo scafo un filo blu traccia un rapporto. / Senza errore, nella sua linea apparente. / Vasto mare, abbi pietà degli sventurati mortali, / Stretti sulle tue rive, persi nel tuo deserto. / A chi s’inabissa parla prima che soccomba. / Scendi nella sua anima, nostro fratello mare, / purificala nelle tue acque di giustizia».
(il manifesto – Alias, 11 gennaio 2026)
A un certo punto della lunga, stupenda, massacrante conversazione che Carla Lonzi e Pietro Consagra hanno per sottoporre la loro relazione alla prova dell’autocoscienza, lui le dice: «Sento che dal femminismo ho guadagnato. Come uomo, ho avuto la sensazione che quello che ci guadagna dal femminismo è più l’uomo che la donna». Lei gli dà ragione, e aggiunge però che quel guadagno rafforza solo in parte gli uomini: «Quando il padrone è stato cosciente del suo profitto, si è indebolito: ha dovuto cominciare a trattare con chi era cosciente di dargli un profitto». È il 1980, Lonzi è la più importante teorica del femminismo radicale italiano e morirà due anni dopo, cinquantunenne, anche se ancora non lo sa; Consagra è uno scultore di fama, stanno insieme da sedici anni e decidono di mettersi alla prova: si chiudono in una stanza, con un registratore acceso, e discutono per quattro giorni dell’incomprensione di fondo, insanabile, che mina la loro relazione e il loro dialogo, e che trova ragione nel fatto che lei è una donna e lui un uomo. Lui non è in grado di riconoscerla davvero, anche se la ama e le sta accanto. Il loro legame è inevitabilmente impari: non è uno accanto all’altra che potranno battersi per il femminismo. Vai pure, il libro che è la trascrizione di quelle conversazioni, è stato da poco ripubblicato da La Tartaruga e non è invecchiato neanche di un giorno.
Consagra aveva ragione: del femminismo beneficiano innanzitutto gli uomini, essendo vittime di patriarcato quanto le donne. Ed è vero persino ora, mentre il femminismo e le sue pluralità sembrano non certo sconfitte, ma avversate, in linea con il momento di rigetto di tutti i traguardi progressisti degli ultimi anni, e con la contrazione dei diritti e delle diversità.
È difficile prevedere se siamo alla vigilia di uno dei molti inabissamenti di cui è piena la storia dell’affermazione della differenza delle donne: i segnali che arrivano dalla società civile sono diversi, spesso contraddittori, la rivalutazione della vita familiare tradizionale, l’ossessione procreativa di tutti i governi occidentali, la limitazione dei diritti riproduttivi, le difficoltà di conciliazione di vita e lavoro convivono con una diffusione della coscienza di genere e del problema della violenza patriarcale, così come con assetti relazionali sempre meno iniqui.
I medesimi opposti stanno in piedi tanto nel piano privato quanto in quello pubblico, tanto in quello politico quanto in quello culturale. A beneficiare del femminismo, in ambito culturale e specificamente letterario, sembrano essere ultimamente e sempre di più gli scrittori. Si tratta di una predazione, di una appropriazione culturale?
Una quasi certezza è che il femminismo ha migliorato gli uomini (non tutti) e ha migliorato gli scrittori (non tutti) ma resta da capire se questo cambiamento finito bene, visto il modo in cui è avvenuto, ha incluso o meno le donne, se è avvenuto o sta avvenendo, per surreale e paradossale che possa sembrare, a loro discapito.
Esistono due macrocategorie: scrittori che registrano il cambio di sguardo sulla virilità che le battaglie femministe hanno non solo richiesto e talvolta imposto, ma pure elaborato, e quindi cambiano il racconto del maschile (e per utopistico che possa sembrare, quello che cambia e succede nei libri, prima o poi cambia e succede nel mondo); scrittori che si fanno testimoni della battaglia femminista.
Quando Andrea Bajani ha vinto il premio Strega e ha detto «Anche gli uomini devono combattere il patriarcato», oltre al plauso c’è stato il biasimo: è parsa una dichiarazione facilona, opportunista, in fondo figlia di un momento in cui, come che vada il mondo, dirsi accanto alle donne, oltre che qualificante, è redditizio. La letteratura non è mai stata meno immune alle meccaniche produttive capitalistiche, pertanto non ha anticorpi per non ammalarsi della brandizzazione del femminismo. Non che non esistano scrittrici che hanno, più di una volta, piegato il femminismo a fini commerciali.
Se ci sono i maschi performativi, cioè quelli di buone letture, buoni consigli, ottime credenziali etiche, ma biechi intenti, esistono anche gli scrittori e gli intellettuali performativi, e ne dà una descrizione esilarante Tony Tulathimutte in Rifiuto (e/o, traduzione di Vincenzo Latronico) e questo è un esempio glorioso di come la propagazione femminista abbia vivificato il dibattito intellettuale: quando il teatro e la letteratura ne fanno una buona parodia, una emancipazione è il più delle volte vicina a compiersi.
C’è stato e c’è molto entusiasmo per Nella carne di David Szalay, che ha vinto il Booker Prize del 2025 (lo abbiamo scritto già su questo giornale, tra i bilanci dell’anno appena passato: tutti i grandi premi letterari, nazionali e non, l’anno appena passato sono andati a uomini, che hanno fatto rubamazzo, e chi lo sa quanto sono consapevoli che parte del merito è anche del femminismo, lo stesso femminismo che è, insieme, lotta contro di loro e lotta per loro).
Szalay racconta le alterne fortune di un ungherese che gira per l’Europa: lo vediamo uccidere il marito della sua amante quando è adolescente, finire in riformatorio, fare il soldato in Iraq, drogarsi, perdersi, salvare la vita a un uomo, fare l’autista di un ricco affarista e diventare l’amante di sua moglie. Lo vediamo cercare se stesso. Lo vediamo soffrire dei casi della vita e della condizione maschile. Lo vediamo rispondere a monosillabi, essere impenetrabile per annichilimento da “sacrificabilità maschile”, concetto caro ai movimenti della manosfera, lo vediamo, grazie all’abilità dello scrittore ma pure allo sguardo e alle contezze che il femminismo ci ha dato in questi anni, essere vittima di ruoli, stereotipi, sovrastrutture. Lo vediamo reagire o per rabbia o per rassegnazione: raramente, forse mai, per amore di sé e della vita. Qualcuno ha calcolato che István, questo il nome del protagonista, dice «ok», in tutto il romanzo, cinquecento volte. E tutte le volte è sia asservito che assertivo: più che di un romanzo sulla mascolinità tossica, come è stato scritto diffusamente, sembra che Nella carne sia un romanzo sul cambiamento ambiguo e bifronte della mascolinità, il suo soggiacere e il suo ribellarsi. Tuttavia, in queste quattocento pagine non tutte magnifiche, non c’è molto di più, sull’intimità maschile, di quello che Martin Amis, ne L’informazione, uno dei più grandiosi libri sui maschi e sull’amicizia (era il 1995), ha scritto in tre righe di incipit: «Le città di notte contengono uomini che piangono nel sonno, poi dicono niente. Non è niente. Solo un sogno triste». Quello che avrebbe potuto esserci, di più, e non c’è, in Nella carne, sono le donne: la relazione con loro, il tentativo di dialogo e l’esplorazione delle sue possibilità, lo stesso che fece Carla Lonzi in Vai Pure. E questo è il limite di quasi tutti i libri sul maschile usciti negli ultimi anni, tranne forse La voce del padrone (add) di Francesco Pacifico, spassoso reportage di un uomo dalla sua vita privata condivisa con una compagna femminista. La tanto dichiarata crisi della virilità, quindi, per ora, ha portato a un racconto nuovo del maschile, ma non della relazione del maschile con il femminile. Per ora, il femminismo giova agli scrittori perché dà loro argomenti certi, bandelle accattivanti, ispirazioni, in fondo facili, per romanzi affollati da uomini che compiono interessanti liberazioni solitarie, che resistono, che si ricompongono, che si sgretolano, ma che lo fanno per sé.
(La Stampa, 9 gennaio 2026)
Il racconto della Visitazione offre l’immagine che più si avvicina e ispira i percorsi delle donne che desiderano camminare insieme per dare vita al mondo in pienezza.
(Visitazioni, Gruppi donne delle Comunità cristiane di Base e le molte altre
https://www.cdbitalia.it/upload/gdonne/Visitazioni.pdf)
Scrivere narrando è fondamentale per noi donne, non solo per alimentare la genealogia femminile, ma anche per affermare che la nostra scrittura non si allontana mai dalla realtà. Con questa riflessione la teologa Antonietta Potente introduce il libro di Paola Cavallari, Lilith se ne va. Femminismo, spiritualità e passione politica (Vanda 2025).
L’opera è un intenso percorso di vita e di scrittura in cui Lilith risplende come un’icona archetipica. Il suo rifiuto eversivo della sottomissione la rende un personaggio chiave in un’ipotetica epica femminista: Lilith si congeda dal ruolo assegnatole e il suo indomito carattere la spinge a scegliere la via della libertà, che diviene sorgente e aurora della soggettività femminile.
Lo stesso percorso dell’autrice si orienta in questa direzione, verso la libertà, segnato da due fuochi inestinguibili: il femminismo, che l’ha afferrata in giovinezza come passione di vita irriducibile, e la dimensione spirituale, fiorita in età matura nell’adesione alla bellezza del messaggio evangelico, «purificato con fatica dalle incrostazioni di potere clericale e kiriarcale che lo hanno tradito».
Il femminismo descritto nel suo libro è un’esperienza «goduta nel suo potenziale politico ed esistenziale», un approccio che si avvicina sorprendentemente a ciò che Antonietta Potente suggerisce di chiamare Misticapolitica.
Si tratta di un sentire femminile che non teme gli sconfinamenti tra anima e corpo, è in ascolto del desiderio di autenticità, ricerca il respiro della trascendenza e si impegna a disseppellire quella lei originaria che è stata annientata da secoli di religioni patriarcali. Per Paola Cavallari questo approccio è diventato la sua casa, la rotta da seguire nel farsi della sua mappa esistenziale.
Il libro, come lo definisce Gabriella Caramore nella prefazione, è un «diario intellettuale e spirituale» che copre un arco temporale di circa trent’anni (1994-2024). È un «arcipelago di scritture» in cui vibra la narrazione del suo percorso di vita attraverso una vasta gamma di contributi: esegesi bibliche, saggi, articoli, interviste, frammenti autobiografici, riflessioni sulla spiritualità, testimonianze di pratiche politiche collettive, prese di posizione e recensioni. In tutti gli ambiti da lei toccati si intrecciano i fili dell’esperienza femminista: l’autocoscienza, l’analisi critica, lo scambio di parola con le altre donne e la scia luminosa delle madri simboliche con cui l’autrice continua a dialogare e confrontarsi. Paola Cavallari si racconta sempre in prima persona, non temendo di esporre le proprie ferite, con la ferma intenzione di partire da sé per dare voce al non detto. Un lavoro simbolico che non compie in solitudine: l’autrice dialoga costantemente con pioniere del femminismo (Simone de Beauvoir, Carla Lonzi, Judith Butler) e figure spirituali e intellettuali (Simone Weil, Etty Hillesum, Hannah Arendt). Centrale è stata per lei anche l’esperienza del gruppo di Venezia-Mestre Donneperlacittà, che ha saputo unire prassi politica e ricerca intellettuale.
Il suo viaggio a ritroso, teso a riaprire la ricerca di senso e a ripercorrere «orme di vita che si metamorfosano in scrittura», è profondamente illuminante. Emerge un sofferto rapporto con la parola fin dall’infanzia: un’esperienza in cui moltissime donne possono rispecchiarsi. Da bambina Paola rifiutava la scrittura e la parola: il suo mondo interiore, descritto come «barbaro, naïf, libero, inafferrabile, fantasmagorico», ancorato all’autenticità della lingua materna, veniva tradito dal linguaggio adulto, provocando un’afasia in cui il dentro non trovava corrispondenza nel fuori. L’evoluzione si è manifestata pienamente solo quando l’autocoscienza ha «fatto saltare il tappo», permettendo alla lingua di essere finalmente risignificata in risonanza con il suo sentire originario. È attraverso questa lente che Paola ha potuto osservare il disegno che «sbalza come un bassorilievo vivente dalla sostanza della propria vita», avviandosi così alla ricomposizione delle parti di sé precedentemente dissociate.
Un’“integrità dell’io” che le ha conferito la forza per affrontare coraggiosamente lo scacco, l’impotenza e la sventura, trovando la sua «scintilla di salvezza» nel «consegnarsi al limite». È stato il suo passaggio nella notte oscura, da cui è scaturita una grande verità: «Quanto più grandi sono fiducia e gratitudine tanto più si espande la realtà di cui godiamo».
Nel suo breve poema, ispirato al celebre passo di Sant’Agostino Tardi ti ho amato, l’autrice racconta con parole commoventi il proprio risveglio, il «dono ricevuto dell’aurora». Passo dopo passo, la dimensione spirituale, la presenza del “divino”, è divenuta per lei un luogo accogliente di conforto e approdo.
Da questo punto prende avvio la narrazione di un percorso da me condiviso con lei, che per me è anche memoria della gioia vissuta nella nostra “Visitazione”: un incontro da cui è nato un legame profondo e generativo di nuovi contesti relazionali. Come ricorda Rebecca Solnit, del resto, la gioia è sempre «un meraviglioso primo atto di insurrezione».
L’ambito a cui mi riferisco è quello dei Gruppi Donne delle Comunità cristiane di base e delle molte altre che, a partire dal femminismo degli anni Settanta, continuano a interrogarsi, partendo da sé, sulla propria esperienza spirituale in relazione alle scritture bibliche, alla preghiera e al linguaggio per dire Dio. Il binomio “femminismo e spiritualità” ha trovato per Paola rappresentazioni concrete in questa teologia dal basso, dove è possibile sperimentare quella coerenza tra pensiero e pratiche a cui anela un’anima in ricerca come la sua:
«Ci sono incontri, e questo lo fu, in cui come per magia ti imbatti in ciò che cercavi nell’intimo, ma di cui non avevi consapevolezza prima di intercettarlo […] Fatto sta che non era più un altare con un celebrante maschio, ma una mensa con un’assemblea celebrante in cui le donne si riconoscono autorità di celebrare. I nostri corpi in circolo, le nostre voci che si allacciano passando l’una all’altra il testimone di parole di benedizione reciproca […]».
In questi spazi continuano a circolare liberamente saperi, autorità femminile, pratiche politiche e spirituali che rendono possibile il «fecondarsi nella reciprocità» di cui Paola parla.
Il libro di Paola è dunque un’opera molteplice: è anche la restituzione di percorsi condivisi, di reti di relazioni che si intrecciano creando una corrente viva in cui si diventa “onda e oceano al tempo stesso”, come suggerisce l’autrice riprendendo le parole usate da Etty Hillesum che richiamano al Tao.
Nei suoi saggi non rinuncia mai a sottoporre a lucida analisi l’impronta patriarcale nelle Scritture e nella storia della Chiesa. Sulla base della teologia femminista elabora profonde intuizioni che danno vita a nuove e originali interpretazioni dei testi sacri. Ma i suoi articoli, che sono spesso veri e propri manifesti di denuncia contro la persistenza patriarcale nelle chiese, sono sovente arricchiti da idee e da proposte di sperimentazione concrete.
Un passaggio fondamentale della sua storia è stato l’assunzione in prima persona di un nuovo progetto da lei ideato, a cui abbiamo aderito in molte: la fondazione, il 14 marzo del 2019, dell’Osservatorio Interreligioso sulle Violenze contro le Donne (OIVD), «la pianticella che, con passione, abbiamo messo al mondo». L’OIVD è un organismo composto da donne ebree, musulmane, induiste, buddiste e cristiane delle diverse Chiese, perché l’insignificanza delle donne e la violenza che ne consegue attraversano in modo trasversale tutte le religioni. È aperto anche agli uomini e si pone l’obiettivo di essere «pratica vivente di una teologia del dialogo interreligioso di genere». È luogo di relazioni, dove circola autorità femminile diventando il punto di intersezione di una rete più vasta.
Le parole di Antonietta Potente incorniciano l’opera dell’autrice, riconoscendone la potenza generativa: «Creare è il nostro gesto preferito: creare tessuti libri pagine scritte con le nostre parole. Creare cibo per nutrire ed essere nutrite, creare ordine nella propria vita come se fosse l’inizio di una nuova creazione». E ringrazia Paola per la tessitura di queste parole vive, nate dal suo sentire e dal suo contemplare la vita. Una simile narrazione può aprire passaggi di consapevolezza e innescare processi dinamici in molte altre donne che con lei condividono il cammino; tra le quali ci sono anch’ io. Per questo desidero unire la mia voce al suo ringraziamento.
(Viottoli, n.2/2025)
L’economia femminista di Emma Holten di cui ci parla in questo articolo Maria Dell’Anno Sevi è in sintonia con il nostro Manifesto Immagina che il lavorodel 2009, dove affermiamo: «Lavoro è tutto il lavoro necessario per vivere». Cioè, comprende tutti quei lavori che sono in gran parte svolti dalle donne e che non hanno alcuna valorizzazione economica, quando invece sono alla base dell’esistenza (mettere al mondo e allevare dei bambini, gestire e svolgere il lavoro che richiede la sfera familiare e domestica, assistere i malati, ecc.).
(Silvia Motta)
«L’economia è la lingua madre della politica, è il linguaggio del potere». In un mondo capitalistico «ciò che possiamo permetterci equivale a ciò che è possibile fare». Ma, si domanda Emma Holten, «come viene calcolato il valore nella società?»
La scrittrice e attivista femminista danese Emma Holten, nel suo libro Deficit (Ed. La Tartaruga, 2025), mette in discussione la struttura apparentemente immodificabile dell’economia mondiale a partire da un interrogativo: quando smetteremo di considerare il lavoro di cura delle donne un deficit, una perdita in termini di denaro? L’autrice racconta di essersi infuriata leggendo un articolo sull’economia danese che bollava le donne come “un deficit per le casse dello Stato”: perché fanno lavori meno pagati o part-time e quindi pagano meno tasse contribuendo in misura minore al PIL, partoriscono e usufruiscono del congedo per maternità, dedicano molto tempo a prendersi cura degli altri. Non producono valore, quindi, in un’ottica economica. Ma, appunto, come viene calcolato il valore nella nostra società?
Quando tutto è definito da un prezzo si crea una gerarchia, e le cose a cui appare difficile attribuire un prezzo finiscono in fondo alla gerarchia: questo non significa che quelle cose non abbiano in effetti un valore, bensì che nel dibattito economico-politico vengono trattate come se non lo avessero. «Quando qualcosa non ha prezzo, il suo prezzo diventa zero». Per il capitalismo ciò che non ha un prezzo non ha un valore. E ciò che non ha un valore è considerato una spesa.
L’economista Clara Mattei – docente alla New School for Social Research di New York, nonché nipote della partigiana e costituente Teresa Mattei – nel suo libro L’economia è politica (Ed. Fuoriscena, 2023), evidenzia che siamo stati portati a credere che l’economia sia una scienza esatta e che il capitalismo sia l’unico modo possibile di vivere. In realtà il capitalismo è una scelta politica, e il capitale come merce, come denaro da investire, come ricchezza espressa in PIL «esiste grazie a specifiche relazioni sociali e, in particolare, grazie al fatto che la maggioranza della popolazione globale non ha alternativa se non quella di vendere la propria capacità di lavorare per un basso salario ed essere retribuita meno rispetto al valore che produce. È questo “l’ordine del capitale”, di cui non parliamo mai ma che sta alla base della nostra società». Quante volte sentiamo dire o diciamo noi stessi/e che avere un lavoro – qualunque lavoro sia, per quanto orribile sia – è comunque una fortuna per la quale bisogna ringraziare? Ebbene stiamo ringraziando per esserci sottomessi all’ingranaggio di un sistema che grazie alla nostra forza-lavoro arricchirà sempre e solo una piccola percentuale di ricchi: è la paura di perdere il lavoro che ci fa accettare condizioni di lavoro sempre peggiori. Il problema è che se le persone si rendessero veramente conto di essere sottomesse ad un sistema ingiusto basato sul dominio di classe e non accettassero più la condizione di salariati a basso costo, crollerebbe la base stessa del sistema economico in cui viviamo: il capitalismo è di fatto incompatibile con la democrazia, così come è di fatto incompatibile con la sostenibilità della vita. Proviamo a rileggere con gli occhi di Clara Mattei l’annuale legge di bilancio: «Se lo Stato italiano, come la maggior parte degli Stati del mondo, aumenta la spesa militare o quella per salvare e sostenere banche e imprese in difficoltà e al contempo taglia la spesa sociale (sanità, scuola, trasporti, edilizia pubblica, sussidi di disoccupazione e via dicendo), sta trasferendo strutturalmente le risorse dai molti cittadini che dipendono dai salari che guadagnano ai pochissimi che vivono dei redditi da capitale generati dalla ricchezza posseduta. In altre parole, non si tratta per gli Stati di non spendere, ma di “spendere” nella maniera “corretta”, ovvero a favore dell’élite economico-finanziaria e a discapito della maggioranza della popolazione. Mentre ci curiamo in ospedali fatiscenti, studiamo in classi pollaio e facciamo file chilometriche per rinnovare la carta d’identità, i forzieri di Leonardo, produttore di armi, e Autostrade per l’Italia (i cui azionisti sono per metà asset manager stranieri come Blackstone e Macquarie) traboccano di soldi delle nostre tasse. Per la classe dei capitalisti la retorica del “non ci sono i soldi” non esiste. Queste manovre economiche non sono solo decisioni tecniche, sono scelte profondamente politiche. Meno risorse sociali abbiamo, meno diritti abbiamo in quanto cittadini e più siamo costretti a comprare tali diritti con il denaro. Così la nostra dipendenza dal mercato aumenta. Se vogliamo garantire una buona istruzione ai nostri figli, assicurarci cure mediche adeguate, una casa dignitosa, il diritto al trasporto, siamo sempre più vincolati alla necessità di avere soldi a sufficienza, che ci possiamo procurare in un solo modo, vendendo la nostra capacità di lavorare in cambio di un salario». Ecco che il sistema capitalistico si autoalimenta sfruttando proprio quella sensazione di inevitabilità che gli economisti ci hanno inculcato. Riassume con veemenza Clara Mattei: «È ora di smetterla di bersi l’idea che nella società capitalistica abbia senso discutere di politiche economiche ritenute corrette o sbagliate in vista di un fantomatico bene comune. Occorre rendersi conto che nel sistema capitalistico le politiche economiche funzionano a vantaggio di alcuni e a discapito della maggioranza. La nostra macchina economica non è strutturata per soddisfare i bisogni della gente comune ma per aumentare la rendita e i profitti dei pochi detentori di capitale. Ciò che è vantaggioso per i profitti è certamente svantaggioso per la maggioranza delle persone, dato che il vantaggio per i primi si fonda in larga parte sul sacrificio delle seconde». Gli uomini hanno costruito una società su fondamenta patriarcali, antropocentriche e capitaliste, ignorando l’ecodipendenza e l’interdipendenza. Eppure – ci ricordano Giovanna Badalassi e Federica Gentile (Ladynomics) nel loro libro Signora Economia (Ed. Le Plurali, 2024) – il termine “economia” etimologicamente vuol dire “amministrazione della casa”, significato che ci rimanda subito alla sfera domestica familiare e non alla sfera produttiva pubblica.
Emma Holten propone quindi un nuovo approccio economico: l’economia femminista. L’economia femminista mette al centro le persone e le relazioni umane al posto del mero profitto, la soddisfazione dei bisogni primari anziché dei desideri costruiti, salvaguardando l’equità e la democrazia. Nelle parole di Marcella Corsi – traduttrice del volume Economia femminista (Ed. Alegre, 2025) – «l’economia femminista non è semplicemente un’altra branca dell’economia politica, ma un altro modo di intendere il mondo, un tentativo di costruire un paradigma economico alternativo a quello dominante, generatore di disuguaglianze multiple». Alla base dell’economia femminista Holten pone riproduzione e lavoro di cura, «cioè tutte le attività retribuite e non retribuite necessarie per mantenere le persone sane, in forma, felici e vive», dalla scuola primaria al confortare un amico: dato che nessun essere umano può sopravvivere senza che gli altri prima o poi si prendano cura di lui, il lavoro di cura è quello che rende possibile ogni altro lavoro. «L’economia femminista si chiama così perché, nel bene e nel male, sia in passato sia oggigiorno, le donne dedicano più tempo a queste attività». Colpisce che queste riflessioni provengano dalla Danimarca, uno dei paesi più paritari al mondo: eppure anche lì Emma Holten evidenzia che le donne in casa lavorano in media 54 minuti al giorno in più rispetto agli uomini. In Italia, secondo l’Istat, una donna che lavora a tempo pieno e ha figli dedica circa 60 ore alla settimana alla somma di lavoro retribuito, domestico e di cura dei figli, contro le 47 ore del partner uomo, con una disparità di circa 13 ore, superiore alla media europea di 11 ore. In base al rapporto pubblicato dall’Organizzazione internazionale del lavoro e Federcasalinghe, il lavoro di cura non retribuito rappresenta l’85% del lavoro non retribuito in Italia, ha un valore pari a un quarto del PIL ed è svolto per il 71% dalle donne. A livello globale, secondo l’Onu, le donne svolgono almeno 2,5 volte più lavoro domestico e di cura rispetto agli uomini; secondo i dati della Commissione Europea, in UE il 79% delle donne svolge lavori domestici ogni giorno contro il 34% degli uomini. L’economia consolidata ha però difficoltà a misurare il valore del lavoro di cura, che è svolto nella maggior parte dei casi – in modo retribuito e non – dalle donne.
«Il femminismo per me è sempre stato un tentativo di capire cosa sta succedendo» spiega Emma Holten. Ed effettivamente il femminismo serve proprio a questo: a guardare con nuovi occhi il mondo che ci circonda e che la nostra cultura ci dice di dare per scontato, perché – come ricorda anche Clara Mattei – «solo se impariamo a guardare il mondo diversamente, potremo agire diversamente». Il femminismo serve a dimostrare che si può vivere in modo diverso. E che vivere in modo diverso conviene.
Holten spiega che per costruire un sistema economico che apparisse certo, meccanico e matematico si è dovuto isolarlo dal resto della vita, da quella parte della vita in cui sono sempre state presenti le donne, la cura. Il padre dell’economia moderna Adam Smith – nel libro La ricchezza delle nazioni (1776) – poneva un confine netto tra la casa, dove ci sono le donne, e la sfera economica sociale, dove ci sono gli uomini; il fatto che fossero le donne a riprodurre e crescere nuovi esseri umani destinati a diventare forza lavoro era irrilevante. «Non esisteva l’idea che quanto accadeva in famiglia potesse creare valore economico». Venne così creato l’homo œconomicus, che prende decisioni effettuando calcoli in base al proprio interesse personale e per accrescere le sue proprietà: in questo quadro l’interesse personale e l’egoismo sono «la forza trainante» del sistema economico; prendersi cura degli altri non è coerente con tale modello. Eppure – come ricorda Katrine Marçal in I conti con le donne (Ed. Ponte alle Grazie, 2016) – erano due donne, sua madre e sua cugina, a cucinare, lavare e pulire in modo disinteressato per Adam Smith, consentendogli di vivere con l’agio necessario a scrivere e promuovere le sue teorie. Ed è per questo che i più grandi autodefinitisi pensatori – maschi, bianchi, occidentali, eterosessuali – si sono affannati a teorizzare che la donna è per sua natura incline alla cura e ai lavori domestici. «Affinché l’economia acquisisse un potere e uno status pari a quello delle scienze naturali, dovevano essere create teorie che ignorassero la moralità e la filosofia. L’eredità di Smith è una visione dell’uomo che considera l’essere umano razionale ed egoista come base ottimale per costruire modelli meccanicistici della società». Per far sì che il meccanismo funzioni si è scelto di ignorare le conseguenze materiali ed economiche della dipendenza reciproca delle persone, e – come rilevavano già negli anni Settanta le studiose Mariarosa Dalla Costa e Selma James – si è scelto di sfruttare il lavoro femminile non retribuito che ha giocato un ruolo centrale nel processo di accumulazione capitalistica, in quanto le donne sono state le produttrici del bene più essenziale per il capitalismo: la forza-lavoro. Come ha evidenziato Silvia Federici – nel suo prezioso libro Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria (Ed. Mimesis, 2015) – parlare di donne in questo contesto «non significa solo una storia nascosta che deve essere resa visibile, bensì una particolare forma di sfruttamento e perciò una prospettiva particolare dalla quale riconsiderare la storia dei rapporti capitalistici».
Il sistema economico è una costruzione culturale, non natura inevitabile. Il PIL è una costruzione culturale – peraltro recentissima, risale al 1947 – e il non includervi le attività non produttive di un prezzo è una scelta culturale. «Per il PIL non c’è differenza tra prendersi cura di una schiera di bambini o fare un pisolino. Si è improduttivi». In realtà il lavoro di cura non retribuito crea un profitto a coloro che non lo svolgono, e una società in cui la vita delle donne fosse identica a quella degli uomini renderebbe la vita familiare come la conosciamo impossibile. D’altra parte, già Marilyn Waring – il cui libro If Women Counted (1988) è considerato una delle pietre fondanti dell’economia femminista – evidenziò che mentre le spese militari e di guerra aumentano il PIL, il lavoro domestico e di cura no, cioè l’economia politica considera più importanti le guerre distruttive per l’umanità rispetto alle attività che consentono la vita dell’umanità. Insomma, per i canoni dell’economia capitalistica le donne rappresentano un deficit, perché il lavoro di cura da loro svolto non è pagato o è pagato poco. Siamo noi donne a sbagliare o è il sistema economico ad essere intrinsecamente sbagliato? Emma Holten evidenzia che «siamo finiti in un paradosso: da un lato l’assistenza appare priva di valore, dall’altro rende possibile ogni altro lavoro». Affidandoci solo alla logica del capitalismo – fiduciosi che questo sia l’unico sistema economico possibile –, il cui unico scopo è produrre sempre più profitto, ci continueremo ad allontanare da ciò a cui il sistema non riesce a dare un prezzo, umiliando le persone che rientrano in quelle categorie: «ci può essere molta violenza in un foglio di calcolo».
Chiedere di cambiare qualcosa di talmente consolidato da apparire inevitabile viene bollato come utopistico e ingenuo, eppure – soprattutto dopo che la pandemia ci ha mostrato la nostra fragilità umana – è ora di scegliere tra umanità e profitto. Si può scegliere, questo è il punto.
(Noi Donne, 7 gennaio 2026)
Mi sono sempre stupita di come l’opera di Tillie Olsen, straordinaria scrittrice americana studiata nelle università, sia stata a lungo sottovalutata in Italia. Qualcosa sta cambiando grazie all’interesse della casa editrice Marietti che, dopo aver ripubblicato la raccolta di racconti Fammi un indovinello (era comparsa nel catalogo dell’estinto editore Giano, grazie a cui anch’io l’avevo scoperta), finalmente propone ai lettori italiani Yonnondio, il romanzo-capolavoro di Olsen, anch’esso nella traduzione di Giovanna Scocchera. C’è una bella e importante nota di Cinzia Biagiotti intitolata, significativamente, “Il libro ritrovato”, ed è uno di quei casi in cui la lettura del saggio-postfazione è imprescindibile per la piena comprensione di ciò che si è letto (o, invertendo l’ordine, di ciò che si leggerà): inquadrare il contesto della grande Depressione e del maccartismo, intrecciarli con la singolare vita dell’autrice, è fondamentale per capire non solo quando, ma come, è stato scritto Yonnondio – testo frammentato, stratificato e, dunque, sfaccettato tanto nella forma quanto in profondità.
Ha una ventina d’anni, Tillie Learner, quando inizia a lavorare a questo romanzo. È nata nel Nebraska da genitori immigrati, ebrei russi di militanza socialista; si iscrive diciottenne alla Lega dei Giovani Comunisti, fa attività sindacale, viene arrestata per aver organizzato la rivolta dei lavoratori di un’industria di carne a Kansas City, in carcere viene picchiata da una detenuta per averne difeso un’altra – la pratica della rimozione delle ingiustizie sociali è il suo mestiere, prima di ogni altro lavoro (nella vita, di lavori ne farà tantissimi e svariati: operaia, cameriera, lavandaia, per mantenere sé stessa e la famiglia). Nel 1933 si trasferisce in California, con due creature: Karla, la bambina che ha messo al mondo dopo essere rimasta incinta da una relazione senza futuro, e che ha chiamato così in onore di Karl Marx, e il romanzo a cui ha appena cominciato a lavorare.
Qualche anno dopo sposa Jack Olsen, l’attivista con cui era stata arrestata, dopo aver fatto con lui altre tre figlie, e dopo che la gestione della prima, Karla, era stata problematica, perché per un periodo aveva scelto di mandarla dai genitori nell’illusione di avere indipendenza e tempo per scrivere, ma la sofferenza generata da quel distacco l’aveva poi indotta a ricongiungersi con la bambina. Allora si era allontanata da Los Angeles e trasferita a San Francisco. I circoli intellettuali di Los Angeles le erano sicuramente più estranei dell’aria di San Francisco, e nella nuova città, seppur tra molte fatiche, riesce a mettere radici. Il romanzo scivola in un cassetto, mentre la vita trascorre velocissima tra la famiglia e l’attività politica, sempre molto turbolenta: Tillie è una donna troppo libera per avere a che fare senza contrasti con la dirigenza del partito comunista, e nel frattempo viene tenuta d’occhio dall’FBI, che la considera pericolosa come intellettuale e come agitatrice. Tira su quattro figlie facendo tutto il giorno lavori che non valorizzano certo il suo talento, e intanto si batte per un mondo in cui sia vivere con pienezza la maternità sia avere un lavoro interessante e soddisfacente siano diritti garantiti per le donne. La società, ritiene, ne sarà beneficiata, così come la cultura, perché – sono parole sue – «una nuova e complessa ricchezza entrerà in letteratura».
Di questa ricchezza, di questa complessità è intessuta ogni parola di Yonnondio. Tillie Olsen riprende il lavoro sul romanzo trent’anni dopo averne scritto le prime pagine, dopo averlo ritrovato quasi per caso, e lo pubblica come fosse un reperto, un oggetto archeologico che viene da un’altra epoca: è il 1974, e il titolo con cui esce è infatti Yonnondio: from the Thirties [‘Yonnondio: dagli anni Trenta’]. Nel frattempo, Olsen ha potuto riprendere a scrivere: quando la sua ultima figlia è in età scolare, verso la metà degli anni Cinquanta, si iscrive a un corso di scrittura creativa all’università di San Francisco e, poco dopo, nonostante non abbia i titoli per essere ammessa, anche Stanford le apre le sue porte. Escono in quel periodo i suoi racconti, che Joan Carol Oates definisce fondamentali, commoventi – sempre Oates sostiene che Tillie Olsen è un’autrice alla quale bisogna guardare «con riverenza», perché il rispetto non è sufficiente.
Dunque, ecco Yonnondio: un libro in cui la storia dell’America e quella dell’autrice si tessono inscindibilmente, un romanzo in cui la quotidianità è quasi una formula magica nella polvere di giorni complessi e duri, e la povertà non ha nulla di epico o mitologizzabile. Il tempo che passa è un gioco su una scacchiera, tra le miniere del Wyoming e le fattorie del Nebraska, tra paesaggi sperduti e grandi città, la lotta contro le disuguaglianze si incarna nella voce di Anna, protagonista insieme alla figlia Mazie, che affronta fame e ingiustizie senza mai rinunciare a una dimensione sognante e perfino visionaria. «Non si può andare avanti così, a subire come un cane. Non si può, Anna» – si chiude così il quarto capitolo di questo libro in cui il riscatto non è un’epica ma una resistenza quotidiana per non soccombere al buio, alla stanchezza, al tanfo della miseria, quel tanfo che fa da promemoria, che ricorda: «Qui comando io». Almeno finché non arriverà qualcuno, o meglio qualcuna, a non arretrare e riscrivere la storia.
(La Stampa – TuttoLibri, 3 gennaio 2026)
Che cosa si scateni, quando chi scrive fa i conti con la madre, è una faccenda che resta certo non inspiegabile ma sempre un po’ sbalorditiva. È un fatto che quando uno scrittore, o una scrittrice, comincia a battere i polpastrelli sul materno, dalle pagine divampano incendi, la scrittura si assottiglia, la poesia comincia a soffiare forte tra le righe. Metteteci i nomi che credete, Gadda e La cognizione del dolore, Simone De Beauvoir e la sua Una morte dolcissima, i versi purissimi di Supplica a mia madre di Pasolini – per restare tra i morti. È come se le parole, al momento di confrontarsi con l’origine, cambiassero di natura, e andassero ad agganciare non solo un arcaico di specie – il tentativo e la necessità di sopravvivere alla morte – ma anche il più umano degli istinti. E dunque non soltanto il bisogno di protezione, ma anche il più viscerale desiderio, e il bisogno disperatissimo, di essere amati fino alla fine. Quando Pasolini, preso a bastonate sul litorale di Ostia, grida «Mamma!» nella notte, tutto questo confluisce nella voce. Come se la parola stessa, che sia scritta su un foglio oppure pronunciata, contenesse già dentro, incastonato, il pianto.
Dire che Edouard Louis – di cui ora esce per la Nave di Teseo Monique evade – ha dedicato un’opera intera alla madre non è corretto ma non va nemmeno troppo lontano dal vero. Quando esordì con Per farla finita con Eddy Bellegueule, nel 2014, aveva ventidue anni, e quel libro fu un piccolo tornado, tradotto e letto avidamente in tutto il mondo. Era la storia di un figlio che si strappava il nome – letteralmente – da dentro la tagliola: la propria storia familiare, la violenza vissuta in casa, era tale da offrirgli come uscita di sicurezza soltanto un gesto. Quello di rimettere all’anagrafe il cognome – Bellegueule – e scegliersene uno non solo per la vita ma da mettere come un sigillo di liberazione sulla copertina. Optare per Edouard Louis, cioè, come uno scandaloso atto di autodeterminazione. Il che però significava anche strappare, dilaniandolo, il cordone – pur fantasma – che lo univa alla madre.
Monique evade (traduzione di Annalisa Romani) è per Edouard Louis quell’opera unica, quella fiammata, che il nome della madre scatena nel figlio che ne scrive. Non lo dico per affermare che si tratta del suo libro migliore né d’altra parte è il solo in cui la madre compaia. Fa anzi il paio, e ne è la prosecuzione, di quel Lotte e metamorfosi di una donna, che Edouard Louis pubblicò meno di cinque anni fa, in cui raccontava, tra le altre cose, il tentativo di fuga della madre dal marito per salvarsi da una violenza che era insieme personale e di classe: dall’uomo sotto il cui dominio viveva, dalla classe operaia cui appartenevano. Al pari di quello, e di altri – penso a Chi ha ucciso mio padre – c’è una questione centrale per Louis, e cioè il tentativo di scavare dentro le ragioni di una sconfitta. C’è sì un dolore privato nella storia di una famiglia che va in pezzi e di una sottomissione inaccettabile al maschile. Ma è inscindibile dalla violenza di classe, dalla dittatura del denaro.
Non è un caso se al centro di questa storia di fuga – di evasione, come da una detenzione – ci sia proprio, più o meno esplicitato, il denaro. Monique fugge dall’uomo con cui è andata a vivere dopo la fuga dal marito. Si è trasferita a Parigi dalla provincia con l’illusione di una vita migliore, per poi ritrovarsi in una replica grottesca della vita precedente. Nella trappola di un uomo violento, in cui la mortificazione era l’unico strumento di un potere tanto totalitario quanto di cartapesta perché tenuto da un uomo da poco. Aiutare la madre a fuggire – da Atene, a distanza, con l’unico aiuto delle videochiamate e degli amici da delegare – è l’atto che innesca la combustione di questo libro così breve e incalzante. Domandarsi il come mai, pur potendo, sia poi così difficile la fuga per una donna, è una delle domande pulsanti, impellenti direi, di questo romanzo. Il denaro – la sottomissione economica – è una delle risposte: «Ci sono ovviamente altri fattori che rendono la fuga impossibile o impensabile, l’abitudine, la paura di una reazione violenta, ma proprio per questo: i soldi non potrebbero dare la sicurezza necessaria a superare quei fattori di paralisi e di rinuncia?». Ovvero: «Sarebbe possibile stabilire qualcosa come un prezzo per la libertà».
Se scrivere della madre è stato prima un istinto – di salvezza e letterario, senza che in fondo vi sia differenza tra i due –, in Monique evade la posta è ancora più alta. Perché è la stessa scrittura che sale sulla bilancia, che stabilisce il prezzo di un gesto. Furiosa con il figlio ai tempi della pubblicazione del primo romanzo, per aver rivelato al mondo la storia di una violenza destinata a restare silenziata tra le mura di casa, ora la madre gli chiede aiuto. Per farlo, sa che deve varcare lei stessa la soglia di casa per entrare – per quanto questo possa suonare paradossale – dentro un libro, dentro la letteratura. Per farsi aiutare dal vero di una versione differente eppure possibile di sé – in quanto donna e in quanto madre. Il figlio la aiuta a fuggire, e lei ce la fa. E se ce la fa è anche perché sa che questa sarà una storia per tante e per tanti, che attraverso la letteratura diventerà una faccenda politica. «Grazie a lei – scrive Edouard Louis – ho scoperto il piacere di scrivere al servizio di un altro, di un’altra. Il libro che state leggendo è, in un certo senso, il risultato di un ordine di mia madre».
(La Stampa -TuttoLibri, 3 gennaio 2026)
L’origine femminile della sua grandezza
Negli anni in cui Jane Austen diventava una somma scrittrice di lingua inglese, si ricava dalle sue lettere che il suo alimento quotidiano era costituito dalla narrativa femminile del suo tempo. Leggeva Harriet Burney, Jane West, Anna Maria Porter, Anne Grant, Ann Radcliffe, Laetitia Matilda Hawkins, Elisabeth Hamilton, Helen Maria Williams…
La disparità fra Jane Austen e queste autrici è così grande da non lasciare dubbi su come esse abbiano potuto aiutarla. Erano come lei donne che scrivevano e pubblicavano. Per lei rappresentavano una strada aperta e un confronto utile nella sua ricerca di mettere in parola la realtà così come si presentava a lei donna. Non cercò un modello fra i pochi scrittori che conosceva, come il suo amato Samuel Johnson o il celebre Walter Scott. Preferì le scrittrici perché con queste aveva la rispondenza più elementare, ai livelli di realtà dove il grande artista, donna o uomo, lavora ed eccelle. Il risultato saranno sette romanzi perfetti che fanno di Jane Austen una maestra nella prosa inglese e nel romanzo moderno.
Ciò nonostante nella nostra società ai nostri giorni una donna può arrivare ai gradi più alti dell’istruzione o ai compiti più impegnativi, quasi in ogni campo, senza sapere della maniera in cui Jane Austen è diventata così grande nel suo campo. Senza sapere cioè quale vigore mentale una donna possa ricavare dalla frequentazione delle sue simili.
(Libreria delle donne di Milano, Non credere di avere dei diritti, Rosenberg & Sellier,1987)
«L’abolizionismo non chiede un vuoto, ma costruisce una trama di presenze e una cultura della responsabilità, senza confondere la giustizia con la reclusione né la protezione con la sorveglianza». Lo scrive Valeria Verdolini, ricercatrice, sociologa del diritto e attivista. Verdolini è anche presidente di Antigone Lombardia e autrice di saggi che intrecciano esperienza sul campo e riflessione teorica. Dopo L’istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia (Carocci), frutto del lungo impegno con l’associazione Antigone, Verdolini torna con Abolire l’impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà (pp. 240, ADDeditore 2025, € 17,10), un libro che non parla solo di carcere, anche se il tema resta rilevante: «Non si abbandonano i grandi amori» dice ridendo.
Il saggio è il risultato di anni di studio, letture, docenza e confronto diretto con le istituzioni e le comunità, una riflessione lucida e stimolante sulle pratiche della violenza, sulle istituzioni che le legittimano e sugli antidoti possibili, che si costruiscono insieme, come comunità. In questa intervista, Verdolini ci guida attraverso i concetti di abolizionismo, deistituzionalizzazione e realismo magico, esplorando i legami tra potere, istituzioni e la vita concreta delle persone, dentro e fuori dai luoghi di detenzione.
Partirei dalla fine: e cioè dalla bibliografia ricchissima e variegata che nutre e interroga le pagine di Abolire l’impossibile. Questo libro è frutto dei tuoi studi multidisciplinari e degli anni di docenza universitaria?
Sì, è così: una sintesi del mio lavoro accademico e del mio impegno da attivista. Ho tenuto per quasi dieci anni un corso universitario sulla disuguaglianza, e prima di occuparmi di carcere ho indagato i confini: su questo tema ho scritto articoli accademici e ho contribuito alla realizzazione di un documentario che seguiva sette migranti nel loro percorso attraverso il confine. Quanto al femminismo, è una compagnia di lunga data: fin dal liceo, grazie a professoresse che ci facevano leggere il pensiero della differenza, ho approfondito autrici come Carla Lonzi, Lia Cigarini e Adriana Cavarero; poi, all’università, mi sono confrontata con il femminismo giuridico.
In generale, tutto ciò che si trova nel libro nasce dall’intreccio di percorsi diversi: l’idea era anche trasformare un sapere accademico in un sapere politico, radicato nella realtà sociale.
Quando ho terminato il mio precedente saggio, L’istituzione reietta, avevo già constatato che il carcere non funziona e non realizza ciò che dichiara di fare. Questa constatazione ha posto una domanda: «Come possiamo affrontare questa situazione? Dove collocare il cambiamento?». Volevo ampliare lo sguardo e pormi interrogativi più ambiziosi. In questo percorso si sono intrecciati diversi stimoli: avevo scritto l’introduzione al libro Abolire le prigioni di Angela Davis e mi ero confrontata con le esperienze basagliane in Brasile. Si tratta di due percorsi paralleli, diversi ma con punti in comune: da un lato l’abolizione delle prigioni, dall’altro il percorso di deistituzionalizzazione. Gradualmente ho provato a mettere ordine, distinguendo tra abolizioni riuscite e quelle che definisco “possibili” o “impossibili”.
Il libro ha una struttura molto originale. In particolare, ci sono due parti dove si elencano manifestazioni delle strutture violente della nostra società. Le chiami “affioramenti” e “detriti”. Un affioramento è per esempio l’uccisione del diciottenne Federico Aldrovandi per mano di quattro agenti di polizia nel 2005. Un detrito è l’omicidio di Soumaila Sacko, bracciante nei campi di Gioia Tauro e sindacalista, colpito da un colpo di fucile mentre recupera lamiere per rinforzare le baracche del campo di San Ferdinando. L’omicida si giustifica dicendo di proteggere la proprietà privata; il processo non tratta la matrice razziale. Cosa connota gli affioramenti e cosa i detriti?
All’inizio avevo previsto solo gli “affioramenti”, immaginando due cicli dedicati a ciò che emerge in superficie: come la punta di un iceberg, ne vedi solo una parte, mentre tutto il resto rimane sommerso. L’idea era mostrare le forme manifeste della violenza, quei momenti in cui la violenza eccede la dimensione istituzionale, diventa visibile, scandalosa. Per questo avevo scelto casi che attraversano tempi e luoghi diversi, ma che riguardano sempre le tre grandi istituzioni del controllo: carcere, confine e polizia.
Poi, però, mi è sembrato che la seconda parte del libro avesse bisogno di un registro differente. Ricordo che stavo camminando sulla spiaggia quando ho pensato ai “detriti”: residui di strutture molto più antiche, ormai solidificate e cristallizzate. A differenza della radicalità esplosiva degli affioramenti, i detriti – pur contenendo spesso una violenza altrettanto forte – sono episodi che si sono sedimentati nel tempo e nello spazio, che vengono da lontano e mantengono una continuità con storie passate.
Per questo hanno caratteristiche diverse: sono i resti di strutture che, anche abolendo le istituzioni, continuerebbero comunque a esistere in qualche forma.
Il tuo libro mostra con molta chiarezza che abolire un’istituzione violenta non significa necessariamente riuscire ad eliminare la violenza su cui quell’istituzione era fondata. La schiavitù è stata formalmente abolita, eppure sappiamo che continua a esistere in molte parti del mondo; i manicomi sono stati chiusi, ma sopravvivono forme di internamento e mortificazione per ragioni di salute mentale.
Il punto che cerco di sviluppare è questo: abolire un’istituzione violenta, di per sé, non basta. Se non si interviene anche sulle strutture culturali e politiche che legittimano la separazione, il controllo e il contenimento, quella stessa logica troverà nuovi modi per manifestarsi.
Nella letteratura statunitense è spiegato molto chiaramente: l’abolizione della schiavitù non ha eliminato i meccanismi di segregazione, che si sono trasformati nel ghetto e nel ricorso sistematico all’incarcerazione. E quando anche le leggi Jim Crow e le norme sulla segregazione razziale sono state superate, altre forme di esclusione hanno continuato a operare. In altre parole, puoi abolire singoli dispositivi, ma se non affronti le ragioni culturali e politiche che producono il bisogno di separare qualcuno da una comunità, quella spinta riemergerà altrove – a volte in forme più sottili, altre volte in modo evidente.
Lo stesso discorso vale per i manicomi. La legge 180 prevedeva non solo l’abolizione dell’istituzione manicomiale, ma un ripensamento collettivo del modo in cui una comunità si fa carico della sofferenza, insieme a una riorganizzazione territoriale della cura e della sanità pubblica. Il fatto che questa trasformazione culturale e politica non sia stata pienamente realizzata – non certo per volontà dei suoi promotori – ha lasciato nella società una domanda “manicomiale” che non è scomparsa.
Così, anche se sono stati compiuti passi avanti, un residuo di quella logica sopravvive: prima negli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari), rimasti nonostante la chiusura dei manicomi, poi – con la loro abolizione – nell’uso del carcere come luogo che finisce per raccogliere forme di sofferenza psichiatrica.
Le rivoluzioni di questa portata avvengono perché la società, in quel momento, è pronta a compiere un salto o possono invece esplodere prima che la maturazione sociale sia avvenuta, sollecitandola?
Diciamo che qui non è semplice capire cosa venga prima. Sicuramente deve esistere un contesto in cui certe trasformazioni siano almeno pensabili. E quel contesto, negli anni in cui nasce l’esperienza triestina, c’era: le mobilitazioni degli anni Sessanta e dei primi Settanta, l’eredità del ’68, i giovani studenti di medicina che decidono di raggiungere Basaglia a Trieste… Insomma, quella di Basaglia non era una voce isolata.
Allo stesso tempo, però, è vero anche il contrario: a volte bisogna rischiare e andare oltre ciò che sembra possibile, buttare il cuore oltre l’ostacolo e vedere cosa accade quando si apre una finestra. È un atto di coraggio.
Quando Basaglia e i suoi parlano di “utopia della realtà”, dicono esattamente questo: rendere possibile nel presente qualcosa che fino a un attimo prima sembrava soltanto immaginabile.
C’è una frase di Mariame Kaba, che torna più di una volta nel tuo libro: «la speranza è disciplina». Come si difende la disciplina della speranza dai continui attacchi che le vengono inferti?
Quando Mariame Kaba dice che «la speranza è disciplina», invita a perseverare anche quando tutto sembra remare contro. Significa continuare a credere nella possibilità del cambiamento anche quando appare impossibile, anche quando è faticoso, anche quando vincono forze politiche autoritarie o quando i movimenti sembrano indeboliti o anacronistici. La disciplina della speranza è, in fondo, la scelta di non demordere.
C’è poi un altro aspetto: la speranza non va intesa solo come entusiasmo ottimistico o slancio emotivo momentaneo. Deve diventare un metodo, una pratica politica fatta certo di passione, ma soprattutto di costanza. È il modo con cui si porta avanti un’idea trasformativa, il modo in cui si pensa e si costruisce la possibilità di un cambiamento. Per questo, nel libro, insisto sul fatto che l’abolizione non è un fine ma una pratica. In termini molto semplici, l’abolizionismo è un metodo perché implica credere che possa esistere un “dopo” diverso dal presente, un tempo possibile alternativo a quello che viviamo. Non si tratta di immaginare un’utopia come un futuro perfetto da realizzare, ma di aprire spazi del possibile nel qui e ora.
Pensi che nella lotta contro le strutture e le pratiche della violenza esista un ordine di priorità, oppure tutto è inevitabilmente interconnesso?
Credo che le cose possano procedere insieme, perché sono chiaramente intrecciate. Però, se dovessi indicare un punto da cui partire, direi il confine. E infatti, nel libro, mettendo al centro il Mediterraneo, dichiaro questa scelta. Il confine è uno degli spazi dove la violenza è più intensa e, allo stesso tempo, è strettamente legato sia alla polizia sia al carcere.
Da un lato, abbiamo un carcere sovraffollato di persone straniere, e spesso la loro presenza lì è effetto diretto della violenza del confine. Dall’altro, molte pratiche di discriminazione e profiling da parte della polizia derivano proprio dalla logica del confine. E non intendo solo il confine fisico, ma il confine come processo di “bordering”: il meccanismo che porta a vedere nell’altro qualcuno da separare, controllare, respingere.
Il confine, inoltre, conserva al suo interno una continuità con la dimensione coloniale: mantiene le stesse matrici e le stesse forme che hanno attraversato la storia delle relazioni tra Nord e Sud del mondo, le stesse che erano alla base dell’invenzione di istituzioni come la schiavitù. Quando il colonialismo formale finisce, ci troviamo davanti alla sfida di fare i conti con quella prossimità e con quelle gerarchie costruite nel tempo, forme di subordinazione differenziata. Chi si muove nel mondo immaginando di potersi spostare liberamente si scontra con l’impossibilità imposta dal confine, che diventa un modo per mantenere in vita quelle stesse strutture di oppressione, ingiustizia e disuguaglianza.
A un certo punto del libro inviti a interrogarsi su quanto i nostri desideri possano trasformarsi in gabbie per quelli degli altri. Allora mi chiedo: se consideriamo l’“Occidente” come la sede sociale del potere – economico, storico, prodotto di privilegi sedimentati – è davvero possibile che generi desideri che non si traducano, almeno in parte, in forme di subordinazione per qualcun altro?
Dipende da come li pensiamo: i desideri vanno ripensati. Ed è qui che entrano in gioco, da una parte, l’immaginazione e ciò che nel libro chiamo realismo magico, e dall’altra la necessità di dare forma a modalità di convivenza che non si fondino su meccanismi costanti di sopraffazione. Il primo passo, però, è esserne consapevoli.
Le strutture culturali dell’oppressione funzionano proprio così: rendono naturale ciò che è artificiale, fanno apparire come eterne – vedi le montagne o gli alberi – dinamiche che invece sono culturalmente e storicamente costruite. Per questo è fondamentale interrogarsi su come tutto questo ci riguarda. La migrazione, per esempio, è stata spesso percepita come qualcosa che non ci tocca, quando invece ci riguarda eccome, così come ci riguardano molti altri processi che tendiamo a considerare esterni e dunque estranei.
Una volta riconosciuto che ci riguardano, il passo successivo è chiedersi come vogliamo starci dentro. E poi ricordarsi che le persone non sono necessariamente mosse da logiche di sopraffazione o indifferenza: lo abbiamo visto, per esempio, nell’ondata di solidarietà verso ciò che accadeva a Gaza. Quella spinta nasceva da un senso di empatia e dalla domanda «Che cosa c’entra con me?», che dimostra come sia possibile attivarsi anche per realtà che ci toccano indirettamente.
«La speranza non va intesa solo come entusiasmo ottimistico o slancio emotivo momentaneo. Deve diventare un metodo, una pratica politica fatta certo di passione, ma soprattutto di costanza. È il modo con cui si porta avanti un’idea trasformativa, il modo in cui si pensa e si costruisce la possibilità di un cambiamento».
Nel libro Perché ero ragazzo (Sellerio), Alaa Faraj, migrante libico, racconta la sua incarcerazione ingiusta perché accusato di essere uno scafista. Dell’Italia, Faraj conosce solo il carcere, e dentro le mura riesce ad attivare quello che chiamiamo “percorso trattamentale”: studia, segue corsi, impara l’italiano, scrive un libro. La sua vicenda – eccezionale, ma non isolata nella geografia carceraria contemporanea – mi ha fatto pensare a quando scrivi che il carcere ha assorbito la sofferenza sociale, diventando una forma di welfare minimo per chi è stato espulso. Avevo trovato un ragionamento simile in Prison Lives Matter (Eleuthera), dove Francesca Cerbini osserva che molte persone che vivono condizioni di marginalità accedono per la prima volta a determinati diritti – istruzione, sanità, percorsi formativi – proprio quando entrano in carcere, cioè nel momento in cui vengono private della libertà. È come se quello fosse il prezzo da pagare per avere accesso a un minimo di welfare.
Io questo fenomeno tendo a guardarlo dall’altra parte: il confine agisce come un dispositivo di inclusione differenziale. Proprio perché funziona così, prevede un accesso minimo – o addirittura nullo – ai diritti a seconda della tua capacità di rispondere alle richieste del mercato del lavoro, principalmente.
Detto questo, non avrei alcun dubbio nel dire che una libertà imperfetta è sempre meglio del carcere. Fuori, un accesso ai diritti è possibile: ci sono scuole di italiano, centri di formazione, percorsi di accoglienza. Il problema è che spesso la vera marginalità fatica a essere intercettata. Nel caso specifico di Faraj parliamo di una persona con risorse personali e relazionali importanti, e anche con un buon livello di istruzione. Questo gli permette di individuare strategie adattive quando può e dove può. Quando invece parlo di “welfare minimo di sopravvivenza” mi riferisco alle persone che non riescono ad attivare nulla perché sono troppo vulnerabili. Ed è lì che si entra in una dimensione quasi necropolitica.
Cioè?
Cioè una situazione in cui lo Stato non si fa davvero carico di queste persone, e le forme di gestione passano attraverso il carcere, che – rispetto alla strada – rappresenta una forma “migliore” di sopravvivenza. Penso a una donna che ho intervistato qualche tempo fa: era uscita dal carcere perché doveva fare la chemioterapia per un tumore, e mi disse che per fortuna era riuscita a ottenere una casa popolare, altrimenti avrebbe dovuto vivere per strada. E non voleva morire per strada. Ecco, penso a questa traiettoria: persone per cui il carcere diventa la prima casa, o comunque un luogo più sicuro della strada.
C’è un passaggio in cui scrivi che Basaglia ha potuto abolire il manicomio non da una posizione di assenza di potere, ma grazie al potere che aveva. Era infatti stato nominato direttore del manicomio di Gorizia. È qualcosa di ovvio, ma non ci avevo mai riflettuto in modo così netto. Ti chiedo quindi se il cambiamento passa più dall’interno o dall’esterno delle istituzioni?
Io uso il termine “abolizionismo” anche per il manicomio, ma va detto che i basagliani non lo usavano. Loro parlavano di “deistituzionalizzazione”. L’idea era che tanto la struttura dell’ospedale quanto gli operatori dovessero continuare a esistere, ma che cambiasse radicalmente la relazione di cura. Per questo il primo lavoro, politico e culturale, era proprio con gli operatori. Lo spiegano bene in Crimini di pace: occorre ripensare il modo di lavorare.
Loro parlano di un doppio movimento: hanno aperto le porte del manicomio, quindi il “dentro” è uscito fuori, ma era necessario anche che il “fuori” entrasse dentro, cioè che ci fosse una relazione più univoca tra il contesto sociale, la città e l’istituzione.
In sintesi: le istituzioni producono separazione. Se vuoi deistituzionalizzare o abolire, oltre al cambiamento normativo devi aprire l’istituzione, far cadere il muro della separazione e portare fuori ciò che sta dentro. Ma serve anche il movimento inverso: portare dentro ciò che sta fuori – relazioni, legami sociali, dimensione politica. Deve esserci una compenetrazione molto più forte tra società e soggetti istituzionalizzati. E questo vale anche per il carcere. Possiamo immaginare di “portare fuori” il carcere: molte persone già oggi scontano la pena in misure alternative, sono circa 90.000. Quindi la pena non è solo detenzione. Ma per deistituzionalizzare davvero il carcere serve immaginare una permeabilità totale tra interno ed esterno, dove ciò che accade nella società libera possa entrare dentro. Ed è esattamente ciò che oggi fatica ad accadere.
Questo mi fa pensare a discussioni che ho avuto con persone di ambienti anarchici e abolizionisti, per le quali qualsiasi forma di dialogo con l’istituzione carceraria sarebbe inaccettabile – anche quella necessaria per introdurre progetti, laboratori o spazi di dignità – perché l’istituzione è di per sé violenta e va abolita. Obbiettavo che intanto l’istituzione esiste e le persone ci vivono dentro. Come stare in questo “frattempo”?
Per me l’abolizionismo può anche essere pensato “da dentro”. Premesso che non sono anarchica – lo scrivo chiaramente anche nel libro, alla fine: non arrivo all’abolizione dello Stato né la desidero – io credo nello svuotamento delle funzioni istituzionali e nell’immaginare altre istituzioni possibili. Questo è il punto di partenza.
Il secondo aspetto è che arrivo all’abolizionismo partendo da un riformismo pratico. Ho sempre fatto sportelli, attività concrete dall’interno. In molti casi mi è sembrato che l’istituzione non solo non collaborasse, ma che fosse nociva: non rieduca, non migliora le prospettive di vita, non riduce l’aggressività, anzi spesso fa il contrario.
Detto questo, penso che non ci sia una contraddizione tra lavorare quotidianamente per migliorare le condizioni di chi è dentro e immaginare l’abolizione dell’istituzione. Il mio punto non è legittimare l’istituzione in sé, ma occuparmi di come stanno le persone dentro: ogni strumento utile a questo scopo è più che benvenuto.
Rimane poi la questione politica: quelle istituzioni sono nate per applicare criteri di separazione sociale. Io sono contraria a quel meccanismo e credo che vada abolito, sostituendolo con altri strumenti di gestione della devianza e dei conflitti sociali. Se tutto questo va a scapito di una certa coerenza ideologica, va bene così.
Mi sembra una perfetta conclusione.
Il punto centrale è come stanno le persone e come possano stare in una prospettiva futura. Sul medio periodo ha senso fare tutto ciò che è possibile: anche tutelare un solo diritto in più rappresenta comunque un risultato importante. Allo stesso tempo, è fondamentale riflettere sul senso delle azioni, sul perché le compiamo e sull’orizzonte a cui guardiamo. E questo orizzonte è quello in cui possiamo liberarci dalla necessità del carcere e delle altre forme di istituzionalizzazione della violenza.
(Lucy – Sulla Cultura, 19 dicembre 2025)
da il manifesto
Rosa Luxemburg, nata nel 1871 nella Polonia russa in una colta famiglia ebrea, si forma in un tessuto culturale composito e si afferma precocemente come teorica marxista. Costretta all’esilio, svolge in Germania un’intensa attività politica, giornalistica e teorica all’interno della socialdemocrazia. A partire dal 1904 subisce numerose incarcerazioni, che si intensificano tra il 1915 e il 1918. Trascorre quaranta mesi in carcere come conseguenza della sua opposizione alla guerra, sostenuta invece dal suo stesso partito con il voto ai crediti bellici nell’agosto del 1914; anche dalla prigione continua tuttavia a intervenire nell’azione politica contro il conflitto, prima attorno alla rivista Die Internationale e poi nella Lega di Spartaco. Mantiene una posizione al contempo critica e autonoma che, pur nel sostegno alla Rivoluzione russa dell’ottobre 1917, la porta a dissentire da Lenin e dai bolscevichi su questioni decisive come la politica agraria e, soprattutto, la tendenza del partito a una direzione autoritaria.
Ritroviamo alcune delle lettere della sua prigionia in Un ardente desiderio di primavera. Erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere (pp. 184, euro 20), un volume di grande bellezza edito da Casagrande, curato e tradotto da Danilo Baratti e Patrizia Candolfi. Le lettere in questione, venti, si collocano nell’intervallo tra il 1914 e il 1918 e sono scritte dalle prigioni in cui Rosa Luxemburg era detenuta.
Il 16 febbraio 1917, dalla prigione di Wronki (nell’allora Prussia) scrive a Mathilde Wurm, Tilde, militante socialdemocratica tedesca: «Oh, questo sublime silenzio dell’infinito: mi sento a casa mia in tutto il mondo, ovunque ci siano nuvole e uccelli e lacrime umane. Ieri sera c’erano delle meravigliose nuvole rosa sopra il muro della mia fortezza. Stavo davanti all’inferriata e ho recitato per me sola la mia poesia preferita di Mörike».
Nelle pagine, la natura ritorna incessantemente come respiro necessario: seguendo il mutare del cielo oltre le sbarre, Luxemburg accoglie tra le mani le erbe del cortile e le affida alla pazienza di un erbario. Così, mentre la storia precipita, il ricamo delle erbe custodisce la vita, nei gambi carnosi degli anemoni – disegnati – e dei petali ostinati della pulsatilla comune, i cui colori sembrano rifiorire anche nell’ombra della pagina.
Le piante essiccate e classificate valgono come tracce di un gesto preciso, affine all’attenzione metodica per la salvazione di quei frammenti minimi di natura – cura che attraversa anche la scrittura epistolare della prigionia. In questo lento lavoro di raccolta, di nominazione e di scrittura spicca fra tutti la semplicità blu del fiore della borragine e delle sue foglie, raccolti entrambi il 24 luglio del 1915, in estate, nell’orto nel cortile dell’infermeria del carcere femminile di Berlino.
Accanto alla nomenclatura botanica, nei tratti nella grafia di Rosa Luxemburg, compaiono anche i luoghi di ritrovamento delle erbe e dei fiori. L’erbario diventa così un territorio di resistenza della memoria, custodita a fasi alterne, tra libertà e reclusione, e, al tempo stesso, un linguaggio silenzioso capace di mantenere – contro gli strattoni della storia – una fedeltà al vivente.
Nel volume di Casagrande sono riprodotti sedici fogli tratti dagli erbari, i cui originali sono conservati presso l’Archiwum Akt Nowych di Varsavia: un lavoro che poté prendere forma grazie alla presenza decisiva di alcune donne legate a Rosa Luxemburg da un rapporto di salda amicizia, tra cui la femminista Clara Zetkin (fin dal 1890) – e che proseguì così anche come esito relazionale, forma condivisa di attenzione e cura. Nell’aprile 1917 proprio a Clara, per ringraziarla del mazzo di fiori ricevuto, Rosa scrive: «Ho potuto sistemarmi qui un intero tavolino di fiori e mi sento una regina».
Come indicato nell’introduzione di Baratti e Candolfi, accanto ai pochi fiori e alle erbe spontanee – raccolti nei cortili delle carceri durante le brevi uscite sotto sorveglianza – furono soprattutto le persone a lei vicine a inviarle, per lettera, esemplari essiccati o mazzi di fiori freschi, affidati alla trasformazione lenta della pressatura e della catalogazione. Alle tavole botaniche si intreccia così una corrispondenza intensa, in cui «la cinciallegra in gabbia» dialoga con l’amore per la vita e le sue forme.
Dal carcere Luxemburg riuscì a far circolare numerosi articoli, tra cui il pamphlet La crisi della socialdemocrazia, una dura presa di posizione contro le scelte di Kautsky e della Spd sulla guerra, che verrà tuttavia pubblicato solo clandestinamente nel 1916 con lo pseudonimo di Junius. Nella corrispondenza si colgono i segni della teorica marxista, avvisata e disincantata: sia sui compagni di partito, sia sulle derive romantiche di un ritorno a una Natura idealizzata e necessariamente falsata. A tal proposito, in una lettera del 2 maggio 1917 a Sophie Liebknecht, scrive: «A lei posso ben dirlo tranquillamente: non andrà subito a sospettare un tradimento del socialismo. Lei sa che spero di morire ancora sulla breccia: in una battaglia di strada o in prigione. Ma il mio io più profondo appartiene più alle cinciallegre che ai “compagni”. E non perché io, come tanti politici interiormente falliti, trovi nella natura un rifugio, un luogo di riposo. Al contrario, anche nella natura trovo a ogni passo tanta crudeltà che ne soffro molto. Pensi, ad esempio, che non riesco a togliermi dalla mente il seguente piccolo episodio. La scorsa primavera stavo tornando a casa da una passeggiata nei campi nella mia strada tranquilla e deserta, quando ho notato per terra una piccola macchia scura. Mi sono chinata e ho visto una tragedia silenziosa: un grosso scarabeo stercorario giaceva sul dorso, e cercava invano di difendersi con le zampe, mentre un’orda di minuscole formiche gli brulicava intorno e se lo mangiava ancora vivo!»
Come afferma il botanico Nicola Schoenenberger nel saggio in volume dal titolo Flora carceraria, l’erbario di Rosa Luxemburg mette in luce il valore conoscitivo della presenza delle specie in un luogo preciso: ogni pianta raccolta, datata e conservata, diventa traccia materiale di un luogo e di un momento, una prova silenziosa dell’incontro tra il corpo prigioniero e il mondo vivente. Proprio per questo, i campioni raccolti da Luxemburg nei cortili delle carceri permettono oggi di ricostruire con sorprendente precisione l’ecologia di quegli spazi – secondo una cartografia sensibile dei luoghi della reclusione, in cui la natura conserva memoria della vita che vi è passata, «nei cortili di prigione nei quali era costretta». Si compone dunque, in forme intime e luminose, l’unità profonda tra la combattente e l’umana, in tutte le declinazioni della nostra vulnerabilità. È proprio lì che la forza della teorica e della militante convive con la capacità di stupirsi per un fiore, per ogni erbaccia «che cresce tra le pietre», per una meravigliosa piuma azzurra di una ghiandaia di Südende – per le vibrazioni del vivente che ci circonda e che siamo.
da La Stampa
Non c’è mai lieto fine né conferma di cliché sessisti o eteronormativi. In lei il mondo non esiste come scenario, ma come campo di esperienza
LILIANA RAMPELLO, Un anno con Jane Austen, Editore NERI POZZA Pagine 432
Genere: SAGGISTICA Prezzo 26 €
L’unico ritratto in vita di Jane Austen, nata il 16 dicembre di duecentocinquant’anni fa, è quello eseguito a matita e acquarello intorno al 1810 dall’amata sorella Cassandra. Di solito, si nota la cuffia – la indossava sempre, ha raccontato il nipote – o gli occhi grandi e la bocca sottile. Ma colpiscono anche i riccioli lisciati sulla fronte, in puro stile Regency. Eppure, non sono i singoli dettagli, ma il modo complessivo di occupare lo spazio a creare lo stile “Jane Austen”. Questa piccola figura non particolarmente bella, e silenziosa, che nel medesimo tempo appare distratta e concentrata, sembra avere in testa molte cose, oltre alla cuffia, e ci ispira autorevolezza; pur essendo, anzi proprio perché è e vuol farsi riconoscere come, una donna. Come ha fatto?
Gli occhi sono attenti, ma, anziché cercare il nostro sguardo, sfuggono, cercando un punto fuori campo: vanno oltre. Magari, durante la posa, la scrittrice è rimasta seduta accanto al piccolo tavolo dodecagonale, nell’angolo del salotto dove scriveva, mentre le altre persone di famiglia attraversavano la stanza. In quarantun anni e mezzo di vita (1775-1816) Austen infatti non ha mai avuto un ambiente soltanto suo. Ma, in senso simbolico, lo spazio della narratrice e quello delle sue eroine compongono universi interi. Sono «i mondi di Jane Austen» (come li ha definiti Diego Saglia), territori creativi spaziosi dove, assieme alla finzione, regna l’autoironia di una voce proveniente «by a Lady» (come si leggeva sul frontespizio dei romanzi pubblicati durante la sua vita: tutti anonimi, ma esplicitamente attribuiti a una “Signora”).
Guardando ancora quel ritratto, sono interessanti le braccia in posizione conserta, come a delimitare il corpo, invece di assumere la postura innaturale di tante donne stordite raffigurate nei quadri sette-ottocenteschi. La ragazza con la cuffia, invece, sta ferma, con l’intelligente tranquillità di chi sa di aver mostrato e fatto sentire, con la sua prosa, tre cose che non erano mai esistite prima, e che sono fondamentali per capire la grandezza dei romanzi di Jane Austen.
Le prime due segnano una linea di non ritorno nella storia del romanzo moderno e sono state indicate, tracciando anche una genealogia di riferimento, da Virginia Woolf. Vale a dire: i libri di Austen inventano la voce di una donna, ci fanno sentire come pensa e come parla una donna, sia da scrittrice sia da protagonista di una storia.
In più, la scrittura di Austen fa esistere non solo quelli che Woolf chiama i momenti d’essere, ma anche i momenti di non essere: «gran parte di ogni giornata non la si vive consciamente. Si cammina, si mangia, si vedono cose, si provvede alle nostre incombenze; l’aspirapolvere rotto; il pranzo da ordinare; la nota della spesa per Mabel; il bucato; i pasti da cucinare; i libri da rilegare. Mi venne un po’ di febbre l’altra settimana: quasi tutta la giornata fu non-essere. Una vera scrittrice riesce a rendere entrambi gli stati. Jane Austen secondo me ci riesce», scrive Woolf in Uno schizzo del passato (1939), nella traduzione di Adriana Bottini.
Il terzo punto fondamentale per capire il potere intramontabile di Ragione e sentimento, Orgoglio e Pregiudizio, Mansfield Park, Emma (usciti tra il 1811 e il 1815), Persuasione e Northanger Abbey (entrambi pubblicati nel 1818), è stato illuminato da Liliana Rampello con Sei romanzi perfetti (2014), il lavoro di curatela dei due volumi dei Meridiani Austen (2022-25), e con il suo recente libro pubblicato da Neri Pozza Un anno con Jane Austen, dove si ripercorre il paese di AustenLand come sfogliando un calendario (con un brano per ogni giorno dell’anno), organizzato però secondo un sistema di simmetrie, rimandi e confronti che pare un gioco eppure è assolutamente serio.
Elinor e Marianne Dashwood, Elizabeth Bennet, Fanny Price, Emma Woodhouse, Catherine Morland, Anne Elliot: al centro delle storie e delle avventure di ciascuna di loro – Rampello lo mostra benissimo – Austen mette, come nodo centrale, la felicità individuale. Questa però è intesa non come autorappresentazione romantica, ma come apprendistato personale e sociale alla capacità di guardare e riconoscere i propri bisogni, distinguendoli dalle velleità e scegliendo bene, di conseguenza, o talvolta anche reinventandosi, i punti di partenza e di arrivo della felicità. Qui sta il terzo punto sostanziale dei sei capolavori.
La promessa di felicità progressivamente esaudita del racconto arriva, dunque, con il riconoscimento della differenza tra “orgoglio” e “vanità”, dentro un sistema pieno di ostacoli, divieti culturali e pregiudizi, che molto spesso continueranno a pesare, visto che ci troviamo in un mondo in cui se sei una donna non sfuggi al destino di essere considerata o come una ragazza da marito o come una povera zitella (a meno che tu non sia ricca). Ma sono limiti materiali e sociali che non vanno travestiti, romanzati o accettati come regole naturali. Lo spazio simbolico percorso dalle eroine di Austen, spesso anche ballando, è quello che intercorre tra necessità e libertà: proprio in questo incontro abita la verità del romanzo. Il matrimonio finale varrà da sigillo sociale di questa traiettoria di esperienza, non è l’orizzonte esclusivo della realizzazione di sé. Per questo, che sia un bene o un male, non andremo mai a un ballo – a meno di non partecipare a una rievocazione austeniana – ma da lettrici (o da lettori), continuiamo a sentire l’urgenza di felicità delle sue eroine come una tensione romanzesca e vitale che ci riguarda e ci interessa ancora così tanto.
Ci vorrà un romanzo intero per elaborare e trasformare l’arroganza con cui Darcy, al primo incontro, ha definito Elizabeth «passabile», perché Austen non rende mai attraente e desiderabile la sottomissione delle ragazze a stereotipi sessisti. La forma di romanzo dentro le quali abitano, pensano e parlano le sue protagoniste è quella della novel realista, dove trama, relazioni, ambientazione, e soprattutto punto di vista interno e esterno alle storie sono tutti livelli testuali che fanno esistere il mondo non come scenario e performance, ma come campo di esperienza; anche come occasioni di sogni, se si è giovani, o della felicità di camminare e ruzzolare da un prato, se si è ragazze; ma lo spazio narrato resta costellato da limiti prosaici, per l’appunto, resistenze e confini di classe, di ragazze che non potranno mangiare bene, chiamare un dottore, sposarsi o indossare un abito nuovo se non hanno rendite sufficienti – visto che i patrimoni vanno sempre ai maschi. Anche per questo i dialoghi dei romanzi di Austen sono così originali e importanti: perché i discorsi in società sono, in termini narrativi e drammatici, il riflettore perfetto sia della vita (e dei momenti di non essere di cui parlava Woolf), sia di come le relazioni umane siano luoghi straordinariamente comuni, cioè quotidianamente “parlati” da forme di disciplina e di repressione del desiderio e dei corpi. Se poi si tratta di corpi femminili anche di più, tant’è vero che sarebbe tempo di riconoscere a Austen il merito di aver reinventato il novel non tanto in termini generici, quanto proprio nel senso di novel d’autrice.
Come mostra la fortuna di Austen a partire dal cinema degli anni Novanta ispirato alla sua opera, il fascino pop testimoniato dalle tante forme di reinvenzione di Austen va compreso e accolto come conferma di un modello diventato immortale non solo come stile di scrittura e narrazione, ma anche come intrattenimento e perfino di consolazione. Eppure una precisazione è dovuta.
Leggendo, e spesso ridendo (perché un altro scandalo di Austen è stato quello di essere una scrittrice ironica, come svela così bene anche la ripresa creativa di Bridget Jones), non siamo mai nei territori del romance, inteso, anche nel senso più largo, come storia d’amore a lieto fine, dove incontriamo giovani donne e uomini di successo dai nomi stranieri, che agiscono in luoghi comunemente straordinari, dove tutto è immediatamente possibile e se ci si innamora o si fa sesso si confermano i clichés sessisti e eteronormativi più sfruttati. C’è posto per tutti, ma invocare Austen come modello di riferimento di questo tipo di scritture è un atto di appropriazione o attribuzione culturale e commerciale essenzialmente falso, qualche volta anche violento, e, proprio ispirandoci a Austen, dobbiamo avere il coraggio sorridente di dichiararlo, anche per non fare il gioco di chi continua a recintare Austen sugli scaffali patriarcali della letteratura “femminile”. Spazi scomodissimi, spesso anche imbarazzanti, se consideriamo che Austen è stata amata e imitata dai più grandi scrittori oltre che dalle autrici. L’importante teorico Edward Said l’ha attaccata, usando Mansfield Park come esempio di letteratura tipicamente orientata da uno sguardo coloniale; ma essere uno straordinario intellettuale non lo ha forse preservato dal pregiudizio contenutista, visto che la verità dei testi non va cercata nelle singole frasi, ma nell’esperienza formale complessiva che facciamo di un dialogo, una situazione, un mondo.
I romanzi di Austen – che leggiamo grazie al lavoro di traduttrici straordinarie (Susanna Basso, e recentemente Stella Sacchini e Elisa Bizzotto) – sono pieni di ragazze piene di risorse che talvolta possono anche rovesciarsi in pericolosi difetti: la ragionevolezza di Elinor, in Ragione e sentimento, per esempio, o la superbia di Emma, che crede a tutto quello che pensa, o la fantasia meravigliosa di Catherine, in Northanger Abbey, il romanzo scritto per primo ma pubblicato per ultimo, che si può anche intendere come il libro più bello dedicato alle lettrici, visto che la protagonista è per l’appunto una ragazza che ha letto tanti romanzi e grazie a questa esperienza incontra nuove amiche, e un amore. L’opera di Austen ha due secoli e mezzo, ma è così contemporanea perché parla anche di come la storia del romanzo moderno sia, alla prova dei fatti, una storia di generazioni e generazioni di donne che hanno letto i romanzi. Tre persone su quattro che si presentano alla cassa di una libreria, in Italia, in questo momento, sono donne. Forse anche di più quando acquistano Austen. La Lady immortale con la cuffia guarda e sorride, perché sa chi è, come aveva scritto spiritosamente in una lettera del 1815: «The most uninformed Female who ever dared to be an Authoress»: la donna più ignorante che abbia mai osato essere un’Autrice.
da RivistaStudio
È un libro per certi versi timido, L’uso della foto. Il soggetto di cui si parla sembra sempre altrove, come se volesse negarsi all’obiettivo che cerca di catturarlo, alla penna che si avvicina a descriverlo ma poi non affonda, devia, prende altre strade.
Pubblicato lo scorso mese da L’Orma Editore con traduzione di Lorenzo Flabbi, L’uso della foto è in realtà un libro di vent’anni fa che l’autrice premio Nobel Annie Ernaux ha scritto insieme al giornalista Marc Marie, suo amante per alcuni mesi. È composto da quattordici fotografie scattate fra il marzo del 2003 e il gennaio del 2004, immagini che testimoniano quel che resta dell’amore quando l’amore è stato consumato, la fragile tenerezza degli abiti abbandonati sul pavimento e delle stanze disordinate, buttate all’aria, che nessuno si preoccupa di tenere in ordine quando c’è una passione che divampa e reclama spazio. «Mi capitava spesso», scrive Ernaux in apertura, «sin dall’inizio della nostra relazione, di restare affascinata nel ritrovare al mattino la tavola non sparecchiata della sera prima, le sedie spostate, i vestiti aggrovigliati, buttati a terra alla rinfusa nel fare l’amore. Il paesaggio era ogni volta diverso. Doverlo distruggere, quando ognuno raccoglieva le proprie cose, mi stringeva il cuore. Avevo l’impressione di cancellare l’unica traccia oggettiva del nostro piacere».
Un racconto cristallizzato
Nella poetica di Ernaux la scrittura è un tentativo di illuminare il passato e offrirgli un senso nuovo. Tutti i suoi lavori sono autobiografici, molti si concentrano sugli anni della giovinezza e sono stati scritti a decenni di distanza dai fatti narrati, ma qui manca un elemento cardine: non c’è il filtro della memoria. L’uso della foto è stato scritto in presa diretta, spinto più dall’urgenza di cristallizzare il presente che dal desiderio di osservare con sguardo inedito, ermeneutico, i fatti già trascorsi.
Ciascuna delle quattordici immagini – una selezione operata su una quarantina di fotografie – è corredata da una descrizione di Ernaux e una di Marie, che raccontano cos’è accaduto subito prima e subito dopo, il contesto in cui è stata scattata, le stanze d’albergo, i ristoranti dove avevano appena cenato o la scomodità di certi stivaletti difficili da slacciare, che arrivano a ricordare le loro infanzie, le famiglie d’origine, i grandi magazzini dove era stato acquistato, coi saldi, un reggiseno di pizzo colorato.
L’uso della foto è anche, di fatto, un gioco tra amanti: Ernaux e Marie scrivevano da soli, senza far leggere nulla all’altro e domandandosi spesso «Cosa starà scrivendo di me?». Colgono elementi differenti della medesima scena, e nel tentativo di comporre un’opera unitaria non fanno che esplicitare la distanza irriducibile che sempre resiste fra due esseri umani, anche quando a unirli c’è una passione sbocciata da poco.
Libri politici e discreti
Ernaux ha esplorato spesso il sentimento amoroso. In Passione semplice, Un ragazzo, Perdersi, che a differenza di L’uso della foto non sono affatto libri timidi, Ernaux ausculta i palpiti del proprio cuore, ogni minima angoscia o effimero entusiasmo, e squaderna sotto gli occhi dei lettori la propria radiografia emotiva. Qui, invece, di sentimenti non si parla quasi mai – solo alcuni accenni alla ex compagna di lui, qualche vaga gelosia, niente di più. Questo è un libro che parla di corpi – e noi possiamo solo immaginarli, avviluppati e felici nella cornice esclusa dall’inquadratura, mentre fanno l’amore, perché di fatto non si mostrano mai. Neanche una mano, neppure la rotondità di un fianco. Al loro posto, solo gli indumenti che portano ancora le impronte di chi li abitava poco prima. I vestitini leggeri di lei, o i pantaloni di tessuto grezzo di lui, sono i testimoni più fedeli del momento in cui i corpi, vivi e appassionati, sono esplosi di desiderio: è successo davvero, sembrano dirci le fotografie, questo è quello che resta.
Quei reggiseni svuotati che compaiono spesso in primo piano, all’apice della montagnetta di abiti, rimandano però al vero, nascosto, protagonista del libro: il cancro. Mentre Ernaux scrive, fotografa e si gode la sua storia d’amore con Marie, è infatti in cura per un tumore al seno. Quando i due escono a cena per la prima volta lei glielo dice subito, come se volesse testare la tenuta del suo desiderio, che dovrà essere più forte di tutto, anche del timore della morte. «Ho un cancro», gli dice, e, subito dopo, «Vorrei andare a Venezia con te».
Non c’è retorica nel modo in cui Ernaux e Marie parlano della malattia: «Ti sei fatta venire il cancro solo per poterne scrivere», le dice lui. Il corpo malato non viene taciuto, né edulcorato, si racconta per quello che è: interamente glabro, dall’incarnato cereo, il capo protetto da una parrucca, attraversato da un sistema di tubi e sacche per la chemio, marchiato da un catetere sotto la clavicola, il capezzolo bruciato dalla radioterapia.
Credo che l’aspetto più potente della scrittura di Ernaux sia il fatto di essere profondamente politica senza mai dichiararlo, senza redigere manifesti. È così nella Donna gelata, che di fatto è un’introduzione al femminismo, in Memorie di ragazza, dove si tematizza il consenso, nell’Evento, dove il diritto all’aborto diventa battaglia sociale e di genere, in Una donna e Il posto, che dietro ai racconti sui genitori nascondono una profonda riflessione sull’identità di classe. Nell’Uso della foto è il corpo malato a prendersi lo spazio, un corpo femminile che, segnato dalla malattia ma anche dall’età – quando scrive, Ernaux ha sessantatré anni –, reclama il proprio desiderio, il proprio piacere, con la medesima sicura pacatezza con cui rivendicherebbe l’ossigeno per respirare, o il cibo di cui nutrirsi. Non fa mai chiasso, la scrittura di Ernaux, ma è raro che indietreggi. «In Francia», scrive, «l’11 per cento delle donne ha avuto o ha un cancro al seno. Più di tre milioni di donne. Tre milioni di seni suturati, scannerizzati, marcati da disegni rossi e blu, irradiati, ricostruiti, nascosti sotto camicette e t-shirt, invisibili. Bisognerà pure osare mostrarli un giorno, in effetti. [Scrivere del mio, fa parte di questo svelamento]».
La fotografia come testimonianza
Per André Bazin la fotografia nasce dall’esigenza di sottrarre la vita alla morte conservandone una testimonianza, una traccia luminosa su pellicola che resista allo scorrere del tempo: questa cosa è successa, dicono le fotografie, questa persona è esistita su questa terra. Roland Barthes, dopo di lui, ha invece esplicitato il paradosso intrinseco al medium fotografico. Se da un lato certifica l’esistenza dell’oggetto immortalato, dall’altro rappresenta la prova irrefutabile che quel momento è andato, perduto per sempre, in fin dei conti anch’esso defunto: «Ciò che la fotografia riproduce all’infinito è un evento che non si ripeterà mai più». Ogni scatto è perciò anche un memento mori: attesta la presenza di un pezzo di realtà che porta dentro di sé le condizioni della sua stessa mortalità, che presto o tardi si farà assenza e figura fantasmatica. «È come una perdita che stia guadagnando velocità», scrive Ernaux, «Invece di frenarla, la moltiplicazione delle immagini dà la sensazione di scavarne ancora di più il vuoto».
Nell’Uso della foto l’autrice, con la complicità del suo amante, intreccia un dialogo con la morte – che non si può scrivere, né fotografare – a partire dalla posizione liminare del suo corpo malato e desiderante, che si nega all’obiettivo ed è combattuto tra due istanze: da un lato il pensiero stesso della morte, dall’altro il richiamo inesorabile del piacere. Fra i due, lo spazio della vita che ancora rimane, e che si fa arte: «Se, in una forma o in un’altra, l’ombra del nulla non aleggia sulla scrittura, allora non c’è niente che possa valere davvero all’uso dei viventi».
da il manifesto
Anatomia di una separazione o documento politico sulla relazione tra i sessi, rileggere oggi Vai pure è di una certa attualità. Si tratta del volume che Carla Lonzi prepara e pubblica nel 1980 riportando la sua conversazione in quattro giornate con Pietro Consagra, facendoci entrare dentro il rapporto tra una donna e un uomo. Si erano conosciuti alla metà degli anni Sessanta, Lonzi e Consagra, e a unirli era stata l’arte, ambiente da cui lei decide presto di congedarsi perché non corrispondente alla sua radicalità, ma soprattutto un legame d’amore. Forte, importante, fatto di alleanza e desiderio, soprattutto nei primi anni, non sempre facili, poi di conflitti insuperabili. Uscito per la prima volta nei «Prototipi» delle edizioni di Rivolta Femminile, viene ripubblicato nel 2011 dalle edizioni et.al e ora è nuovamente disponibile per La Tartaruga (pp. 168, euro 19), a cura di Annarosa Buttarelli che ne firma una puntuale postfazione.
A casa di Carla, luogo indicato in quelle 4 giornate del 1980 dal 25 aprile al 9 maggio, registrano ciò che si dicono riportando su carta l’analisi incarnata di una resa dei conti. Per comprendere come arrivano a quel punto si può intanto leggere il diario di Lonzi, Taci, anzi parla (1978, poi 2010 e 2024), in cui «Simone» (cioè Pietro) è tra le sue interlocuzioni significative, se ne possono osservare le mutazioni via via che la scoperta del femminismo diviene inaggirabile indagine di sé, quando l’autocoscienza prosegue e rompe le illusioni, una per una, smantellando inganni, sistemi di potere e inferiorizzazione.
Nel 1973, Lonzi appunta diverse cose proprio nel suo diario rivolgendosi al suo compagno di allora: «Avevo diversi amici, personalità di cui subivo l’influenza, però sono stata saggia e oculata: il cuore, proprio il cuore l’ho dato a te, e era la parte più veritiera. Con te ero più me stessa, tu mi amavi più come ero, gli altri mi mitizzavano di più; o meglio, vedevano solo una parte». Dopo sette anni, la frontalità ormai ineludibile è di due esseri umani nella tensione di osservare l’esaurimento di una esperienza, tra disincanto e allarme.
C’È UNA FOTO, nella copertina di Vai pure, in cui sono seduti ai lati di una scrivania, lui concentrato a leggere qualcosa mentre lei lo guarda. È scomparso il sole caldo di quella volta in cui, nel 1968, è proprio Consagra a fotografare Lonzi. Sono in Texas, a San Antonio, il ritratto di lei ha dietro una costruzione illuminata di una fiera internazionale che le faceva da aureola. Anche questo lo racconta nel diario, quando descrive l’esperienza del suo cancro e della sua operazione proprio negli Stati Uniti.
Cosa accade allora in quel 1980? Anno interessante – ad esempio Adrienne Rich svela i gangli dell’eterosessualità obbligatoria assunta come sistema di potere e sulla scena artistica mondiale, Marina Abramovic e Ulay sperimentano Rest Energy, che li vede in equilibrio precario mentre tendono un arco, sbilanciati sui talloni. Lui tiene la freccia tesa sul petto di lei, basterebbe una frazione di secondo a spaccarle il cuore e in quella eventualità c’è un affidarsi ma pure una disparità di potere maschile su una donna spalancata ed esposta che non cede. Se della performance dei due artisti ricordiamo i suoni dei loro battiti cardiaci, per 4 minuti, di Carla Lonzi e Pietro Consagra l’impressione delle loro 4 giornate è la capacità di sapersi salutare, come accaduto già transitoriamente.
Ora però il clima è definitivo, perché tutto è accaduto, lei davvero gli dice che può andare dopo che si è compresa l’insostenibilità di due mondi opposti, due lingue agli antipodi. Quella di Lonzi, libera, dice, ad esempio, che non è possibile il perdurare di un incontro di due soggetti senza che uno riconosca l’altro interamente e non come presenza accessoria. Anche questa reciprocità, da non confondere con una richiesta di autorizzazione per esistere, è il sottofondo di Vai pure.
Il confronto serrato è su quanto abbiano scelto per le loro esistenze: in Vita mia, l’autobiografia che Pietro Consagra pubblica nel 1980 con Feltrinelli, Lonzi nota quanto lo scultore scambi i processi, i passaggi con le «tappe» mentre lei nel suo Taci, anzi parla, edito la prima volta nel 1978, «si vede cosa è stata per me la tua presenza in quegli anni, dal tuo libro non si vede cosa è stata la mia presenza per te, non c’è proprio».
DUE ORIZZONTI che potrebbero ascriversi nell’ordine di una differenza sessuale al lavoro e in effetti c’è una fatica, un discreto impegno ma infine una irraggiungibilità non più rimediabile. Consagra si lambicca, è a tratti sinceramente incline ma non sostiene l’intransigenza, il nocciolo della questione: le domanda, quindi, perché lei continui a parlare di «un rubacchiamento» mentre quel che solleva Lonzi è ancora una volta, e con semplicità, di un’altra portata. Il tema è che, dice Lonzi, «io trovo astratto, cioè non vero, irreale, tutto questo costruirsi della personalità maschile come un produrre da sé.
Questo produrre da sé non è vero, non esiste. Esiste sempre un rapporto, un dialogo». E fintanto che un dialogo non si pone tra due coscienze, una delle due crede di essere «assoluta», e anche – si potrebbe aggiungere – irrelata. Il diario fa vedere quanto a uno «scatto di coscienza corrisponde un processo che non è prestigioso come lo scatto di coscienza» per segnalare come questo momento «non prestigioso» venga sempre nascosto «ed è quello in cui la donna è presente».
Diversamente, l’uomo di questo salto di coscienza ne fa un salto di cultura, gestendone il profitto. Ancora una volta il meccanismo è della appropriazione, Lonzi lo chiama qui «assorbimento», e del disconoscimento che ne consegue a fronte di un protagonismo maschile.
Sono argomenti che, a quell’altezza, avevano già circolato ampiamente negli scritti di Lonzi e con il gruppo di Rivolta era già intervenuta in più contesti, ad esempio in un documento del 1971, «Assenza della donna dai momenti celebrativi della manifestazione creativa maschile», o anche quello del 1972 «Significato dell’autocoscienza nei gruppi femministi» (riuniti in Sputiamo su Hegel nel 1974, poi 2010 e 2023). Da un lato dunque c’è il protagonista, monologante ed estroflesso nei suoi rapporti sociali e di mantenimento della sua posizione, che non è più l’uomo «in crisi» della metà degli anni Sessanta, dall’altro lato c’è la «massima dilatazione» il cui sfondo, quando Lonzi scrive il diario, è il femminismo e che le ha consentito di porsi «come mito di nessun genere» piuttosto invece come «un’istanza di autenticità e l’altro capisce che o risponde sullo stesso piano o è meglio che stia zitto».
IN «VAI PURE», prima che Carla e Pietro concludano questo loro apprendistato che ha seguito l’amore, la ferita, la fragilità, fanno capolino la sessualità come l’abbraccio. Colpisce inoltre quanto nessuno dei due sia mai grato all’altra bensì vi sia «una esasperazione continua delle posizioni» che diventa, ineluttabilmente, impraticabile. Cruciale il passaggio in cui, parlando della dialettica servo-padrone segnandone la prospettiva marxiana, Carla Lonzi centra un punto piuttosto attuale nei rapporti cosiddetti emancipati (Consagra non sembra ostile alla sua pratica femminista); oggi lo chiameremmo un percorso denso, condiviso nella libertà di una visione del mondo. Ebbene, peccato che: «qui, siccome il rapporto è privato, a due, senza testimoni, bisogna che siano proprio i due interlocutori a mettere giù i punti di coscienza. L’uomo finora ha usufruito di un profitto senza accorgersene, adesso se ne accorge, perché se ne è accorta l’altra. Me ne sono accorta io quindi ti ho portato a dover ammettere che la cosa è così, siccome siamo sul piano della coscienza, e la coscienza vuol dire la verità».
- Sabato 13 dicembre, alla Libreria delle donne di Milano (Via Pietro Calvi, 29) alle ore 18.00, la presentazione di «Vai pure» con Annarosa Buttarelli in dialogo con Francesco Morace.