Da Il Tascabile – «Il letto, mio caro, è tutta la nostra vita. Qui si nasce, qui si ama, qui si muore»: sono le parole della protagonista di un breve racconto di Maupassant del 1882 che s’intitola, per l’appunto, Il letto. La donna, di cui non conosciamo e non conosceremo il nome, è allettata da giorni e descrive così in una lettera al suo amante, l’abate d’Argencé, quel tempo di degenza obbligata:
Mio caro amico, sono malata, soffro veramente, non posso lasciare il letto. La pioggia batte contro i vetri e io me ne sto a fantasticare languidamente al caldo, nel tepore dei piumini. Ho qui un libro che amo e che mi sembra fatto con un poco di me stessa. Devo dirvi quale? No. Mi rimproverereste. Poi, dopo aver letto un po’, mi metto a pensare, e voglio dirvi a cosa. Dato che da tre giorni sono a letto, penso proprio al mio letto, e persino nel sonno continuo a pensarci. Se solo possedessi la penna di Crébillon, scriverei proprio la storia di un letto.
Costretta a trascorrere il suo tempo distesa, la donna fantastica, legge, scrive lettere, pensa. E pensa proprio al giaciglio che la accoglie, e ci pensa così intensamente che perfino mentre dorme il letto – quel letto – diviene il pensiero fisso delle sue giornate. Oh, se solo avesse il talento di un grande scrittore come Crébillon! Ma no, è soltanto una donna, senza nome né (apparentemente) talento. Una donna malata, che pensa al suo letto, mentre è a letto. Quasi cinquant’anni dopo – è il 7 gennaio del 1926 – un’altra donna, con un nome e un talento, scrive una lettera alla sua amante, in quei giorni costretta a letto per una breve malattia: «Solo per chiederti come stai – hai la febbre? 38? 39? 40? Non ti senti bene? Mezzo addormentata sorseggi il tè, mangiucchi una fetta di pane tostato, e poi verso sera ritorni luminosa e remota e irresponsabile distesa nel tuo baldacchino come un minuscolo chicco nel guscio?». L’amante ammalata risponde: «Sei un angelo ad avere scritto. E mi piace il tuo atteggiamento nei confronti della malattia: “luminosa e remota”, quando la maggior parte delle persone avrebbe detto “calda e appiccicaticcia”».
Già, Vita Sackville-West – l’amante ammalata – ha proprio ragione: nessuno più di chi le ha scritto quelle parole, ovvero Virginia Woolf, è capace di raccontare la malattia in modo così diverso, originale, inconsueto. A testimoniarlo, appena qualche giorno dopo quello scambio di lettere, è il breve e indimenticabile saggio On Being Ill, “Dell’essere malati”, pubblicato per la prima volta proprio sul numero del gennaio 1926 della rivista “New Criterion”, diretta da T.S. Eliot. In Dell’essere malati, Woolf riflette – e ci fa riflettere – su come il fatto di essere costretti a letto da una malattia non sia sempre, non sia solo, una sciagura. È anche, più spesso di quanto crediamo, un’occasione. Lo è nel senso etimologico del termine. Se pensiamo alla parola occasio, dal latino ob + cídere, subito ci rendiamo conto che la parola “occasione” porta con sé un movimento di caduta, una parabola discendente. La malattia è un’occasione perché ci ac-cade, “ci cade davanti”. O siamo noi che, andando avanti, ci cadiamo dentro. Eppure questa caduta, avverte Woolf, non è necessariamente un male. Molto spesso, infatti, “cadere ammalati” significa essere costretti a cambiare prospettiva, ad abbandonare la verticalità, a divenire orizzontali. Sdraiati a letto, non più feminae e homines erecti, obbligati a rinunciare alla postura che l’evoluzione, la storia, il mondo, ci chiedono per essere parte attiva del consorzio civile, noi, gli ammalati, i distesi, gli inetti, abbiamo improvvisamente la possibilità di abitare un altro spazio, di guardare qualcosa di diverso. Qualcosa che, in piedi, continuava a sfuggirci e che da sdraiati, invece, ci si rivela.
Con la malattia la simulazione cessa. Appena ci comandano il letto, o sprofondati tra i cuscini in poltrona alziamo i piedi neanche un pollice da terra, smettiamo di essere soldati nell’esercito degli eretti; diventiamo disertori. Loro marciano in battaglia. Noi galleggiamo tra i rami nella corrente; volteggiamo alla rinfusa con le foglie morte sul prato, capaci forse per la prima volta dopo anni di guardarci intorno, o in alto – di guardare, per esempio, il cielo.
Quella che credevamo una disgrazia, la malattia, può diventare, in alcuni casi, uno stato di grazia, una modificazione posturale che, imponendoci di abbandonare le file dell’esercito degli eretti, degli attivi, dei produttivi, ci obbliga (o autorizza) a sostare, a non agire, a osservare. Il cielo, per esempio. «Diventati una foglia, o una margherita, supini, lo sguardo rivolto in alto» – continua Woolf – «scopriamo che il cielo è qualcosa di così diverso, ma così diverso che ne siamo scioccati. Ecco dunque cos’è che da tanto tempo andava avanti senza che lo sapessimo! […] Solo i supini sanno ciò che dopotutto la Natura non si dà affatto la pena di nascondere – che alla fine sarà lei a trionfare».
I supini lo sanno. Sanno ciò che gli eretti dimenticano, tutti presi dalla propria verticalità, dalla propria “rettitudine”, per usare il termine che la filosofa Adriana Cavarero mette al centro del suo saggio Inclinazioni. Critica della rettitudine, proprio per ragionare sulla «centralità della postura verticale, tanto cara all’individuo sovrano e ai suoi sogni di autonomia» e che per la filosofa, come per Woolf, non è che un «patetico abbaglio». Chi si pensa dritto e intero, chi guarda sempre davanti a sé, chi procede senza sosta nell’esercito degli eretti, illudendosi di dominare lo spazio – e dunque il mondo – confortato dal proprio orientamento verticale, (o dalla propria erezione), è completamente fuori strada. Ignaro, o dimentico, «di ciò che dopotutto la Natura non si dà affatto la pena di nascondere – che alla fine sarà lei a trionfare».
Essere orizzontali, per Woolf, significa avere la possibilità di sfuggire a questo abbaglio, a questa fatale dimenticanza. Significa allenare lo sguardo a un’altra prospettiva, una prospettiva eccentrica, fuori dal centro di un’autoreferenzialità che è in realtà miope. A letto, distesi come «una foglia, o una margherita», al cospetto di un cielo che non ricordavano, i supini ritrovano i confini di un corpo vulnerabile e vivo, che patisce, che dipende da un altro, dagli altri, che è in contatto con i propri bisogni, con la propria parzialità. E, insieme, con la propria creatività. Sì, perché è proprio quando siamo distesi, ammalati, che siamo più disponibili a lasciarci attraversare dall’incomprensibile. Spesso, quando siamo in piedi, e in salute – scrive ancora Woolf – «il senso usurpa il ruolo del suono. L’intelligenza domina sui sensi. Ma nella malattia, con la polizia non più in servizio, le parole liberano il loro profumo, sussurrano come fanno le foglie, ci coprono di luci e ombre». Liberi dall’imperativo categorico del dover capire, del dover dare senso e ordine al mondo, affrancati dall’asse verticale della ragione, i supini fantasticano, leggono, scrivono. Proprio come la donna protagonista del racconto di Maupassant. Proprio come Virginia Woolf, che scrive Dell’essere malati subito dopo – o dovremmo dire grazie al fatto – di essere stata costretta a letto per un mese, nell’autunno del 1925.
Quello di Woolf non è certo l’unico caso. Sappiamo bene che la maggior parte della Recherche Proust la scrive a letto. E che è a letto, mentre è ammalato di pleurite, che il grande poeta Attilio Bertolucci compone la sua seconda raccolta di versi, Fuochi in novembre, del 1932. Ed è sempre a letto che, dieci anni prima, nel 1922, Katherine Mansfield, malata di tubercolosi, scrive uno dei suoi racconti più belli e più crudeli: La mosca. Ed è ancora a letto, o addirittura stesa sul pavimento, che Karen Blixen, malata da tempo di sifilide, scrive o detta uno dei suoi capolavori: la raccolta di racconti Capricci del destino, pubblicata nel 1958. Perfino Via col vento, il romanzo di Margaret Mitchell da cui sarà poi tratto il celebre film, nasce in posizione orizzontale: l’autrice inizia a scriverlo proprio perché costretta a letto per settimane a causa della frattura di una caviglia. La storia della letteratura è piena di scrittrici e scrittori orizzontali. Autori e autrici per cui stare a letto, o a terra, o su un divano è non solo la condizione migliore, ma talora l’unica condizione, la condizione necessaria per creare. Edith Warthon, che da ragazzina è solita leggere stesa sul tappeto della biblioteca paterna, da adulta scrive quasi solamente a letto, libera – così dice – dalla dittatura femminile del corsetto, che asfissia qualsiasi slancio creativo. Mark Twain e George Orwell scrivono a letto. William Wordsworth scrive addirittura a letto e al buio… non si sa come. E così Truman Capote, che in una intervista del 1957, dichiara: «Sono uno scrittore assolutamente orizzontale. Se non sono sdraiato a letto o su divano, non riesco a pensare». «Io sono verticale/ ma preferirei essere orizzontale», scrive dal canto suo Sylvia Plath, in una delle sue più celebri poesie, I am vertical.
Io sono verticale
ma preferirei essere orizzontale.
Non sono un albero
con radici nel suolo
succhiante minerali e amore materno
così da poter brillare
di foglie a ogni marzo,
né sono la beltà
di un’aiuola ultradipinta
che susciti grida di meraviglia,
senza sapere che presto
dovrò perdere i miei petali.
Confronto a me,
un albero è immortale
e la cima di un fiore, non alta,
ma più clamorosa:
dell’uno la lunga vita,
dell’altra mi manca l’audacia.
Stasera,
all’infinitesimo lume delle stelle,
alberi e fiori
hanno sparso i loro freddi profumi.
Ci passo in mezzo
ma nessuno di loro ne fa caso.
A volte io penso
che mentre dormo
forse assomiglio a loro
nel modo più perfetto
– con i pensieri andati in nebbia.
Stare sdraiata è per me più naturale.
Allora il cielo ed io
siamo in aperto colloquio,
e sarò utile il giorno
che resto sdraiata per sempre:
finalmente gli alberi mi toccheranno,
i fiori avranno tempo per me.
In questa bellissima poesia, che troppo spesso è stata banalizzata e interpretata solo come uno dei tanti annunci della poeta americana rispetto al suo futuro suicidio, c’è molto altro, c’è ben altro. Anche Plath, come Woolf, si pensa supina, come foglia o margherita, vicina alle radici degli alberi, ai traffici minerali del terreno, ai fili d’erba che guardano le stelle. «Sono verticale / ma preferirei essere orizzontale» non è semplicisticamente il verso-manifesto di chi è vivo ma preferirebbe morire. È il canto di chi sa la richiesta di verticalità che le fa il mondo – la richiesta di assennatezza, appropriatezza, conformità all’esercito degli eretti – la separa da ciò che le è più caro, da ciò che le permette di essere vicina a sé stessa.
Sylvia Plath, come Virginia Woolf, come Truman Capote, come William Wordsworth, come Amelia Rosselli – che in un suo celebre verso tratto da Serie ospedaliera scrive proprio questo: «non staccarsi dalle cose basse scrivendone / supina» – per essere vicina a sé stessa deve disertare. Sottrarsi al traffico quotidiano, rinnegare il negotium, in favore di un otium che non è semplice inerzia, pigrizia, al contrario, è un’inattività attiva, una inoperosità fertile che pesca nel doppio fondo dell’esistenza, nei suoi recessi, nelle sue falde, in tutto ciò che è basso, e perciò stesso in aperto colloquio con l’alto. È dal basso che ci si accorge del cielo. È da stesi che si vedono le nuvole. Nuvole come «isole felici, pecorelle, cavolfiori e pannolini – che si asciugano al sole» (sono versi di Wisława Szymborska, questi). Nuvole come quelle che Marina Cvetaeva vede mentre, distesa a terra nel bosco, sta scrivendo una lettera al giovane letterato Aleksandr Bachrach: «Caro, vi scrivo tra il muschio, nel cielo avanza una enorme, minacciosa nube nera – rilucente. Stavo leggendo la Vostra lettera e di colpo ho avvertito la presenza di qualcosa… Il muschio corto mi punge le braccia, scrivo distesa, se sollevo la testa eccola, lucente». Lucente sul corpo della poeta stesa sulla nuda terra, nell’umidore del muschio, la nuvola avanza e entra nella scrittura, il cielo finisce sulla pagina, la contamina, alimenta, decentrandola dalla sua autrice, che è insieme testimone e cantrice di qualcosa di più grande, di cui è ospite e ospitante, orizzontale e protesa. Il cielo fa così. Preferisce i supini. Visita gli orizzontali. I corpi guasti, stanchi. I corpi in abbandono. Gli inservibili. Come inservibili sono i corpi dei burattini Totò – nel ruolo di Jago – e Ninetto Davoli – in quello di Otello – gettati in una discarica a cielo aperto alla fine del film Che cosa sono le nuvole di Pier Paolo Pasolini.
Otello: Iiiiih, che so’ quelle?
Jago: Quelle sono… sono le nuvole…
Otello: E che so’ le nuvole?
Jago: Mah!
Otello: Quanto so’ belle! Quanto so’ belle!
Jago: Oh, straziante, meravigliosa bellezza del Creato!
Dice così Jago, con la sua faccia verde, che si illumina tutta, proprio quando non ha più un ruolo, quando la pantomima è finita, quando non c’è nessun filo a tenerlo in piedi. Orizzontale, derelitto, incongruo, e per ciò stesso rinato al mondo che lo coglie dall’alto, e che può cogliere perché è in basso. Lì dove la vita accade come una scoperta. Un ritorno. Un mistero.
(*) Sara De Simone ha conseguito un dottorato di ricerca in Letterature comparate alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha tradotto, con Nadia Fusini, “Scrivi sempre a mezzanotte”, il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West (Donzelli, 2019). È vicepresidente dell’Italian Virginia Woolf Society. Ha scritto “Nessuna come lei. Katherine Mansfield e Virginia Woolf: storia di un’amicizia” (Neri Pozza, 2023).
Caro Presidente,
siamo due donne legate da un’amicizia politica più che ventennale. Una di noi vive in Calabria, a Catanzaro, l’altra in Veneto, a Spinea (Venezia). La nostra relazione politica, fatta di scambio, fiducia, stima, affetto e amore per il mondo, ci ha tenute sempre unite, nonostante la distanza geografica. Entrambe ci sentiamo prima di tutto donne e poi cittadine di questo Paese dove siamo nate, cresciute e abbiamo vissuto la nostra vita, restando fedeli a noi stesse. Abbiamo deciso di scriverLe per avere da Lei una risposta a domande che ci siamo poste dopo che ha firmato, senza alcun rilievo, la legge approvata dalla Camera sull’autonomia differenziata. Ci siamo chieste: «Il presidente della Repubblica non è il garante dello Stato e dell’unità nazionale (art. 87 della Costituzione)? Non è dovere dello Stato assicurare a tutte/i le/i cittadine/i uguali diritti (art. 3 della Costituzione)? Lo Stato non ha il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza?» Presidente ritiene che l’autonomia differenziata risponda a questi dettati costituzionali, di cui Lei è il garante? Non siamo due costituzionaliste ma sappiamo leggere la realtà con sapienza femminile, a partire dalla nostra esperienza. Capiamo, per esempio, che quella legge demolirà il tanto o poco di buono che ancora resta del Servizio Sanitario Nazionale, voluto da una donna, la Ministra Tina Anselmi, che aveva come principi fondanti la solidarietà, l’universalismo e la gratuità delle cure per tutte/i, da Nord a Sud. Sappiamo come il primo colpo per indebolire e frantumare quel sistema, come la pandemia da Covid19 ci ha mostrato, l’hanno dato la riforma dell’art. V (n. 3/2001) della Costituzione e l’introduzione in essa del pareggio di bilancio (20.04.2012). L’autonomia differenziata, che dà a ogni regione la possibilità di trattenere e spendere le entrate fiscali esclusivamente all’interno di sé stessa e non più distribuirle a livello nazionale, rilancerà o distruggerà definitivamente quel sistema sanitario? Lei come noi conosce le disuguaglianze tra Nord e Sud, tra la Calabria e il Veneto, il cui presidente Zaia si è già affrettato a chiedere 9 deleghe delle 23 previste, e per la sanità il problema non è garantire alle regioni ricche del Nord una sanità di eccellenza e al Sud i Livelli Essenziali di assistenza (LEP). Noi, come Tina Anselmi, pretendiamo una buona sanità uguale per tutte/i, da Nord a Sud dove, tra tanti disastri e mala politica, non manca la buona sanità. Io l’ho trovata a Catanzaro al Centro oncologico “Ciaccio-De Lellis” dove sono stata curata con professionalità e umanità dal dottore Stefano Molica e dal personale infermieristico. Non ho avuto la necessità di emigrare al Nord, come sono costrette tante/i calabresi. L’autonomia differenziata fermerà l’emigrazione sanitaria o l’aumenterà? Le eccellenze che abbiamo anche nel Sud da chi saranno garantite? I mali che Lei e noi conosciamo della sanità pubblica – carenza di posti letto, mancanza di personale medico e infermieristico, costretto a turni massacranti, lunghe liste d’attesa che spinge chi se lo può permettere a rivolgersi a pagamento al privato e chi no a restare in attesa o rinunciare a curarsi, anche nel ricco Nord – chi li risolverà? La fiscalità regionale con le assicurazioni private che lucrano solo profitti, come negli USA? No, tutto andrà per il peggio. E che dire della scuola, Presidente? Ogni regione avrà il suo sistema scolastico finanziato dalla fiscalità regionale e dalle Fondazioni private? È questa l’unità nazionale di cui è garante? Presidente, noi siamo propense a pensare che quella legge non la doveva firmare, perché l’ha fatto?
Con cordialità
Franca Fortunato e Adriana Sbrogiò
(Quotidiano del Sud Calabria, 6 luglio 2024, rubrica “Io, Donna” curata da Franca Fortunato)
Franca Fortunato e Adriana Sbrogiò fanno parte della rete delle Città Vicine. Questa lettera si può firmare: https://chng.it/tZBNY6JvjW
L’apertura della legislatura in cui la guerra è costituente di un presunto “arco costituzionale” europeo
Interpreto il comunicato di Disarmisti esigenti a cui partecipo con altre donne.
Il nostro presidio, di Disarmisti esigenti e altri, dal 16 al 19 luglio davanti alla sede del Parlamento europeo rimarca un impegno preciso: contrastare l’uso della retorica della pace di chi poi vota a presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen.E l’abitudine di votare solo per motivi di schieramento partitico, andando poi ad appoggiare con il voto gli aiuti militari a Zelensky.
Lo illustriamo in una conferenza stampa a Roma, il 9 luglio 2024, alle ore 11:00, presso la Libreria D’Amico, via Silvio D’Amico 1.
Ci chiediamo se sia utile che buona parte della sinistra cosiddetta radicale del gruppo Left sostenga la posizione che sia giusto che l’“aggredito” resista militarmente all’“aggressore”. Molti, tra cui molti elettori del PD che pure è un pilastro della maggioranza per la guerra, si proclamano e si credono pacifisti. Ma dimostrano di non avere alcuna strategia, alcuna vertenzialità contro i governi che fomentano la violenza della guerra, sono assenti e in silenzio assoluto nei momenti in cui viene deciso di accettare solo una “pace giusta”, cioè di andare avanti fino alla completa sconfitta militare dell’avversario, legittimando così concretamente la corsa agli armamenti e ai massacri. Lo abbiamo visto quando, in Italia, si sono approvati gli aiuti militari all’Ucraina.
Noi siamo molto sospettose anche rispetto a certe “unità contro la destra” che considerano l’opposizione contro la guerra addirittura divisiva. Non è forse il clima bellico, con la militarizzazione dell’intera società, il più fertile incubatore dei fascismi?
Noi donne e uomini di Disarmisti Esigenti saremo a Strasburgo appunto per vigilare e documentare, per mettere in evidenza che ci vuole coerenza tra parole e opere! Vogliamo cercare eurodeputate ed eurodeputati onesti, disposte/i a lavorare per i popoli che non vogliono essere massacrati, a prendere seriamente l’impegno di opporsi alle guerre, perché facciano da sponda istituzionale ai movimenti di base che si danno da fare con le azioni dirette, le obiezioni, la disobbedienza civile nonviolenta!
Non sarà affatto facile, perché l’atlantismo e la guerra contro la Russia sono il perimetro dell’“arco costituzionale” che, a livello europeo, andrà a formare la nuova versione della “maggioranza Ursula”. Ma è probabile che anche chi voterà contro la Commissione UE sarà a favore della sua politica di sostegno all’“autodifesa armata” dell’Ucraina in forma di guerra ad alta intensità.
Quello che invece noi sosteniamo è che, nelle condizioni tecnologiche e sociali contemporanee, da “villaggio globale” di fatto, non si può più immaginare una “guerra giusta”, come ha capito, tra i leader mondiali, Papa Francesco.
Ad esempio in Africa, dove sono del tutto estranei alle dispute territoriali in Ucraina, come conseguenza del conflitto che ha ostacolato le esportazioni di grano, la fame ha già fatto più morti delle centinaia di migliaia dei soldati periti sul campo di battaglia.
Non esiste nessuna causa territoriale che oggi valga la pena di difendere con le armi. Perché esse provocano problemi sempre peggiori di quelli che si ripromettono di risolvere, comportano il rischio di escalation incontrollabili, fino alla guerra atomica. E perché ogni rivendicazione tribale ci distoglie dal compito principale che oggi compete a tutte e tutti ai quattro angoli del Pianeta, alla comune umanità che siamo: la pace con la Natura, una nuova civilizzazione che riduca gli inquinanti, con tutto ciò che comporta in cambiamento degli stili di vita troppo lussuosi per la sostenibilità. La guerra costa e inquina più di ogni altra cosa, dev’essere evitata. L’essere a Strasburgo di pochi pacifisti che attivano il rapporto tra i popoli e gli eletti mi sembra uno sforzo da sostenere.
Bassam Aramin, palestinese, già condirettore del Parents Circle-Families Forum, ha trascorso sette anni in un carcere israeliano per il suo ruolo nella resistenza palestinese. Nel 2007 sua figlia Abir, dieci anni, è stata uccisa da un soldato israeliano. Vive a Gerico, in Cisgiordania.
Prima di tutto vorrei chiederti di raccontare brevemente la tua storia e di come sei entrato nel “Parents Circle”.
Ho trascorso sette anni nelle carceri israeliane, ci sono entrato quando avevo diciassette anni. Proprio in prigione ho visto un film sull’Olocausto, ed è così che ho scoperto della sua esistenza. Fino ad allora pensavo fosse una bugia, mi dicevo: «Non ne ho mai sentito parlare…». All’epoca fu molto difficile per me guardare quelle immagini; quella visione mi ha segnato al punto che, venticinque anni dopo, ho conseguito un master sull’Olocausto. A muovermi era stato il desiderio, la necessità di saperne di più sull’altra parte.
Quando sono stato rilasciato, sette anni dopo, mi sono sposato, ho avuto sei figli, e nel 2005 sono stato uno dei co-fondatori dei “Combatants for peace”, un’organizzazione israelo-palestinese impegnata in un’azione non violenta contro «l’occupazione israeliana e tutte le forme di violenza» in Israele e nei territori palestinesi, costituita da ex soldati israeliani e ufficiali che si sono rifiutati di prestare servizio nei territori occupati ed ex detenuti palestinesi.
Il 16 gennaio 2007 un poliziotto israeliano di servizio al confine ha sparato e ucciso mia figlia Abir, che all’epoca aveva dieci anni. Le ha sparato alle spalle da una distanza ravvicinata colpendola alla testa. È caduta a terra e due giorni dopo è spirata all’ospedale Hadassah, dove era stata ricoverata.
Due giorni dopo sono entrato nel “Parents Circle – Families Forum”, realtà che già conoscevo perché uno dei cofondatori di “Combatants for peace”, Rami Elhanan, aveva subìto un lutto, aveva perso la figlia Smadar in un attentato suicida palestinese il 4 settembre 1997, dieci anni prima della morte di mia figlia Abir. Avevo conosciuto Rami nel 2005 ed eravamo presto diventati molto amici. Due anni dopo eravamo legatissimi, praticamente di famiglia. Nei media palestinesi avevo letto anche del lavoro di Robi Damelin, per cui insomma conoscevo l’associazione, la apprezzavo, era davvero un impegno nobile. Certo nemmeno nel peggiore dei miei incubi immaginavo che mi sarebbe capitato di entrare a far parte di un gruppo di parenti di vittime.
È stato così che sono entrato nei “Parents Circle”, organizzazione che oggi conta oltre settecento famiglie di israeliani e palestinesi che hanno perso un proprio caro. Con Rami negli anni ci siamo talvolta detti che per quanto tra la morte di Smadar e quella di Abir siano passati dieci anni, l’assassino è lo stesso, è lo stesso criminale ad averci portato via le nostre figlie: l’occupazione israeliana, che ha provocato la resistenza e ha portato violenza e atrocità.
Quando sei entrato nel “Parents Circle” i tuoi famigliari ti hanno seguito? Dopo una tale tragedia sarebbe stato facile far prevalere il desiderio di vendetta.
È stato decisivo il fatto che fossi già un attivista pacifista; se non fossi stato impegnato con i “Combatants for peace” non so come sarebbe andata, credo che difficilmente sarei entrato a far parte dei “Parents Circle”.
All’epoca per la mia famiglia è stato molto difficile e doloroso, ma alla fine siamo entrati tutti. Mia moglie già conosceva il mio impegno. Ci è voluto più tempo per mio figlio Arab: quando aveva tredici anni aveva così tanta rabbia da assentarsi qualche volta da scuola per andare a tirare pietre. Mi ci sono voluti quattro anni per fargli capire che quella non era la strada giusta. Dopo si è unito anche lui ai “Parents Circle” e lì ha trovato un amico israeliano della sua età, con cui ha cominciato ad andare in giro a raccontare la sua storia. Il suo amico si chiama Yigal Elhanan: è il figlio di Rami. Così anch’io ho potuto finalmente fare pace con me stesso e con mio figlio.
Come hai reagito ai fatti del 7 ottobre, qual è stata la prima cosa che hai pensato?
Vorrei parlare anche dell’8 ottobre… il 7, l’8 ottobre… dipende da come si vedono le cose. Naturalmente non posso ignorare il 7, ma per noi palestinesi è come se fossero due cose separate. L’8 ottobre è stato l’inizio dell’ennesima operazione militare, che è la nostra quotidianità ormai da settantacinque anni. Per gli israeliani il 7 ottobre è stato invece vissuto come qualcosa di inedito dopo l’Olocausto.
Devo dire che per me quanto successo a partire dall’8 ottobre fino ancora a oggi non è stata una grande sorpresa. Anche parlandone con Rami ci siamo spesso ripetuti che non si può pensare di chiudere due milioni di persone in una scatola, chiudere il coperchio e ignorarle. Non può funzionare; temevamo che sarebbe successo qualcosa, che ci sarebbe scoppiato tra le mani e così è stato il 7 ottobre. In confidenza, la mia prima previsione era che fino a che Israele non avesse ammazzato 15-20.000 palestinesi, tra soldati, bambini, donne innocenti, non si sarebbe decisa a trattare per concludere l’operazione. Purtroppo ero stato troppo ottimista: abbiamo superato i 35.000 morti e ancora non è finita. Sfortunatamente questo è un conflitto feroce, l’occupazione si è fatta estremamente brutale, e a pagarne il prezzo sono principalmente degli innocenti, donne e bambini che non c’entrano nulla, la parte più debole sia in Palestina sia in Israele, anche se è più dura per i palestinesi: noi non abbiamo posti dove scappare, non abbiamo rifugi né qualcuno che ci avvisi. Ci hanno chiesto di andarcene a sud e poi ci hanno bombardato.
I membri di Hamas che hanno condotto l’attacco del 7 ottobre fin da bambini hanno assistito alle atrocità commesse da Israele contro Gaza. Hanno agito per vendetta. Se non cerchiamo la pace, se non poniamo fine a questa pulizia etnica, a questo genocidio che si svolge sotto i nostri occhi, sfortunatamente dovremo aspettarci altri 7 ottobre. Perché l’origine di questa tragedia è l’occupazione; entrambi, israeliani e palestinesi, ne sono vittime.
Fino a che continuerà l’occupazione siamo destinati a veder versato altro sangue, da entrambe le parti. La sicurezza di Israele dipende dal riconoscimento della dignità dei palestinesi; se vuole davvero la stabilità, deve far pace con i palestinesi.
Come siete riusciti a continuare il vostro lavoro in un periodo tanto difficile?
È dura. Siamo tutti esseri umani e ognuno guarda alla sua parte. Vediamo ciò che succede ai palestinesi e non ce ne capacitiamo, ma poi vediamo anche i bambini israeliani, le donne, quei ragazzi al rave… Come dicevo, siamo esseri umani, ma noi del Parents circle siamo anche persone abituate a vedere la dignità dell’altro, per cui guardiamo a entrambe le parti. Sin dal primo giorno abbiamo deciso di far sentire la nostra voce e di mantenere fede al nostro impegno. Per noi l’unica via d’uscita rimane il dialogo, il parlarsi l’uno con l’altro e l’agire insieme contro l’occupazione e contro ogni atto di violenza. Diversamente noi sappiamo bene cosa ci attende: un futuro doloroso, segnato dalla perdita di un proprio caro, un dolore, una ferita al cuore dalla quale non ci si riprenderà mai. Dopo il 7 e l’8 ottobre abbiamo cominciato a parlare tra di noi, anche se è stato faticoso, tanto più che non possiamo incontrarci fisicamente, visto che anche la Cisgiordania, dopo il 7 ottobre, è finita sotto assedio, per cui i nostri meeting, tutte le attività, le conferenze, dobbiamo tenerle via internet, su Zoom, su Skype…
Per quanto riguarda i coloni, la situazione è peggiorata?
Si parla sempre di Gaza perché lì la situazione è più grave, ma ci si dimentica della Cisgiordania, dove dal 7 ottobre a oggi sono morte più di quattrocento persone, e più di settemila sono state arrestate. Immaginate, settemila persone in una popolazione di cinque milioni.
Poi ci sono le atrocità dei coloni, che sono organizzati in bande paramilitari legalizzate perché di fatto supportate dall’esercito. È un problema grave: per loro non esiste alcuna legge. Loro non ci considerano persone: ogni giorno prendono di mira i nostri villaggi, le nostre auto, i nostri bambini, persino i nostri animali. Quando gli israeliani si interrogano su come sia potuto accadere il 7 ottobre, devono comprendere che tutto ciò è stata una reazione alla loro brutalità, alla loro oppressione. Chi vive sotto occupazione non accetterà mai questa situazione, vorrà reagire e questo è il risultato. Sfortunatamente, ci saranno ancora altre vittime, altro sangue.
La tua comunità, i palestinesi attorno a te come vedono questo sforzo per tenere aperto il dialogo con l’altra parte?
Non è facile: siamo una minoranza che nuota controcorrente. Nel mio caso nessuno mi ha mai dato del traditore, non ho mai sentito pronunciare quella parola. Conoscono la mia storia: ho passato sette anni nelle carceri israeliane, ho perso mia figlia, quindi ho il diritto di parlare.
Magari ti sorprenderà, ma oggi è più facile essere un attivista pacifista in Palestina di quanto non lo sia in Israele. In Israele ti possono arrestare per un post su Facebook, e parliamo dell’“unica democrazia del Medio Oriente”; lì le persone ora hanno paura; si sente sempre parlare di agguati contro gli attivisti israeliani, di docenti universitari costretti a dimettersi per aver condiviso qualcosa in un gruppo WhatsApp. Tra i palestinesi non ci sentiamo minacciati, le persone apprezzano quello che facciamo. Certo ora che a Gaza sono in corso dei massacri è tutto più difficile ma, nonostante la rabbia, le persone apprezzano ciò che facciamo.
Alcuni sondaggi di qualche settimana fa registravano un crescente appoggio per Hamas tra i giovani in Cisgiordania, tu cosa ne pensi?
Mi dispiace, ma se vivi sotto occupazione e qualcuno attacca l’occupante tu ne gioisci. A essere sincero penso che il 7 ottobre per molti palestinesi, dovunque fossero, sia stato un giorno felice. Noi di “Parents Circle”, impegnati per una via nonviolenta, sappiamo che non è così che si può ottenere un cambiamento. Il prezzo che si paga è sempre troppo alto. Dobbiamo far capire agli israeliani: «Avete speso miliardi e miliardi in tecnologia militare, nel costruire muri, nella sicurezza, e poi è arrivato il 7 ottobre. Tutto questo non è bastato a proteggervi. L’unica cosa che può garantire davvero la vostra sicurezza è un accordo di pace con il popolo palestinese». Dopodiché i palestinesi dovranno rispettare i patti e difendere i loro confini, come è accaduto tra Giordania e Israele e tra Egitto e Israele. Ognuno ha il diritto di difendersi, certamente, ma nessuno ha il diritto di occupare la terra altrui. Chi vive sotto occupazione non chiede il permesso per resistere. Resisterà comunque, intanto la nostra gente muore, muoiono i nostri figli. Dobbiamo porre fine a questa spirale, e lo si può fare solo riconoscendo la dignità dei palestinesi e il loro diritto di popolo all’autodeterminazione, ad un proprio stato.
Quando parli ai giovani cosa dici? È dura per un ragazzo cresciuto a Gaza o in Cisgiordania…
Assolutamente. Se sei palestinese la tua vita è difficile ovunque, che tu sia in Cisgiordania, nei campi profughi o a Gaza. Quello che dico sempre è che i palestinesi non hanno ucciso sei milioni di israeliani; neppure gli israeliani – finora – hanno ucciso sei milioni di palestinesi. Ebbene, oggi c’è un ambasciatore tedesco a Tel Aviv e uno israeliano a Berlino. E solo quattro anni dopo l’Olocausto, dopo sei milioni di morti, Israele e Germania intrattenevano regolari relazioni diplomatiche. Se ci sono riusciti loro, possiamo farcela anche noi. Siamo destinati a condividere questa terra, che potrà essere organizzata con uno, due o cinque stati, altrimenti la condivideremo comunque ma come due enormi tombe per i nostri figli, le nostre famiglie, la nostra gente.
Nessuno sparirà solo perché l’altra parte lo desidera. Siamo qui, insieme, e possiamo dimostrare di poter vivere in libertà e uguaglianza, dignità e giustizia sociale. Senza che nessuno occupi l’altro. Sfortunatamente abbiamo a che fare con una minoranza, oggi al potere, che porta avanti un tipo particolare di razzismo e di discriminazione. Il problema non è che noi siamo scuri e loro biondi. È che proprio non riescono a immaginare di dover condividere questa terra con nessun altro al di fuori degli ebrei, e per questo vorrebbero sbatterci fuori dal confine. Questo è il problema principale, e finché non si sbarazzeranno del loro senso di superiorità e capiranno che qui ci siamo anche noi e che non ce ne andremo da nessuna parte; che non è scritto da nessuna parte che dobbiamo continuare ad ammazzarci l’un l’altro, solo allora capiranno che c’è un’unica soluzione logica. Certo, è difficile, ma la pace si fa con i nemici, non con gli amici.
Se guardiamo indietro nella storia, all’impero romano, dov’è finito, ora? Lo sapete quante nazioni nella storia hanno cercato di occupare questa terra, la Palestina? Dove sono ora? Noi siamo ancora qui e ci rimarremo.
In una conferenza che ho ascoltato su YouTube dici che i gazawi sono più ottimisti degli israeliani di Tel Aviv. Puoi spiegare cosa intendi dire?
Certo, è molto difficile capire che cosa significhi per un popolo vivere sotto occupazione, sotto assedio per decenni. Le persone devono conservare una speranza, altrimenti impazziscono. Hanno più speranza perché soffrono di più: sono costretti a credere che in futuro vinceranno, che si troverà una soluzione.
Nessuno pensa di distruggere Israele; se lo chiedi loro, le persone rispondono che ciò che vogliono è la pace. Chiedilo alle madri: vogliono solo poter mandare i figli a scuola e vederli tornare indietro tutti interi, al sicuro. Lo stesso vale per gli abitanti della Cisgiordania, è un valore fondamentale. Gli israeliani sono diversi per un motivo: soffrono della mentalità della vittima. Sin da bambini crescono portando sulle spalle il peso di una lunga e tragica storia: schiavitù, antisemitismo fino ad arrivare all’Olocausto… così non è facile crescere ottimisti. Vedono un mondo pieno di nazisti, antisemiti o negazionisti. Le cose non stanno così; dovrebbero accantonare questa mentalità e vedere gli altri per quel che sono, smettendo di averne paura. D’altro canto, non si può continuare a far pagare il prezzo dell’Olocausto a noi palestinesi. Il fatto è che noi siamo le vittime delle vittime.
Come ti sei appassionato alla storia degli ebrei e alla vicenda della Shoah?
Quando ero piccolo sentivo dire che «Hitler aveva ucciso sei milioni di ebrei», ma non sapevo chi fosse; per me era solo un nome, una storia inventata. Nulla del genere poteva essere davvero accaduto. Poi, in prigione, mi è capitato appunto di vedere un film sull’Olocausto. Pensavo di godermi appunto una storia, poi ho visto le scene di tortura, gli arresti, le invasioni, e anche se mi trovavo nelle loro prigioni, dopo pochi minuti mi sono ritrovato a piangere, a provare empatia per quegli innocenti. Quello che avevo visto era davvero troppo per me, era una cosa contro la natura umana e la legge degli uomini. Mi ripetevo: è solo un film, non è la realtà, non è possibile che un essere umano faccia cose del genere ad altri esseri umani… Così ho sentito il bisogno di saperne di più. Devo dire che l’interesse nasceva anche dal bisogno di capire il brutale comportamento dei soldati israeliani quando venivano al mio villaggio. Sono le stesse cose che si vedono oggi a Gaza; quei soldati sono macchine per uccidere, non distinguono tra bambini, vecchi, insegnanti, donne, per loro sono tutti uguali. Quel film l’ho visto quando avevo credo diciassette anni e mezzo, non avevo idea di ciò che era successo ai palestinesi nel 1948, non sapevo della Naqba, della catastrofe. In prigione ho imparato che solo conoscendo il nemico lo puoi sconfiggere. Così ho studiato l’ebraico, la lingua del nemico, e poi ho approfondito la loro storia, ho anche visitato i campi di concentramento. Nella vita, più cose sai, meglio puoi agire. In arabo diciamo che quando impari qualcosa di nuovo cominci a soffrire, perché dopo non puoi più tacere. Ed è questo che è successo a me.
Come si svolge la tua giornata? Cosa stai facendo in questo difficile momento?
La nostra non è una vita quotidiana normale: per andare al lavoro devi passare i checkpoint e talvolta puoi metterci anche due-tre ore, è un disastro. Se sei studente, per raggiungere la scuola devi passare dal checkpoint di Anata, è quasi impossibile arrivare in orario. In Palestina non abbiamo il senso del tempo. Tra di noi ci diciamo: «Ci vediamo alle sei o forse alle nove» perché non possiamo saperlo prima. Immaginati di poterti aspettare di incontrare un checkpoint ogni minuto, quando sei in viaggio per andare a trovare la tua famiglia o quando rincasi dal lavoro; lo devi sempre preventivare, per cui non riesci mai a gestire il tempo, non sei libero di muoverti. In più non hai libertà di parola, vivi sotto una dittatura, sotto una brutale occupazione militare. In ogni momento potrebbero venire a prenderti e metterti in galera, senza accuse, anche per dieci anni! La chiamano “detenzione amministrativa”. Poi, dal momento che non sai le cose, non hai neppure un avvocato. Immagina, quando sentiamo parlare di democrazia, di diritti umani, di libertà di parola, noi sappiamo esattamente di cosa si parla: loro possono giocare con questi termini davanti al resto del mondo, ma non davanti a noi palestinesi. Dovrebbero confrontarsi su questo innanzitutto con noi, visto che siamo qui.
Si è molto parlato dell’inadeguatezza dei leader di entrambe le parti.
Si parla di “entrambe le parti” ma qui non ci sono due parti, ce n’è una sola, gli occupanti: un governo fascista e radicale. Non lo diciamo noi palestinesi, sono gli stessi israeliani a dirlo. Per noi è come se da settantacinque anni ci fosse lo stesso governo. Un governo che porta avanti l’occupazione, le detenzioni, le confische, che costruisce sempre più insediamenti, ruba altra terra, uccide altre persone, incarcera… Dal 1967 si stima siano stati incarcerati oltre un milione di palestinesi. Questo per dire che per noi sono tutti la stessa cosa. Ma questo governo attuale, sempre in base alle denunce fatte dagli israeliani, comprende anche due persone che in passato sono state accusate di terrorismo e incitamento all’odio dai tribunali israeliani. Penso a Itamar Ben-Gvir e a Bezalel Smotrich, per esempio. E loro sono i responsabili della sicurezza, te lo immagini?
Ora ci hanno vietato di andare nelle scuole a parlare ai ragazzini della nostra esperienza, di pace e riconciliazione. Per loro siamo molto pericolosi, e in effetti lo siamo, visto che ci contrapponiamo al loro programma di razzismo, odio e tenebre. Per questo ci combattono, accusando noi di essere terroristi. Un terrorista che mi accusa di essere terrorista è per me un grande onore, ma non è questo il punto: il punto è che noi rimaniamo determinati a diffondere il nostro messaggio di pace e riconciliazione contro questo brutale governo e continueremo fino a che non saranno costretti a vederci, a riconoscerci.
Sul lato palestinese fortunatamente ci sostengono, non hanno nulla contro di noi, siamo stati a visitare il presidente molte volte, tutte le autorità ci appoggiano, perché anche loro vogliono la pace, ma non sono loro ad avere potere. E come potrebbero? Ogni giorno nelle strade di qualsiasi città palestinese ci sono i soldati israeliani. Quindi come si può parlare di “entrambe le parti”? Anche il presidente palestinese ha spiegato che per spostarsi nella sua Ramallah gli serve un permesso rilasciato da israeliani e americani.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Spesso quando parlo in pubblico concludo con le parole di Martin Luther King: alla fine ci ricorderemo non delle parole dei nostri nemici, ma del silenzio dei nostri amici. Per favore, non restate in silenzio.
(Una Città n° 301 / 2024 – aprile-maggio, traduzione di Stefano Ignone)
Da Doppiozero – È decisamente confortante assistere al ritorno in libreria, tra inediti e ristampe, degli scritti e dei diari di Susan Sontag, saggista, romanziera, drammaturga, cineasta, attivista di sinistra e femminista, molto famosa fin dagli anni Sessanta. Una mente multiforme, il cui pensiero, pur muovendosi nelle diverse pieghe della sua contemporaneità, supera in modo folgorante l’esame del tempo che passa, arrivando a noi con la ferma padronanza delle prospettive teoriche e l’ostinazione di un nucleo antagonistico di sorprendente agilità che punta dritto ai problemi, in ragione di un tenace desiderio di conoscenza.
I saggi raccolti in Sulle donne (a cura di David Rieff, Einaudi 2024) coprono gli anni dal 1972 al 1975, e li vorrei scorporare in due momenti per cercare di rendere conto di alcune fra le molte sollecitazioni e riflessioni di un tema sì ben identificato, ma variamente declinato, nel tempo e in paesi diversi. Naturalmente gli scritti sono tutti legati, più o meno sottotraccia, da un contesto che è costituito sempre, nell’orizzonte di lavoro di Sontag, di fatti, viaggi, incontri, libri e lotte. Scenario primo dei suoi bersagli sono, negli anni della guerra del Vietnam, il neoliberismo, l’anticapitalismo e l’antimperialismo, la sua postazione quella di un’intellettuale anticonformista e anti-ideologica, anche tra le femministe. Tre saggi e una lunga intervista definiscono il primo campo, con al centro il corpo delle donne, il secondo campo è costituito da un lungo e importante saggio (“Fascino fascista” del 1974, già ristampato in Sotto il segno di Saturno, Nottetempo 2023), da uno scambio polemico, di grande interesse, tra l’autrice e Adrienne Rich (poeta e saggista, suo un classico del femminismo, Nato di donna, 1976), e da un’intervista che riprende e rilancia alcuni momenti della storia intellettuale di Sontag.
Nella prima parte salta agli occhi con grande evidenza come il suo pensiero sia insieme per certi aspetti datato e per molti altri di estrema lungimiranza, il che significa che la lente storica con cui lo leggiamo oggi registra uno sguardo critico, finemente antropologico, in grado di cogliere elementi naturali, culturali, sociali ed economici propri del suo tempo, ma di rivelare anche, spesso, piccole o abbaglianti verità, balenio di intuizioni che ancora ci interrogano. Se prendiamo ad esempio il saggio di apertura, “Invecchiare: due pesi e due misure”, la messa a fuoco più rilevante riguarda la brutalità dell’asse patriarcale che, distribuendo a uomini e donne privilegi e potere in modo violento e dispari, rende l’invecchiamento femminile «osceno», perché quel corpo è ormai orfano di ogni potenza desiderante (attribuita solo alla giovinezza), e dunque soggetto a un giudizio sociale umiliante, una «demonizzazione della femminilità» che è arrivata persino a cristallizzarsi «in caricature mitiche come la megera, la virago, la vamp e la strega». Questo da un lato, ma dall’altro è la subalternità interiormente introiettata a rendere le donne complici attive di questa minorità. Distinguendo tra vecchiaia e invecchiamento, Sontag vede in quest’ultimo «un’ordalia dell’immaginazione – un malessere morale, una patologia sociale –» tale che la donna finisce per viversi con «vergogna» e «disgusto»; si innestano qui pagine ancora importanti sul teatro della femminilità, sulle forme di un’autorappresentazione asservita al gusto dominante (e dominato dall’uomo, con «regole» utili a rafforzare «le strutture del potere»), sull’acquiescenza delle donne, nutrita di bugie, riflesso penoso di un insultante paternalismo (ricordo le donne-specchio di Woolf, le donne-alibi di de Beauvoir). I profondi pregiudizi e gli inveterati privilegi maschili, che hanno costruito nei secoli un così radicato «tabù estetico», indicano chiaramente le forme di una manipolazione culturale tale da lasciare ben salda nelle mani degli uomini la leva del potere, perno e volano di ogni ragionamento sulla sessualità e sul corpo delle donne. Sesso, potere, soldi: non ne siamo uscite del tutto nemmeno oggi, se è vero che le donne vecchie sono diventate una buona fetta del mercato cosmetico mondiale da blandire, e le più giovani, afferma una recente indagine, chiedono come regalo per il loro diciottesimo compleanno interventi estetici soprattutto sul seno. Affari e profitti colossali.
Altri due scritti intitolati alla bellezza (Fonte di discredito o di potere e Come cambierà?) annodano un filo costante del suo pensiero, il rapporto tra estetica ed etica, e ripropongono la questione del potere, il potere, ben noto a tutte noi, della seduzione, con il suo volto bifronte, che per un verso garantisce il piacere dello scambio erotico e vitale, dall’altro si riduce a potere di “attrarre” e dunque nega se stesso, perché rinuncia a essere trasformativo della relazione. Se “farsi bella” diventa un lavoro, un dovere di sopravvivenza in un mondo diseguale, allora la bellezza stessa diventa in definitiva un’altra fonte di auto-oppressione. Ma ancor peggio, ci racconta il secondo articolo, la bellezza e il consumismo vanno a braccetto, perché non solo la bellezza naturale non esiste, ma in quanto mito è una perversa invenzione maschile che imprigiona le donne e, «democratizzandosi», fa pensare che si possa e si debba acquisirla per diventare «uniche, eccezionali».
È il vecchio gioco del divide et impera, pensiero che torna prepotente in “Il terzo mondo delle donne”, assieme ai temi già in parte nominati, dal mai intaccato privilegio maschile, ai pregiudizi, all’oppressione millenaria che radica una delirante idea proprietaria del corpo dell’Altra e che, in Occidente, a fronte dell’avvento della libertà femminile, arriva troppo spesso al femminicidio. Necessità dunque di una rivoluzione economica, culturale, linguistica, necessità che il cambiamento passi da una nuova coscienza femminile, necessità di un’etica sessuale non più incardinata nell’eterosessualità, lotta alla mistica della natura (non a caso La mistica della femminilità, di Betty Friedan, è del 1963) e al biologismo, lotta per il potere e non per la parità, lotta agli stereotipi sessuali sul lavoro…
Alcune questioni di questo lungo ragionamento tornano in modo aspro anche nella seconda parte del libro, a partire da “Fascino fascista” in cui, con lucida passione, Sontag mette a fuoco l’intreccio perverso di etica ed estetica sia nel libro dedicato ai Nuba sia nei film documentari di Leni Riefenstahl (in particolare Il trionfo della volontà e Olympia), sottolineandone una continuità tale da non permettere da non permettere alcuna riabilitazione in nome dell’arte (è una tematica questa che ritroviamo nella conversazione finale per la rivista “Salmagundi”, con richiami a Kracauer e Benjamin). Premesso che quei due documentari – scrive Sontag – «sono indubbiamente magnifici […] ma non hanno una reale importanza nella storia del cinema come forma d’arte», tuttavia un «giro di ruota culturale» non può rendere «irrilevante» il passato nazista di Riefenstahl, l’insieme di opere tanto funzionali e fondative dell’estetica fascista da essere finanziate direttamente da Hitler e Goebbels: masse «in inquadrature panoramiche», «primi piani in cui è isolata una singola passione, una singola, perfetta sottomissione», estasi della vittoria, culto del capo, e ancora i corpi nudi dei primitivi, i bellissimi Nuba (un’intera comunità destinata all’estinzione), e infine il legame intrinseco e «naturale» fra fascismo e sadomasochismo. Non si salva il passato di una donna solo perché è una donna.
La lettura di questo articolo sul New York Times stranisce Adrienne Rich, che obietta a Sontag di non essere ben informata sulle proteste femministe per la presenza di questi film nei diversi festiva, ma soprattutto per aver tradito il saggio precedente, Il terzo mondo delle donne, dopo il quale molte si aspettavano opere con «un rigoroso rispecchiamento dei valori femministi». Ridotto a «puro esercizio intellettuale», questo scritto secondo Rich mostra Sontag vittima di una vera scissione tra l’acutezza intellettuale e la base emotiva della conoscenza, che è la forma in cui meglio si profila la colonizzazione patriarcale. La replica è esplosiva e tagliente, mostra lo scatto orgoglioso di una mente indipendente, sempre lontana dal cercare approvazione o dall’inchinarsi a qualsiasi dettato ideologico, indica con veemenza una «persistente aberrazione della retorica femminista: l’anti-intellettualismo», afferma che il «discredito delle virtù normative dell’intelletto […] è una delle radici del fascismo». La lotta alla misoginia, che passa dal separare le «eccezionali» da tutte le altre, come ha già scritto Sontag, vive della consapevolezza che una cosa è accettare «con compiacimento» il proprio privilegio partecipando «all’oppressione di altre donne», dunque tradendole, altra cosa è rivendicare la libertà di pensare, di distinguere, di contestualizzare, per non sacrificare tutto a una generica «storia patriarcale» («Sono una femminista militante, non una militante femminista», leggo nel diario). Quel «sospetto nutrito contro il pensiero e le parole rientra a pieno nella grande tradizione dell’anti-intellettualismo americano» ribadirà ancora nel 2002, e le donne non devono peccare dello stesso errore. Errore ancora attuale, sul quale molto avremmo tutti da pensare, così come, per una migliore comprensione, va contestualizzata la sua polemica contro il separatismo, in cui l’affinità con Simone de Beauvoir le impedisce di capire la necessità storica di quel taglio generatore di libertà femminile che dobbiamo a Irigaray e Lonzi. Ora l’ultimo nodo da rilevare, con rispetto e discrezione, riguarda quella crepa interiore, intuita da Rich, e che la lettura dei diari (Rinata e La coscienza imbrigliata nel corpo, Nottetempo) conferma come sua dolorosa ferita, a riprova che se il pensiero vitale e polemico di Susan Sontag è invecchiato benissimo, certo il suo corpo di donna ha pagato un alto prezzo all’eresia della sua mente.
Da Doppiozero – Siamo in un’epoca di “caos cognitivo” che si è preso molti cervelli nel mondo. Spesso anche quelli che si ritenevano cervelli migliori, a sinistra, paiono brancolare nel buio e non comprendere cosa accade veramente nella realtà quotidiana. Concordemente nei luoghi di osservazione indipendenti, si pensa sia perché la sinistra istituzionale si è adattata all’andamento confuso del cosiddetto capitalismo neoliberista finanziario. Il fatto è che questo adattamento collabora con la fine del pensiero critico attraverso l’elaborazione del cosiddetto “politicamente corretto”, altrimenti pensabile come morale pubblica imposta soprattutto attraverso i media, social compresi. Il combinato disposto caos cognitivo e politicamente corretto conduce velocemente in uno stato mentale e comportamentale che potremmo definire di dominio, poiché si esplica soprattutto attraverso slogan, parole d’ordine, formule morali, ma soprattutto al fumo con cui si ricopre ogni cosa grazie all’attivazione continua dell’appello ai “diritti”. Si dimentica, allo stesso tempo e a sinistra, che nel sistema giuridico occidentale i “diritti” sono individuali e si richiamano strettamente a proprietà individuali. Tutto questo, fino al femminismo della seconda ondata compreso, le donne lo avevano chiaro, perché in tutto questo non erano mai state considerate, grazie al cielo. Si dà il caso che, oggi, il femminismo come soggetto politico, si sia diviso in correnti, in pratiche differenti, in prese di posizione molto distanti tra loro. Tutto grazie al mercato neoliberista dei diritti. Così sinistra istituzionale e femminismi difensori della libertà individualistica si trovano d’accordo nel dare addosso al femminismo della origini che “non crede di avere (solo) dei diritti”.
Questa premessa si è resa necessaria per dare molti motivi alla necessità di raccogliere dati e testimonianze confluiti nel libro Vietato a sinistra. Dieci interventi femmnisti su temi scomodi, curato da Daniela Dioguardi, femminista della differenza sessuale, cioè del femminismo della libertà non individualistica. L’eccellente introduzione di Francesca Izzo, spiega molto chiaramente come, lei e molte altre, si siano trovate allontanate «da partiti e organizzazioni della sinistra a cui erano appartenute o avevano guardato con simpatia». La mia premessa dà una traccia per capire i motivi di questo allontanamento che trova ulteriori ragioni nella lacerazione prodotta, anche tra donne, da temi e appelli “divisivi”. Mi sembra chiaro che la divisione deve ringraziare i dettami politicamente corretti che ammaliano anche una parte delle femministe, creando nella mente una forbice dicotomica. Eccone alcuni: affido condiviso che “cancella la madre”; prostituzione come “lavoro” parificato agli altri neoliberisti; maternità surrogata come diritto ad avere figli a prescindere dall’unità psicofisica materna; identità di genere che nega l’unità psicofica di ogni corpo; gender per tutti, a prescindere se c’è una donna di sesso femminile o una donna di gender femminile, e via così di dicotomia in dicotomia, di identità spacciate per fluidità, ecc. ecc. L’inaccettabilità, sia logica sia umana, di queste risorse della confusione del presente, risulta sottolineata da un’evidenza: ogni dicotomia che si presenti nella storia tende a cancellare le donne di sesso femminile dalla cittadinanza e dall’autorità guadagnata dal pensare radicalmente. Forse una nuova era che tende all’insignificanza del soggetto sessuato? Forse un revanchismo misogino di maschi che intendono riprendersi di nuovo l’autorità assoluta?
Fatto sta che le autrici del libro si sono sentite nella necessità di mettere nero su bianco «i problemi che ci stanno di fronte, non affrontabili accumulando e sovrapponendo diritti. Si tratta invece di rivoluzionare i fondamenti, i paradigmi della cittadinanza perché l’ingresso delle donne significa la rottura e lo sconvolgimento defgli assetti istituzionali», compreso tutto quanto supporta questi assetti, come fa il “politicamente corretto”. Le esperienze e i contributi di riflessione contenuti nel libro (scritti da Silvia Baratella, Marcella De Carli Ferrari, Lorenza De Micco, Anna Merlino, Daniela Dioguardi, Caterina Gatti, Cristina Gramolini, Roberta Vannucci, Doranna Lupi, Laura Minguzzi, Laura Piretti, Stella Zaltieri Pirola) cercano di rispondere alla domanda: perché per porre fine alle discriminazioni e alle violenze si deve annullare la differenza sessuale? Scrive Francesca Izzo: «Nei fatti ciò che viene dissolto è la donna (dell’uomo non se ne parla…) per raggiungere un’uguaglianza secondo imperativi sociali pensati e voluti dagli uomini per gli uomini». Perciò chi, a sinistra, aderisce ai veti all’espressione della dissidenza rispetto agli “Imperativi sociali”, chi cerca di marginalizzare le femministe del pensiero della differenza, dovrebbe prendersi la responsabilità politica e storica di rappresentare la misoginia contemporanea. «Cosa succede quando la sinistra cosiddetta progressista si chiude al confronto su alcuni temi e l’inclusione diventa dogma? Oltre a lasciare spazio in maniera allarmante alla destra sugli stessi temi, rischia di contribuire all’affermazione di nuove censure e ingiustizie, anziché allo sviluppo di nuove pratiche democratiche». Non lasciamo ai posteri l’ardua sentenza. I tempi che corrono hanno già giudicato.
Vietato a sinistra. Dieci interventi femministi su temi scomodi, a cura di Daniela Dioguardi, introduzione di Francesca Izzo, Castelvecchi, pp. 91, euro 14,00
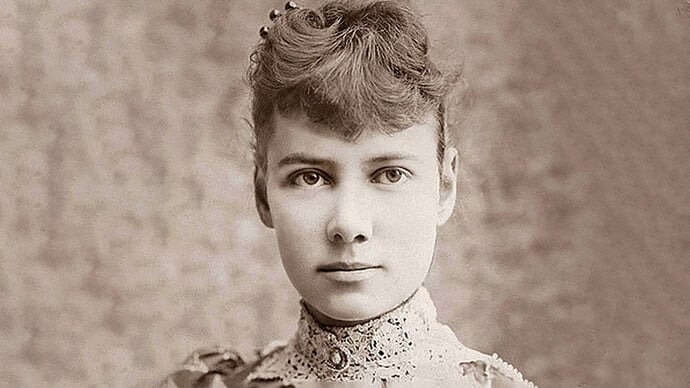
Da il manifesto – Il giornalismo sotto copertura lo ha inventato una donna. Nel 1880 Nellie Bly (nella foto), pseudonimo di Elizabeth Cochrane, si finse pazza per farsi internare nell’ospedale psichiatrico di Manhattan. Da dentro poté vedere e raccontare per il New York World di Joseph Pulitzer le condizioni in cui erano tenute le ricoverate. Donna era Barbara Ehrenreich, giornalista, scrittrice e attivista che per mesi lavorò in incognito per un’impresa di pulizie, esperienza raccontata in Una paga da fame: come (non) si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo. Quando è morta, nel 2022, il New York Times l’ha definita una «Esploratrice del lato oscuro della prosperità».
Donna è la francese Florence Aubenas che nel 2009 si iscrive a un ufficio di collocamento di Caen per svolgere un’inchiesta sulla reale situazione dei disoccupati in Francia. Ne uscirà un libro intitolato Le quai de Ouistreham, da cui è tratto un film con Juliette Binoche e diretto da Emmanuel Carrère. Donna è la giornalista di Fanpage che si è finta adepta di Gioventù nazionale per raccontare la realtà razzista e antisemita che anima il gruppo giovanile del partito di Giorgia Meloni.
Poiché nel mio piccolo anch’io ho dieci anni di esperienza come inchiestista in incognito, so che cosa significa infilarsi in luoghi che sarebbero di difficile accesso se ci si presentasse con la reale professione. Al di là dell’identità da darsi, dell’aspetto o dell’atteggiamento da assumere, il giornalismo undercover è prezioso perché può raccontare una realtà dal di dentro, senza maschere, senza filtri. Si può scoprire l’imbroglio, la corruzione, il ladrocinio, la violenza, oppure viene a galla il non detto che è sotto gli occhi di tutti, ma che si preferisce ignorare.
È, questa, l’esplorazione del lato oscuro di cui parla il New York Times e proposito della Ehrenreich che non svelò nulla di illecito, ma gettò in faccia all’America il suo lato rapace, la sua capacità di sfruttare il lavoro senza farsi domande perché così va il mondo, perché la legge te lo permette e quindi ti assolve.
Qui devo dirlo, c’è una diversa sensibilità anche fra giornalisti e per spiegarlo mi tocca raccontare un’esperienza personale. Quando lavorai in incognito come cameriera ai piani in un grande albergo di lusso a Milano, proposi l’inchiesta a un importante settimanale di politica e attualità le cui firme erano soprattutto di uomini. Mi risposero che sì, era interessante, ma in fondo raccontava solo che culo si fanno le cameriere d’albergo e lo rifiutarono perché non faceva notizia. Pubblicai con un’altra testata, anche quella con parecchie firme maschili, ma più sensibili agli anfratti della società e vinsi il premio cronista dell’anno per la Lombardia. Entrambe le testate erano di sinistra.
Se le inchieste di Günter Wallraff, che si finse operaio, alcolista, studente in cerca di alloggio, o quelle di Fabrizio Gatti che si è infiltrato nelle rotte dell’immigrazione irregolare, nel caporalato dell’agricoltura e dell’edilizia hanno svelato le illegalità e irregolarità di un occidente a cui i disperati fanno comodo, quelle delle giornaliste finte donne delle pulizie o finte pazze o finte lavoratrici precarie mostrano la parte indecentemente tollerata della società in cui viviamo.
È una realtà che a volte si nutre di indifferenza, altre viene subìta o combattuta, altre ancora è votata. Quando qualcuno fa cadere le maschere si produce un gioco di specchi e siccome non sempre gli specchi rimandano un’immagine edificante, a qualcuno fa più comodo additare non ciò che è stato svelato, ma chi ha tolto quel velo.
Da il manifesto – E se un premio internazionale per la pace fosse assegnato, in questo 2024, all’unico movimento al mondo che vede impegnati ex combattenti e obiettori di coscienza da entrambi in fronti di un conflitto ancora in corso? Intanto, ai «Combatants for Peace», associazione bi-nazionale di israeliani e palestinesi che dal 2006 porta avanti una storia di pacifica resistenza, è dedicato il libro Combattenti per la pace. Palestinesi e israeliani insieme per la liberazione collettiva, curato da Daniela Bezzi (con contributi di Ilaria Olimpico, Luisa Morgantini e Sergio Sinigaglia), per Multimage edizioni. E un campo per la pace si svolgerà in Israele il 1° luglio a opera di Combatants e di altre organizzazioni (fra cui Standing Together, Ir Amim, Peace Now).
La speranza attiva è sopravvissuta anche al 7 ottobre e a quel che ne è seguito a Gaza, confermano le due direttrici dell’associazione, Rana Salma ed Eszter Koranyi. I militanti auspicano una soluzione di «mutuo rispetto e riconoscimento, che possa restituire ai cittadini israeliani e palestinesi una vita di libertà, sicurezza, democrazia e dignità in entrambe le loro patrie». Fin dagli incontri segreti durante la seconda Intifada fra alcuni palestinesi che stavano combattendo o erano stati in carcere, e alcuni israeliani che erano nell’esercito, «si era arrivati alla conclusione che non esistono soluzioni militari» spiega Sulaiman Khatib, uno dei fondatori. Via via si sono aggiunte persone che non avevano partecipato ad attività militari.
Il lavoro comune dei Combatants si svolge anche sul terreno, nella cosiddetta area C della Cisgiordania, per aiutare le comunità palestinesi durante i raccolti e mitigare le aggressioni dei coloni. E poi sostegni economici alle vittime, visite organizzate, seminari formativi come le Freedom Schools, tentativi diplomatici… Il perno sono due annuali, solenni commemorazioni, capaci di radunare decine di migliaia di persone: la Joint Memorial Ceremony che, alla vigilia della celebrazione ufficiale della nascita dello Stato di Israele, introduce il concetto di un memoriale dedicato ai caduti di entrambi i fronti; e il ricordo della Nakba palestinese, perché pace e riconciliazione implicano un confronto con la storia. Nel 2024, per ragioni di sicurezza, le due cerimonie sono state preregistrate e seguite in streaming in tutto il mondo.
Le storie personali di quindici fra i membri dell’associazione si intrecciano con le tormentate vicende israelo-palestinesi nei decenni. Maia Hascal non approvava l’obiezione di coscienza dei soldati israeliani finché non ha trascorso settimane nei territori occupati. Galia Galil, la cui nonna nata a Jaffa era ebrea ma si definiva palestinese, si arruola a diciott’anni ma davanti alla violenza cerca un’altra via e un cartello pacifista per strada le fa capire che «il momento per fermare la guerra è durante la guerra stessa». Jamil Qassas ha partecipato all’Intifada e ha perso un fratello per mano dell’esercito occupante, ma un giorno vede sua madre piangere davanti alla notizia di bambini israeliani uccisi in un attentato, e da allora lotta «per la libertà per il mio popolo, ma in modo pacifico». Sulaiman Khatib negli anni trascorsi nelle carceri israeliane capisce che esistono narrazioni opposte del conflitto (e questa è una presa di coscienza comune a molti membri) ma che «apparteniamo alla stessa terra» e «abbiamo nemici comuni: odio, paura, trauma collettivo».
Chen Alon, diventato negli anni da soldato un «esperto militare dei territori occupati», alla fine firma la petizione dei refusenik (soldati che rifiutano di servire nei territori) e inizia il cammino che fonda i Combatants. Nathan Landau, arruolato nell’esercito israeliano, capisce che la guerra non è affatto romantica, è paura e disagio psico-fisico; al funerale di un amico riflette: «1948, 1967, 1973, prima Intifada, seconda Intifada, la guerra sarà sempre il nostro orizzonte se non fermiamo la spirale». Per Bassam Aramin, militante fin da piccolo, il confronto con una guardia carceraria è l’inizio di una scoperta che lo porta a incontrarsi con ex soldati israeliani. Nel 2007 sua figlia di dieci anni viene uccisa fuori dalla scuola. Bassam lotta per la giustizia, ma continua il dialogo perché «è stato un soldato israeliano a sparare ad Abir, ma cento ex soldati hanno costruito un giardino a lei dedicato».
«Ai primi incontri segreti c’ero anche io», scrive Luisa Morgantini. Era l’epoca in cui le manifestazioni pacifiche palestinesi venivano represse e Hamas colpiva i civili con le azioni suicide. Il risultato della violenza era devastante; e Israele continuava a espandere le proprie colonie (illegali). Proprio in quel contesto, fiori sbocciano. Familiari delle vittime israeliane e palestinesi si uniscono nel dolore. Nel 2004 nasce Breaking the Silence, soldati che escono dall’omertà. Si mobilitano politici delle due parti, viene anche presentato un Piano di pace. Certo sui Combatants come sulle altre forze pacifiche – minoritarie – piovono le accuse, sia in Israele («traditori») che in Palestina («normalizzatori»). Ma «oggi più che mai c’è bisogno di chi si oppone alla violenza, per una pace giusta e l’autodeterminazione del popolo palestinese, libero da apartheid, colonizzazione e occupazione militare».
Ricostruire la storia travagliata di quei popoli, per superare la quale occorrono i «costruttori di ponti» capaci nelle loro comunità di «tradire la compattezza etnica» mettendo tutto in discussione (anche se stessi): ecco il compito che nel libro spetta a Sergio Sinigaglia. Il conflitto non inizia con la creazione dello Stato di Israele nel 1948 ma è secolare. Negli ultimi anni, poi, «si sono viste tutte e due le società subire un processo di involuzione: una sempre più avvolta in una logica militarista e oscurantista; l’altra, un tempo laica, ormai egemonizzata dall’integralismo islamista». Ma i Combatants sono un seme per la futura realtà. Sarebbe piaciuto ad Hannah Arendt il cartello che compare nella foto che chiude il libro: «Nei tempi più bui, dobbiamo rifiutare di perdere la nostra umanità – altrimenti che senso ha vivere?».
Da Il Quotidiano del Sud – Scrivo per esprimere la mia solidarietà e il mio sostegno all’archeologa Maria Teresa Ianne, direttrice della Biblioteca calabrese di Soriano, piccolo borgo a pochi chilometri da Vibo Valentia, mia città natale. Nei giorni scorsi la vicenda della biblioteca e della sua direttrice è arrivata alle cronache nazionali per aver contrastato il sindaco che voleva cambiare la serratura con l’intenzione di chiudere la biblioteca e farla “sloggiare”. Lei si è opposta energicamente, ha mandato via il falegname e si è barricata dentro per difendere con il suo corpo l’amore per i libri e per la Calabria. A quel punto, il sindaco è accorso con aria “feroce” con degli impiegati e, indispettito perché aveva mandato via il falegname, le intima di “sloggiare”. La direttrice per difendersi chiama il 112, i carabinieri accorrono e liberano lei e i libri dalle intenzioni del sindaco. «La biblioteca – dice la direttrice in un’intervistata al Fatto Quotidiano (24 giugno 2024) – ha bisogno di libri e non di serrature». Come mai un sindaco appena eletto alle ultime amministrative, come primo atto si occupa della biblioteca per fare “sloggiare” la direttrice, che presta servizio da volontaria, e chiuderla definitivamente? Il suo gesto, come spiega la direttrice, «documenta la ritorsione ignorante, in un paese dominato dalla ’ndrangheta». Ritorsione nei confronti del suo avversario politico, fondatore della biblioteca, in un paese il cui consiglio comunale è stato sciolto due volte per infiltrazioni mafiose, l’ultima prima delle elezioni. Un gesto di ignoranza ma anche di mancanza di amore per la Calabria. La biblioteca, infatti, la cui storia inizia nel 1979 come Centro culturale del folklore e delle tradizioni popolari di Soriano e divenuto Istituto della Biblioteca calabrese nel 1992, possiede documenti rari, testi autentici, cinquecentine calabresi, incisioni, testi del XVII e XIX secolo. Un patrimonio che conta 31.265 volumi a disposizione di ricercatrici e ricercatori, di intellettuali e di chiunque ami la cultura, se solo la biblioteca venisse riaperta al pubblico. Da un anno, infatti, è chiusa perché «si è scoperto che non è rispettata la normativa antincendio» e le uniche a cui è concesso entrare sono la direttrice e l’impiegata che sta digitalizzando. Quell’immobile, dato alla biblioteca in comodato d’uso tanti anni fa, non appartiene al sindaco ma alla comunità di Soriano, la biblioteca non appartiene al sindaco ma a chi la dirige, la frequenta e la tiene in vita. Il sindaco come primo atto avrebbe dovuto cominciare a mettere a norma l’edificio, restituire al pubblico la biblioteca e ringraziare la direttrice per averla tenuta in vita anche se chiusa. Invece ha pensato di intervenire per farla “sloggiare”. La direttrice giura che lei non abbandonerà il suo posto e c’è da crederle. Chiudere una biblioteca, per ripicca o altro, è segno di disprezzo per i libri, un gesto che ci riporta alla memoria tempi bui di un passato che non passa, in cui ci sono state donne e uomini coraggiosi che hanno salvato la loro biblioteca per amore dei libri, come la direttrice, le bibliotecarie e i bibliotecari della biblioteca americana di Parigi, American Library, che durante l’occupazione nazista e la seconda guerra mondiale non solo hanno resistito all’ordine di chiuderla ma hanno continuato a fare circolare i libri, anche quelli “proibiti”, salvandoli dal rogo. Una storia straordinaria che ho avuto modo di raccontare recensendo il romanzo “La biblioteca di Parigi” di Janet Skeslien Charles.
Una storia di coraggio e di amore che oggi ritrovo nella direttrice della biblioteca di Soriano, che va aiutata e non lasciata sola per salvare la biblioteca, bene comune, dalla chiusura definitiva.
Da Corriere dello spettacolo – Nel Chiostro “Nina Vinchi” del Piccolo Teatro di Milano si è svolta la dodicesima edizione della Rassegna teatrale Anima Mundi. Ho ricordato al pubblico che il Premio nasce nel 2010 con l’intento di offrire al pubblico e agli addetti ai lavori una rassegna, una mini-vetrina non certo esaustiva ma significativa, di opere di qualità scritte da autrici affermate ma anche esordienti. Dopo i doverosi ringraziamenti a: il Comune di Milano, nella persona dell’Assessore alla Cultura, dott. Tommaso Sacchi e alla Coordinatrice all’Assessorato, dott.ssa Antonella Amodio, al dott. Andrea Barbato, Responsabile degli Eventi Speciali del Piccolo Teatro, ho ringraziato la U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro), che da sempre ci sostiene e sostiene il Teatro tutto con le sue centinaia di compagnie sparse sul territorio. A rappresentare la stessa UILT ho invitato sul palco la regista Lara Panighetti e l’attrice Raffaella De Martino della Compagnia GHOST di Bollate che hanno parlato della commedia, già rappresentata con successo, intitolata Madri interrotte in cui quattro donne, chiuse in un centro di recupero, confrontano le loro drammatiche, anche estreme, esperienze.
Entrando nel vivo della serata, ricordo che questa edizione è dedicata ad una donna vissuta seicento anni fa che scrisse uno dei massimi capolavori della letteratura spirituale di tutti i tempi e che si fece bruciare sul rogo come eretica relapsa per aver rifiutato di rinnegarlo. La donna di chiamava Margherita Porrete da Valenciennes e il suo libro Lo Specchio delle anime semplici. Abbiamo quindi proiettato alcuni minuti di un video che ho creato con l’intento di divulgare questa incredibile storia, sconosciuta ai più. Il video è stato realizzato con la preziosa collaborazione degli attori Domitilla Colombo, Daniela La Pira, Sergio Scorzillo e Paolo Tedesco, che ne ha anche curato il montaggio, ed è visibile su YouTube.
Tornando alla contemporaneità, sale sul palco Domitilla Colombo che legge un brano tratto da Riunione di famiglia, una commedia scritta da Maricla Boggio, nostra ospite d’onore e drammaturga di fama internazionale che, com’è noto, dirige la S.I.A.D. (Società Italiana Autori Drammatici) e la storica rivista “Ridotto”.
Fra le nuove proposte procediamo quindi con Chiara Antonutti,autrice del toccante monologo autobiografico intitolato Anna. Qui una giovane Chiara interroga idealmente la bisnonna Anna, uccisa nel 1936 con quaranta coltellate da un uomo che lei aveva rifiutato. Tante sono le domande di Chiara e le risposte di Anna come quella, fondamentale, di non aver potuto chiedere aiuto, ne legge un brano la stessa autrice. A seguire Mara Crisci presenta la sua coraggiosa e spiazzante pièce Arma, in cui il titolo “guerriero” fornisce direttamente il sottotesto dell’opera e si condensa nella scioccante frase«Scusa mamma, sono una puttana e mi piace!». Vero, falso? Il tema qui, come in altre opere presentate, è quello della libertà femminile ma non una libertà del fare o dell’avere ma dell’essere, una libertà da introiettare e da costruire in noi stesse per essere agita in totale consapevolezza e assecondando i nostri veri desideri. «Quanto costa la verità?», «Un corpo liberato dalla morale può diventare un’arma?»,le domande che Crisci propone al pubblico. Ne legge un intenso brano la stessa autrice. In seguito, il commosso intervento di Attilia Cozzaglio, leader dell’associazione Donne di Parola, che ci ricorda la fondatrice, Donatella Massara, scrittrice, femminista e autrice di testi teatrali, purtroppo di recente scomparsa. Leggono alcuni brani tratti dai suoi scritti Domitilla Colombo e Raffaella Gallerati. Succedono sul palcoDanielaDorigo e Daniela Zorzini, autrici di Bulimica, operain cui, con perfetto ritmo teatrale e sapienza letteraria,affrontano un tema purtroppo sempre più attuale, la bulimia. Si racconta il diario giornaliero, dal luglio 2023 al novembre 2024, di una donna affetta da bulimia che registra, ora per ora, le diverse fasi della sua malattia: la rabbia, i dottori, l’ansia di fronteggiare le ricadute, il rapporto con la madre e soprattutto il desiderio di risalire al “bandolo della matassa”. Ne legge un brano con la ben nota perizia Daniela Zorzini. Altro tema di triste attualità è la condizione delle donne nelle realtà mafiose. Lo presenta Marianna Faga con la pièce Non è per sempre. In questo caso parliamo di ’ndrangheta evediamo, in un unico ambiente claustrofobico, le donne del boss che, assente dalla scena, tuttavia domina figlie, moglie e anche amante. Ma «non è per sempre» sembra volerci dire l’autrice, ma come e in che modo? A parte la fuga, quale potrebbe essere? Questa è la questione. Infatti la giovane Gelsomina sembra optare per un’altra soluzione: rimanere sul posto e resistere alla corruzione e alla tirannia. Con l’autrice ne leggono un brano le attrici: Yasmina Luccisano e Rita Saldaneri.
Con Caravanserraglio, incubo contemporaneo, Nadia Marcuzzi racconta con toni altamente poetici, a tratti al ritmo musicale di un rap, le perversioni di una società odierna alienata e alienante. La stessa autrice ne legge uno dei brani più efficaci. Altro tema di forte impatto drammatico è presentato dalla nota drammaturga Francesca Sangalli. L’opera ironica e apparentemente disimpegnata, intitolata Non essere ridicola,pone la domanda: ridicola agli occhi di chi? Il tema della pièce richiama quello trattato da Mara Crisci in Arma, e cioè la libertà interiore della donna che combatte contro la tentazione del vittimismo. Il personaggio principale è un fantasma, Letizia, morta a cinquant’anni, che dialoga con la sorella Amalia, una donna di settant’annicon un figlio di quaranta. Letizia vorrebbe che la sorella superasse il tabù della donna anziana che intesse una relazione sentimentale con un uomo molto più giovane di lei. Ne leggono brillantemente un brano la stessa Francesca con Laura Pozone. Conclude egregiamente le letture sceniche Patrizia Schiavo con Donne senza censura, una commedia che ha già riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Qui un’attrice, arrivata al pieno successo, viene intervistata da una voce off che la incalza con domande indiscrete sulla sua vita privata, sui suoi partner, con riferimento a Carmelo Bene… mentre compaiono, alternandosi, alcuni alter ego della protagonista in conflitto fra loro e con la stessa protagonista. Ne legge un brano con la sua trascinante verve la stessa Patrizia Schiavo.
Per il Premio alla Regia, Chiara Malpezzi e Sergio Scorzillo presentano il trailer dellapièce Amiche in cui due donne fra loro diversissime, Edith ed Helen, nell’Irlanda degli anni settanta sconvolta dal conflitto fra protestanti e cattolici, iniziano un conflittuale rapporto che coinvolgerà tutta la loro vita. Brillante l’interpretazione delle due protagoniste: Chiara Malpezzi e Daniela La Pira. Dulcis in fundo Stefania Porrino presenta il trailer di Figlio non sei più giglio,una pièce che sta già riscuotendo un grande successo in molte città e che è interpretata dalla nota attriceDaniela Poggi e dalla musicista Mariella Nava. Qui una donna, Daniela Poggi, scrive un’accorata, durissima lettera all’amatissimo figlio, colpevole di aver ucciso la sua donna. Le musiche di Mariella Nava creano un flusso di emozioni fra le due protagoniste che si trasmette al pubblico.
In conclusione emerge dai testi presentati, oltre all’elevata qualità, il tema di quella libertà femminile, in parte ancora da conquistare, fuori da schemi mentali, a volte auto-imposti, che sovente sfociano nel vittimismo e nella recriminazione. La serata si è così conclusa fra gli applausi del pubblico che gremiva la sala.
Da Il Quotidiano del Sud – Mentre il governo e la sua maggioranza con la riforma dell’“Autonomia differenziata” erano impegnati a dividere l’Italia in tanti staterelli, a danno del Sud, e a rafforzare il potere della/del presidente del consiglio di turno stravolgendo la Costituzione italiana con la riforma del “Premierato”, lontano dalla scena del potere, nella notte tra domenica e lunedì, a poche miglia dalle coste della Calabria, a un anno dalla tragedia di Steccato di Cutro, si consumava sulla stessa rotta l’ennesimo naufragio. Un vecchio veliero, carico di esseri umani, per lo più famiglie afghane, curde irachene e siriane, partito dalla Turchia, è affondato, trascinando con sé negli abissi marini 65 esseri umani di cui 26 bambine/i, il più piccolo di soli quattro mesi annegato insieme alla sua mamma. Dodici i sopravvissuti, salvati da un veliero francese che si è fermato per soccorrerli, mentre altre imbarcazioni passate da lì hanno fatto finta di non vedere. I migranti avevano lanciato l’SOS quando la barca aveva cominciato a imbarcare acqua, ma nessuno aveva raccolto il loro grido di aiuto. Solo dopo l’SOS del veliero francese sono arrivati i soccorsi della Marina e della Guardia costiera calabresi. I 12 sopravvissuti, di cui due donne e una bambina, sbarcavano a Roccella Jonica, nella Locride, dove venivano affidati alle cure mediche e psicologiche. Delle due giovani donne una, le cui condizioni erano gravi al momento del salvataggio, è morta durante lo sbarco. Quando si sono imbarcate su quel veliero le madri alle loro creature che stringevano a sé o tenevano per mano avranno detto di stare tranquille, che ce l’avrebbero fatta ad arrivare sane e salve e che la loro vita sarebbe cambiata in meglio. In cuor loro ci credevano, volevano crederci. Quante speranze, desideri, sogni, storie viaggiavano su quel veliero che per tre giorni e tre notti, tre albe e tre tramonti, ha navigato su acque tranquille! Poi, il mare è diventato grosso, sulla barca c’è stato un forte scoppio che l’ha fatta tremare, facendo volare quegli esseri umani da una parte all’altra. Alla fiducia e alla speranza allora è subentrata la paura e il terrore. Non c’era nessuno, non c’era l’Europa, non c’era l’Italia in quelle acque per salvare quelle madri e le loro creature. Non c’erano le Ong, criminalizzate da questo governo e tenute lontane per impedire soccorsi e salvataggi. Un giorno la storia farà giustizia di questi che sono veri crimini contro l’umanità e allora chi ha governato le istituzioni europee e italiane dovrà darne conto alle generazioni che verranno. Allora le cose saranno chiamate col loro vero nome e quello che oggi è un vanto per l’Europa e per questo governo, come la costruzione di un centro di detenzione in Albania per migranti, sarà un’ignominia. Forse prima degli storici lo faranno bambine come la bimba curda iraniana di dieci anni, Nalina, i cui bellissimi occhi color ambra hanno visto sparire nel mare la madre, il padre e la sorellina ed è sbarcata in uno stato confusionale. «Non ricorda nulla e continua a chiamare la madre» racconta la pediatra cubana Taily Rodriguez Jaime, in servizio all’ospedale di Locri, che insieme a Concetta Gioffrè, vicepresidente della Croce Rossa, si è offerta a tenere con sé la piccola se la zia in gravi condizioni non dovesse farcela. Quanta umanità in queste donne e nei medici e infermiere che hanno preso in cura le/i sopravvissute/i! Non una parola di umana pietà è venuta dall’Europa o dal governo. Vite le loro che non contano, come quella del bracciante Satnam Singh, l’emigrato indiano gettato dal “padrone” davanti casa sua insieme al braccio strappatogli da un macchinario mentre lavorava a nero nelle campagne laziali. Anche lui è morto. È tra tanta disumanità che le destre avanzano ovunque.
Da il manifesto – «Possiamo aprire il presente all’imprevisto, possiamo fare la differenza». Così scrive Giulia Siviero, in chiusa alla introduzione del suo volume Fare femminismo (Nottetempo, pp. 181, euro 16,50). Più che una constatazione augurale, l’autrice sceglie di aprire il suo ragionamento sulla pluralità di pratiche e luoghi della politica delle donne che muovano da quel verbo declinato all’infinito scelto nel titolo. Cui se ne aggiungono molti altri, dal generare all’occupare, dal disertare allo spiazzare.
Legati a episodi storici, prese di parola e mutamenti di contesto, i tagli riferiti dall’autrice attingono al “fare” come senso libero di una esperienza attraversata. Ché parla ai (e dei) corpi e porta con sé la direzione anche di un disfare. Operazione genealogica e non archeologica, come ricorda Siviero fin dalle prime pagine, si restituisce una tessitura tanto più utile in questo tempo di rimozione ed equivalenza. Il metodo che Siviero utilizza per significare l’intreccio, storico e politico, è di una parola sessuata che emerge, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta (anche se gli andirivieni svettano di qualche secolo, quando occorre), in molti modi e continenti.
Ci sono storie, note e meno note, intorno alle parole (e alle lotte) che sono servite per scoprire e appropriarsi dei corpi, del proprio vissuto. Come quella di Matilde Maciocia che il 24 novembre del 1971 a Piazza Navona – durante una manifestazione per l’abrogazione del reato di aborto – racconta le condizioni per cui a vent’anni ha scelto di abortire, segnalando per un verso la brutalità della mammana cui si era rivolta e, d’altra parte, la violenza medica insieme alla necessità di rompere il «muro di omertà» e contro un sistema ingiusto. Siviero descrive, con sagacia e pazienza, il crocicchio di luoghi e nomi che hanno trasformato, con radicalità, il modo stesso di stare nel mondo: dall’autocoscienza, alle pratiche di self-help e dell’iter – non solo legislativo e non solo in ambito italiano – dell’aborto, dei processi per stupro e di molti altri temi.
«Generare lotta» è sottofondo di tutto il volume, e gli episodi riportati dall’autrice sono più che semplici aneddoti: per esempio ciò che accade il 13 settembre del 1968 al Congresso della lega tedesca degli studenti socialisti, a Francoforte sul Meno. Helke Sander, unica donna autorizzata a parlare, davanti ai compagni delegati denuncia la struttura sessista del movimento studentesco e propone di discuterne. La risposta è che un compagno riprende rapidamente la parola. In quel momento Sigrid Rüger, arrivata anche lei al congresso – quasi al termine della sua gravidanza e assistendo all’ennesimo tentativo di seppellire un confronto aperto – prende i pomodori che aveva con sé per la sua cena, si alza e inizia a lanciarli. Verso i delegati, gridando: controrivoluzionari.
In che modo, oggi, luoghi pubblici e domestici possano leggersi in una prospettiva interdisciplinare – politica e femminista – lo affronta il volume Gli spazi delle donne. Casa, lavoro, società a cura di Michela Bassanelli e Imma Forino (DeriveApprodi, pp. 202, euro 18). Storia, arte, sociologia, architettura, filosofia ed economia, sono i campi, presenti e mescolati, cui rispondono le autrici che avviano le rispettive riflessioni critiche. Spazio è qui parola cangiante e ricca di molteplici significati che però non possono saltare corpi ed esperienze: fisico, virtuale, tra forza collettiva e lotta politica, il corpo sessuato è, anche e non solo, luogo dell’agire e di relazioni con altri. Dall’idea della «casetta eugenica» di marca fascista (sviluppato da Annalisa Avon) alla «stanza per sé» (discusso da Carola D’Ambros), si arriva a ulteriori indagini come quella relativa alla casa intesa come spazio di lavoro produttivo e riproduttivo che, almeno dal tardo Settecento, è stato condizionato da un processo di femminilizzazione (come spiega Raffaela Sarti). Tutti molto utili ed efficaci, i testi inseriti ne Gli spazi delle donne raccontano della metamorfosi di gerarchie e ruoli che dalla modernità arrivano fino alle negoziazioni contemporanee, carichi di cura compresi (come ricorda Sandra Burchi) e alla disciplinazione sociale della sessualità (nel contributo di Carlotta Cossutta).
Prezioso è anche il volume a più voci curato da Paola Stelliferi e Stefania Voli: Anni di rivolta. Nuovi sguardi sui femminismi degli anni Settanta e Ottanta (Viella, pp. 314, euro 29), inserito nella bella collana «Storia delle donne e di genere», il cui punto di avvistamento più disciplinare nasce dal fermento globale provocato intorno a Ni una menos e il #Metoo, approfittando del cinquantesimo anniversario del primo manifesto di Rivolta Femminile comparso sui muri di Roma e Milano nel luglio del 1970.
Se la pandemia ha modificato quanto la Società italiana delle storiche si era prefissata, è importante che questo libro ritessa gli esiti di quante, nella primavera del 2020, avevano salutato con grande partecipazione la call for papers lanciata dalla Sis, consentendo di osservare in profondità alcuni momenti cruciali. A cominciare dall’intervento di Marta Panighel che si occupa della esperienza interna alla rivista Effe (1973-1982) e alla sorellanza come rappresentazione dell’Altra, proseguendo con il brillante contributo di Elisa Bellè sul femminismo trentino (di cui si era diffusamente occupata nel suo volume del 2021 per Rosenberg&Sellier, L’altra rivoluzione) proseguendo un lavoro ben documentato di costruzione della memoria pubblica che scardina la gerarchia «centro-periferia», collocando l’esperienza di Trento in una rete di relazioni, italiane e non. Altrettanto utile è il saggio di Anastasia Barone, sui consultori romani prima e dopo la legge 405/1975, e quello di Elena Biagini, concernente la soggettivazione politica delle lesbiche.
Da il manifesto – Il livello di violenza e crudeltà in Palestina, nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, ha oltrepassato da molto tempo ogni limite.
Ci eravamo espressi a gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, e lo facciamo di nuovo, a distanza di cinque mesi, perché l’inerzia e l’indifferenza di fronte alla strage della popolazione palestinese decimata e affamata è insopportabile. Da mesi, la risposta di Israele all’aggressione di Hamas si è trasformata in guerra di sterminio contro il popolo palestinese. L’azione del governo Netanyahu sta infliggendo al Paese un vulnus che peserà per generazioni.
Il nome stesso di Israele, già compromesso, desta ora ostilità e disprezzo crescenti nel mondo, crea isolamento e insicurezza, e fomenta antisemitismo. Crediamo che mai come ora spetti agli ebrei della diaspora e a chiunque abbia a cuore il futuro di Israele e dei palestinesi appoggiare le donne e gli uomini che in Israele, da settimane, si vanno ormai mobilitando non più solo per la liberazione degli ostaggi, ma chiedendo anche le dimissioni del governo Netanyahu. Sosteniamo gli israeliani che vogliono uscire dal tunnel di strage e distruzione in cui è stato trascinato il Paese.
Si cessi il fuoco immediatamente e sia adottato un piano che ponga fine alle sofferenze, ora.
Firmatari/e
Francesco Moshe Bassano, Guido Bassano, David Calef, Paola Canarutto, Giorgio Canarutto, Franca Chizzoli, Beppe Damascelli, Annapaola Formiggini, Paola Fermo, Sabetay Fresko, Bice Fubini, Nicoletta Gandus, Adriana Giussani Kleinefeld, Bella Gubbay, Joan Haim, Cecilia Herskovitz, Francesca Incardona, Stefano Levi Della Torre, Annie Lerner, Gad Lerner, Bruno Montesano, Guido Ortona, Giacomo Ortona, Bice Parodi, Mario Davide Sabbadini, David Terracini, Renata Sarfati, Eva Schwarzwald, Susanna Sinigaglia, Sergio Sinigaglia, Stefania Sinigaglia, Jardena Tedeschi, Mario Tedeschi, Fabrizia Termini, Claudio Treves, Roberto Veneziani, Micael Zeller, Marco Weiss.
Per adesioni: aderisco@maiindifferenti.it
Da Altraeconomia – L’esecutivo Milei ha tagliato fondi a ricerca, scuola, pensioni, prevenzione e politiche per le disuguaglianze di genere, colpendo soprattutto la popolazione femminile, che è la più povera. Ma la resistenza nel Paese c’è, come dimostrano le esperienze incontrate da Iaia Pedemonte, coautrice della nostra guida per “libere viaggiatrici”. Dai tour femministi di Buenos Aires a progetti di conservazione della biodiversità
In Argentina è un autunno molto caldo. Il 3 giugno, nono anniversario del movimento femminista “Ni una menos” (“Non una di meno”), al rullo dei tamburi, migliaia di persone – lavoratrici dei trasporti pubblici, casalinghe, persone trans, donne indigene, afrodiscendenti, migranti, prostitute – hanno sfidato il governo contro i “discorsi e crimini di odio”, la violenza di genere, l’oppressione dei popoli originari e il depredamento della terra. Nella stessa settimana, la Confederazione Generale del Lavoro è scesa in piazza contro la legge sulla “deregulation” e le politiche ultraliberiste dell’esecutivo di Javier Milei, che ha tolto fondi a ricerca, scuola, pensioni, prevenzione e politiche per le disuguaglianze di genere, colpendo soprattutto la popolazione femminile, che è la più povera.
Quel giorno María-Noel Vaeza, direttrice di Un Women per le Americhe e i Caraibi, ha ricordato che «qui dove c’è un femminicidio ogni 18 ore, servono una politica pubblica condivisa tra i ministeri, prevenzione, rispetto dei trattati internazionali». La risposta del governo è stata lo scioglimento del Sottosegretariato per la protezione contro la violenza di genere, ultimo baluardo rimasto dell’ex ministero delle Donne. In effetti, Milei è stato di parola, dato che il giorno dopo la sua elezione, otto mesi fa, come prima cosa aveva annunciato la chiusura di quel ministero, «degradante perché discriminatorio» e un nuovo referendum per cancellare la legge sull’interruzione di gravidanza. Da allora la “ministra delle donne”, Ayelén Mazzina, ha dovuto sospendere decine di progetti, dai congedi parentali ai nidi per le donne sole, al numero per le emergenze in cinque idiomi indigeni, alle metodologie ambientali legate al genere.
Le donne argentine restano comunque in prima fila. Ce lo ha raccontato Inés, facendo l’uncinetto nell’accampamento del Pueblo Jujuy nei giardini di Plaza de Mayo, a Buenos Aires: «Siamo in lotta contro le misure fasciste contro le popolazioni indigene e i diritti umani». Da qui al falò acceso lungo la strada centrale di fronte all’Oceano gelato di Ushuaia, abbiamo incontrato molte altre donne resistenti. Seguiteci e segnatevi gli indirizzi per un prossimo viaggio.
Prima tappa, le strade da visitare con i “tour femministi”. Basta scegliere tra le varie associazioni e in due ore si scopre che a Buenos Aires c’erano solo tre monumenti o strade che rappresentassero le donne, finché a Puerto Madero, intorno al nuovo Puente de la Mujer di Calatrava, fontane, giardini, statue e vie sono stati dedicati alle donne. Da Juana Azurduy e Micaela Bastidas che imbracciarono le armi contro gli spagnoli, alla medica e suffragetta Julieta Lanteri, che con Eva Perón ottenne nel 1947 il voto alle donne prima di essere uccisa, fino alle Madri di Plaza de Mayo, che finalmente hanno avuto una strada intitolata all’ultima donna scomparsa. «Non proponiamo solo la storia delle donne, ma quella del nostro continente, per far riflettere sulle disuguaglianze – racconta Leticia Garziglia, tra le ideatrici dei Femitour @femitour.bsas. – Se ora ci sono diritti riconosciuti a livello giuridico è perché c’è stata una lotta: in Argentina c’è un grande movimento che non lascerà passare questo nuovo patriarcato cieco davanti alla violenza».
Dai due imperdibili quartieri di Boca e di Puerto Madero, è un passo per il Barrio Rodrigo Bueno: una terra di nessuno in cui fino a pochi anni fa i migranti da Uruguay, Paraguay, Ecuador e campagne vivevano su palafitte e pescavano in canoa sul fiume, ora diventato il centro riconosciuto dei progetti sociali condivisi. Ci ha portato qui Bettina Gonzalez, instancabile curatrice di progetti ambientali contro la povertà. «Se prima le forme urbane di “villas” e insediamenti informali venivano risolte senza mai ottenere una vera integrazione, come nel difficilissimo vicino quartiere di Villa 31, qui invece c’è stata un’evoluzione sanitaria, economica, culturale, gli affitti dipendono da posizione sociale, età, possibilità».
Il fiore all’occhiello e cuore del quartiere è diventato la “Vivera Orgánica”, vivaio di piante ormai celebre come esempio di cultura circolare ambientale, sociale, economica, una cooperativa autosostenuta di quattordici donne, con lo scopo di integrare l’identità urbana dei migranti e diffondere la cultura della biodiversità. Tra serre e aula, fiori e farfalle sconosciuti, insegnano ad altre donne come aprire più orti e alle scuole pratiche ecologiche, disegnano spazi urbani, vendono l’insalata agli hotel, cucinano e fanno eventi. «E pensare che prima l’indirizzo era uno solo per mille abitanti: Avenida España 1800. Ci siamo riuniti per le strade a disegnare gli spazi, molti sono stati formati come muratori, alcuni sono rimasti a lavorare qui». Come Elisabeth Cuenca, l’unica che ha concluso il corso di guida e ora accompagna urbanisti da tutto il mondo. E non può che essere qui Peruvian Nikkei, uno dei migliori ristoranti peruviani della città.
La Vivera è diventata celebre anche grazie al marketing sociale di Jessica Oyarbide, che ha applicato qui i modelli studiati in India e Bangladesh, dove incubatori etici e imprese sociali sono radicati. Jessica ha inventato due iniziative – “Marcas que Marcan” ed “Echos” – con cui accompagna le imprese e incoraggia la trasformazione sociale, con corsi, consulenza, viaggi studio, personalizzazione del marchio, propagando un impatto positivo sulla società, la prospettiva di genere, l’inclusione economica di persone fuggite da situazioni di disagio. Così ha fatto conoscere anche le iniziative delle donne delle campagne, che oggi per le strade della città raccolgono firme contro le coltivazioni di soja e vendono piante autoctone.
Tra le più attive la Red de Mujeres Rurales: «Sono più di 500 donne in più di 100 organizzazioni – come ci ha raccontato Yamila Niclis di Agrocultura – intenzionate a fare conoscere le diverse professioni delle campagne, dalle veterinarie alle sociologhe, con progetti su pratiche ambientali, biotecnologie, clima, connettività, responsabilità sociale». Dove andare? Ci sono decine di iniziative da cercare durante un viaggio nelle pampas. Yamila e Jessica invitano tutti nelle comunità indigene del Grand Chaco, le cui artigiane vendono nel mercato solidale i loro prodotti tessuti a mano, oppure dalla catena solidale delle “regine del miele”, le cooperative da incontrare nella provincia di Buenos Aires e in diciotto Paesi nel mondo.
Ma poiché qui si viene per scoprire spazi infiniti, allora con lo zaino in spalla si va dalle “Imprenditrici per la natura” di Rewilding Argentina, Fondazione che protegge territori e specie, in uno dei progetti di conservazione più ambiziosi del Pianeta. Sofía Heinonen, studiosa degli ecosistemi a rischio, riconosciuta dalla Bbc come una delle cento donne più influenti del pianeta, dirige qui quattro parchi, che coprono più di un milione di ettari, con un team multidisciplinare di oltre duecento persone. «Siamo 50% di donne e 50% di uomini, ma le donne occupano più posizioni di responsabilità e comando: una piccola differenza a favore dell’emancipazione – ci ha detto Sofia. – Per quanto riguarda il turismo e l’imprenditorialità, inseriamo le donne nei progetti legati al turismo naturalistico o come guide, valorizzano il loro savoir-faire, come l’artigianato, la tessitura, la maglieria, la cucina tradizionale, e questo aiuta le famiglie perché le donne distribuiscono meglio il reddito».
Nei parchi protetti alle estremità del Paese abbiamo incontrato le “Imprenditrici per la natura”, decine di luoghi per altrettanti prodotti naturali ed attività con i turisti, tutti da scoprire da Nord a Sud: da Margarita Ibañez si va per i tessuti, ma poi si seguono i sentieri fino al fiume alla ricerca di uccelli rari. Carola Pucchiaro e Marisa Palomeque invece hanno partecipato ad un training di acquacultura, diventando esperte di diete a base di alghe, ma poi hanno anche aperto un affitto di biciclette, mentre alcuni istruttori offrono immersioni e giri in barca ai viaggiatori che si fermano nelle casette di legno colorate. Mentre Veda Palavecino e altre venti donne tingono e lavorano le lane, Alina Ruiz ha studiato nuove ricette e organizzato una scuola di cucina con i prodotti locali.
Alcuni spunti di viaggio a cura di Iaia Pedemonte, giornalista freelance, scrittrice, viaggiatrice ed esperta di turismo responsabile, in particolare al femminile. Ha fondato il sito “Gender Responsible Tourism”. Per Altreconomia ha scritto La guida delle libere viaggiatrici insieme a Manuela Bolchini.
Buenos Aires
Tour Femministi
Freetour: https://www.freetour.com/it/buenos-aires/feminist-tour-in-buenos-aires,
Setour: https://www.setours.com/wp_experience/feminist-tour-of-buenos-aires/,
Ecofeminita: https://ecofeminita.com/femitour-buenos-aires/?v=3a52f3c22ed6 )
Femitour di Leticia Garziglia: https://www.instagram.com/FemiTour.bsas/
Barrio Rodrigo Bueno
Guida Elisabeth Cuenca, tel. +541130048647, @broteli.tours.
Ristorante Peruvian Nikkey tel. +54 11 3941-9441, @peruviannikkeiar.com, https://www.facebook.com/peruviannikkei/?locale=sv_SE ).
La Vivera Organica, Vivaio e eventi: https://viveraorganica.empretienda.com.ar/
Tour Operator Responsabile Boomerang viajes: https://www.boomerangviajes.tur.ar .
Argentina
L’associazione Grand Chaco è nelle provincie di Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán e Santiago del Estero. La grande associazione di Mujeres Rurales raggruppa decine di realtà nelle campagne di tutto il continente: https://mujeresrurales.com/
Comunità Indigena Grand Chaco (www.matriarca.com.ar )
Cooperative del miele in tutte le Provincie https://honeyreinas.com .
Rewilding Argentina: Decine di rifugi, campeggi, comunità, percorsi a piedi, a cavallo, in foreste, lagune, rocce, quattro parchi, due Parchi Marini a El Impenetrable, Iberá, Patagonia e Terra del Fuoco
https://rewildingargentina.org .
Le Imprenditrici per la natura sono decine di microimprese tra natura e turismo. Le trovate per esempio a El Impenetrable, il Parco a 60 km da Miraflores. https://elimpenetrable.org/ .
Tutte le imprenditrici della natura valgono una visita: https://emprendedorespornaturaleza.org
Da la Repubblica – Robinson – Due grandi mostre, aperte alla Galleria Borghese di Roma e al Museo Novecento di Firenze, celebrano finalmente in Italia l’artista vissuta quasi un secolo che ha definitivamente liberato la creatività dal monopolio maschile. E che oggi continua a ispirare
Quanti interrogativi affiorano dal suo ghigno secco e da quel reticolo di rughe che è una matassa di ricordi emersi in superficie. Quanta ironia possiede ogni immagine della sua persona. E di quanta capacità di filtrare, modellare, spezzettare per poi rivisitare le cose del mondo, soffrendo ma anche giocando, si nutre ogni sua opera. Louise Bourgeois è un’artista sovraccarica di rinvii simbolici che esprime dimensioni spesso bipolari per raccontarci l’esistenza con le sue contraddizioni, i suoi traumi, le sue oscenità e i suoi conflitti, addensandola in una sfera traversata dalla psicoanalisi e dal mito. È una portatrice di affondi nella violenza relazionale e un’artefice di dilatazioni barocche degli sconvolgimenti del Novecento. È pure la fattucchiera che in un celebre ritratto di Robert Mapplethorpe reca sottobraccio un fallo enorme. Bellicoso? O difensivo come una clava? Si tratta di una sua scultura, Fillette, cioè ragazzina: «Per fare la foto avevo portato con me una piccola Louise», scrive lei. «Quell’opera mi rassicurava». Brandisci il pene, prima che lui catturi te.
Ora due grandi mostre in Italia, a Roma e a Firenze, celebrano il genio di Louise, nata a Parigi nel 1911 e morta a New York nel 2010. Visse in Francia fino al 1938 e poi in America, viaggiando nel frattempo in Europa e in Italia, dove passò periodi a Pietrasanta e a Carrara, nei laboratori del marmo. L’attuale riconoscimento italiano, forse tardivo vista la mole del personaggio e dei suoi influssi, esalta il segno di un’inventrice prolifica e autonoma, distante dai minimalismi, dai concettualismi e dagli espressionismi astratti del secolo scorso. Alla Galleria Borghese s’apre Louise Bourgeois. L’inconscio della memoria, esposizione votata alla sua prassi scultorea, mentre il Museo Novecento presenta Louise Bourgeois in Florence, progetto sdoppiato col Museo degli Innocenti, sede di Cell XVIII (Portrait), cioè di una delle famose “Celle” di Louise. Questa categoria di lavori anni Novanta consiste in una trafila di paesaggi ingabbiati che contengono emblemi e relitti: specchi, ghigliottine, sedie fluttuanti, sacchi di stoffa, pelli di coniglio, letti, fantocci, ex voto… Illusioni carcerarie o monastiche. Ricettacoli di proliferazioni dell’inconscio. Ma anche sviluppi del tema della donna-casa che negli anni Quaranta era al centro della serie di pitture Femme-Maison, dove i corpi metà donna e metà edifici scavavano nell’identità femminile soffocata dalle prigioni domestiche.
Aveva genitori pesanti, Louise, e li portò sulle spalle per tutta la vita. La sua arte fu una pluridecennale seduta psicoanalitica per affrancarsi da loro, o ridisegnarli a modo proprio. Qualcosa di universale, nella rappresentazione di quegli spettri, oltrepassa di molto l’autobiografia parlandoci di spirito e sesso, vita e morte, anima e corpo, misoginia e fallocrazia. Sua madre era Joséphine Fauriaux, suo padre era Louis Bourgeois. Restauravano arazzi. Lui era dispotico, umiliante e fanatico dei bordelli. Lei teneva insieme la famiglia distogliendo lo sguardo dai tradimenti del marito. Louise impara la cura delle stoffe, la pratica dei colori, la ricomposizione dei pezzi mancanti nei corpi. Inizia studi di matematica alla Sorbonne e li lascia per l’École des Beaux-Arts. Poi trasmigra negli atelier di artisti come Ferdinand Léger, che la spinge verso la scultura. Farà anche installazioni, narrazioni oggettistiche, teatrini onirici, gouaches (scarlatte e colme di senso d’umido, evocative di fluidi corporei) e iperbolici ragni materni. Userà il gesso, il cemento, il lattice, il marmo, il bronzo, il legno e la stoffa, corteggiata con l’antica arma infantile dell’ago. Non si dà confini: indaga materiali e disposizioni delle forme in spazi minimi e massimi, da esploratrice del cosmo. Sposa l’americano Robert Goldwater, che insegna storia dell’arte, e parte con lui per gli Stati Uniti. A New York trova i surrealisti Marcel Duchamp e André Breton, maschi indifferenti all’arte delle donne. «Erano interessati alle donne ricche, questo sì», scrive Louise, «ed erano interessati soprattutto a sé stessi». Lei è rimasta ancorata ai voli azzurri di Joan Miró, scoperto negli anni parigini e descritto come «un magnifico shock estetico». A New York la memoria è il suo racconto: nel ’50 plasma figure totemiche, diciassette sculture lignee che richiamano le persone lasciate in Francia. «Mi mancavano disperatamente».
In tempi successivi privilegia i falli, che però non sono mai soltanto falli. Sono fiabe, sfide, gusci misterici. Escrescenze microbiologiche e aggregazioni collinari. Vedi gli addensamenti di cazzetti in marmo nero dell’opera Colonnata. A volte paiono fanciulline oblunghe e pettorute (Fillette); a volte si miscelano nel bronzo di una forma organica bifronte che mima testicoli e fessure, o insegue mammelle amalgamabili coi genitali maschili (Janus Fleuri). Opposizione, scissione, ansia di risolvere il dualismo.
Risale al ’74 The Destruction of the Father, ritratto di famiglia situato in un antro pieno di protuberanze viscerali. «È l’orrida cena capeggiata dal padre che si siede e gode», scrive. «E gli altri, la madre e i figli? Stanno in silenzio. La madre cerca di soddisfare il tiranno, suo marito». Tramite frammenti di carne macellata allestisce il banchetto cannibalesco. È una vendetta rituale. «Più mio padre si pavoneggiava, più ci sentivamo insignificanti», spiega. «Improvvisamente si creava una tensione terribile e noi lo afferravamo, lo trascinavamo sul tavolo e lo smembravamo. Fantasie, ma talvolta la fantasia è vissuto». Nell’estro di Bourgeois si stagliano scenari da tragedia greca che ispireranno non poco la Abramović, ma non soltanto. Un’ondata femminista di fine Novecento (Kiki Smith, Rona Pondick e altre) prese Louise come punto di riferimento per svelare la corporeità, anche nei tabù e nell’enfasi del rapporto madre-figlio. L’ultima, ossessiva icona di Bourgeois sono i ragni, col loro abbraccio dominatore e protettivo. Di proporzioni abnormi, sorgono in diverse città del mondo. Il ragno è la madre. È intelligenza procreativa. Ma è anche tessitura di una tela, costruzione dell’arte, emanazione della fillette Louise che ammanta con una cupola le nostre paure.
Louise Bourgeois. L’inconscio della memoria è alla Galleria Borghese di Roma fino al 15 settembre, a cura di Cloé Perrone, Geraldine Léardi e Philip Larratt-Smith in collaborazione con The Easton Foundation e l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici. “Esistere come donna” è il programma di incontri e proiezioni a cura di Electa e Fondamenta che la accompagna: galleriaborghese.beniculturali.it Louise Bourgeois in Florence Do Not Abandon Me è al Museo Novecento di Firenze fino al 20 ottobre, a cura di Philip Larratt-Smith e Sergio Risaliti: Cell XVIII (Portrait) a cura di Philip Larratt-Smith con Arabella Natalini e Stefania Rispoli è nelle stesse date al Museo degli Innocenti di Firenze.
Da la Repubblica – Robinson – «Mi diceva: lavora in cucina, in bagno, in camera da letto, ovunque. E mettitelo bene in testa: hai un sacco di tempo davanti a te». Nei ricordi di Tracey Emin, Louise Bourgeois è ancora lì che la sprona, la rimprovera, le dà consigli, condividendo con lei il mistero dell’arte. L’ex ragazza terribile della scena inglese, appena nominata Dame Commander dell’Impero britannico dal re Carlo III, ha vissuto con la madre di tutte le artiste contemporanee un curioso sodalizio. Lontane quasi mezzo secolo per l’anagrafe, firmarono insieme il progetto Do Not Abandon Me, fondendo il loro stile e i colori in acquerelli unici. Tracey ha poi dedicato all’amica un documentario della Bbc e oggi, mentre è alle prese con una mostra a Bruxelles, prepara quella del 2025 al fiorentino Palazzo Strozzi e revisiona una monografia in uscita da Phaidon, si abbandona volentieri al racconto di una Bourgeois vista da molto vicino.
Dame Tracey Emin, quando si è imbattuta per la prima volta nell’arte di Louise Bourgeois?
«Nel 1996: il curatore Stuart Morgan fu il primo a parlarmene. Mi invitò a vedere la mostra della “sua amica Louise” alla Tate, dicendomi che sicuramente l’avrei apprezzata. E così mi ritrovai davanti ad alcune acqueforti. Erano datate anni Quaranta e iniziai a chiedermi perché mai. Guardando quelle opere, ero convinta che Bourgeois avesse la mia stessa età. Non ne sapevo niente, non avevo mai letto nulla di lei. Solo più tardi avrei scoperto che era molto, molto più anziana. E diventammo amiche».
Dove vi incontraste?
«A casa sua a New York, nel 2007. Riuscii ad avere un appuntamento. La cosa assurda fu che la porta era aperta. Entrai e chiamai. L’assistente, Jerry Gorovoy, scese giù dalle scale e mi chiese: come sei entrata? E io: la porta era aperta. E lui: impossibile. Forse era stata Louise stessa ad aprirla. Non lo scoprimmo mai. Lei, già ultranovantenne, era nel suo studio e ogni cosa in quella stanza appariva grigia e monotona, eccetto il pavimento che splendeva del magenta dei suoi disegni. Brillava intensamente. Louise era seduta al tavolo da lavoro. La guardavo e ricordo di essermi resa conto che aveva un seno enorme, gigantesco, e che non ero mai stata nella stessa stanza con una persona così anziana, la più anziana con cui avessi mai parlato. Fu tutto strano e intenso: andammo subito d’accordo».
Bourgeois le chiese di collaborare con lei. Fu una richiesta unica. Non era mai capitato con nessuno.
«Sì, accadde un anno dopo. Una sorpresa enorme per me. Ero abbastanza nervosa per questo. Lei iniziò a dirmi: fa’ quello vuoi, qualsiasi cosa, incasina tutto. Fa’ quello che vuoi. Più lo diceva e più diventavo nervosa. Alla fine, mi ci sono voluti due anni prima che realizzassi la mia parte, aggiungendo il mio tratto alle sue invenzioni. Ho fatto tutto in un solo weekend, ho arrotolato i disegni e glieli ho rispediti. Lei era a letto quando le sono stati recapitati. Jerry glieli srotolava e, ogni volta che Louise ne vedeva uno, esultava. Li ha apprezzati tantissimo. Compresi i peni, gli uomini nudi. Fu molto sorpresa. Voleva che effettivamente il risultato finale della nostra collaborazione risultasse come di una sola mano. L’ego non era contemplato».
Bourgeois iniziò a lavorare in un mondo dell’arte ancora tutto maschile: è stata una pioniera.
«La sua rivoluzione fu di realizzare progetti di qualsiasi dimensione. Dai piccoli disegni alle sculture giganti. Nulla era impossibile per lei. Non si poteva dirle di no. È stata la prima donna artista a ragionare così. Faceva esattamente ciò che voleva, anche se, certo, si muoveva in un mondo
ancora tutto maschile. Eppure manteneva una sua femminilità nei lavori. Nessun uomo avrebbe potuto fare quello che faceva Louise: qualcosa di ultra-femminile e, talvolta, enorme nelle proporzioni. Ha rotto una marea di barriere per noi. È stata un modello eccezionale. Il suo vero insegnamento era dire: fallo e basta».
Che cosa è cambiato da allora nel mondo dell’arte?
«Fino a una decina d’anni fa, il pubblico riusciva a stento a fare il nome di dieci artiste. Ora ci sono tante artiste e artisti black, c’è più diversità. Quando Louise era giovane, c’erano donne nel mondo dell’arte, ma erano più figure legate alle istituzioni o al mercato, penso a Peggy Guggenheim. Artiste come Joan Mitchell hanno impiegato tanto tempo per essere apprezzate. Bourgeois stessa ha dovuto superare la sessantina per essere riconosciuta. E pensare che adesso sono io ad avere sessant’anni! La mia generazione ha vissuto un sacco di cambiamenti».
Louise si sentì più libera di creare dopo la morte di suo marito, Robert Goldwater, nel 1973.
«Decisamente. Trasformò la casa di New York nel suo studio. Ogni singola parte. Amava suo marito, ma come artista credo si sentisse un po’ frenata, durante il matrimonio. Ricordiamoci che era anche madre. Aveva un mucchio di distrazioni domestiche».
Una volta, lei, Tracy, ha detto che per continuare a essere artista non avrebbe potuto diventare madre.
«È vero. Non sarei stata in grado di conciliare entrambe le cose. Alcune donne ci riescono. Ma per me sarebbe risultato impossibile. È il mio cuore che mi guida, che mi sveglia al mattino. Sono i sentimenti. Per questo, se avessi avuto un bambino, non sarei riuscita a separarmene. E non avrei potuto fare anche l’artista. Avrei fatto male una delle due cose, sicuramente. La mia energia funziona così. Il mio tempo è questo. Ma sono una madre di gatti, e va bene così».
Bourgeois ha definito la sua idea di maternità con il ragno: la serie di aracnidi giganti ribattezzati “Maman” che sono nei musei di tutto mondo.
«Per lei il ragno è l’essere femminile che depone le uova, ha più gambe, è in grado di essere qualsiasi cosa, apparentemente fragile ma forte. I ragni che Louise realizza su ampia scala, poi, sono come dei rifugi. Ci si può riparare sotto e sentirsi sicuri. E questa idea di maternità così concreta è geniale. La sua Maman è una creatura che protegge».
Ricorda l’ultima volta che vi siete incontrate?
«Era a New York, un paio di mesi prima che morisse, nel 2010. Guardammo insieme un libro di opere giovanili e parlammo un sacco. Mi diceva sempre: (ne imita la voce) tu hai tempo, tu hai tempo. Era una cosa che mi ripeteva spesso perché effettivamente io non me ne rendevo conto. Non capivo quanto tempo avessi rispetto a Louise. E quanto ancora ne avessi a disposizione per cambiare completamente la mia vita. Louise cambiò la sua a sessantaquattro anni. Io ancora non sono arrivata a quell’età».
L’ha mai sognata in questi anni?
«Sì, uno strano sogno. L’ho vista su una diga, sembrava di essere a Venezia. Louise era in piedi davanti all’acqua, che mi aspettava».
Da Adista – «E quando mi si dice che una donna è libera di fare del proprio corpo ciò che vuole, comincio a pensare che l’idea di libertà abbia iniziato a partorire mostri», ha chiosato brillantemente Alessandra Bocchetti già nel 20131.
Voci di “donne indisponibili” a questa malintesa idea di libertà sempre più prendono parola: per decostruire e affermare l’inaccettabilità di una idea di libertà disincarnata, che disconosce la logica del Due per riaffermare l’Uno, in una riedizione della logica universalistica androcentrica. Voci di autrici femministe che resistono a una cultura conformistica imperante che si spaccia per progressista; ma non lo è, piuttosto si tratta di “progressismo”, come precisa Francesca Izzo; un “pensiero unico” che vorrebbe bellamente spazzare via teorie e pratiche guadagnate dal femminismo anni ’70 (il cui cardine si incentrava sulla differenza sessuale), ritenute da quest’ondata dilagante un’ammuffita anticaglia da “superare”; e in un luciferino gioco trasformistico, si approderebbe a una novella riedizione – sotto “travestite” spoglie – dell’ineffabile e immarcescibile dominio del neutro maschile.
Tra le voci più incisive ed esaurienti che si sono esposte per dire no, spicca per limpidità e assertività il libro Noi le lesbiche, preferenza femminile e critica al transfemminismo; vanno citate poi le traduzioni dalle opere di Sylviane Agacinski (per es. L’uomo disincarnato, prefazione di Francesca Izzo), Le avventure della libertà, di Francesca Izzo, Libertà in vendita, il corpo tra scelta e mercato, di Valentina Pazé, e mi scuso per le omissioni.
Ora è apparso Vietato a sinistra, dieci interventi femministi su temi scomodi (Lit edizioni, 2024), libro atteso, auspicato, di più, necessario: introduzione di Francesca Izzo cui seguono i saggi di (in ordine alfabetico) Silvia Baratella, Marcella De Carli Ferrari, Lorenza De Micco e Anna Merlino, Daniela Dioguardi, Caterina Gatti, Cristina Gramolini e Roberta Vannucci, Doranna Lupi, Laura Minguzzi, Laura Piretti, Stella Zaltieri Pirola.
Quali sono in estrema sintesi i temi esposti nell’agile ma sostanzioso pamphlet, quali i temi “vietati a sinistra”, che «hanno allontanato molte (me compresa) – scrive Izzo – da partiti e organizzazioni di sinistra»? Si dislocano in un arco tematico che va dall’affido condiviso, alla gestazione per altri (GPA), dall’identità/fluidità di genere alla prostituzione/sex work, alle norme anti-separatismo imposte dai regolamenti del terzo settore; temi visitati e interpretati secondo varie angolazioni e accenti, puntuali nel documentare episodi di censura, intimidazione, discriminazione; vicende vissute dalle autrici, episodi incresciosi, imbarazzanti, inquietanti.
«Vogliamo richiamare l’attenzione su alcune pratiche che impoveriscono lo spazio critico, un tempo fiore all’occhiello del campo dell’alternativa, e – inaudito – giungono a minacciare le donne indisponibili a sostenere presunti nuovi diritti sessuali quali la surrogazione della maternità, il blocco della pubertà, il lavoro sessuale… riferiremo solo alcuni episodi…», si legge nel saggio di Cristina Gramolini e Roberta Vannucci.
Non manca un’altra barbarie sessista: «Vorrei riflettere a cosa succede alle bambine, perché anche le bambine accedono alla pornografia… gli stupri sono comuni e la narrazione fa credere che alle donne possa piacere essere violentate», scrive Caterina Gatti, saldando prostituzione e pornografia, due questioni cruciali non separate tra loro.
Questioni divisive nel movimento delle donne, si sa: con grande coraggio il libro si assume il compito di affrontare tali argomenti “prendendo parola”, una parola scomoda, una parola audace: osa dire che il re è nudo; mettendola in circolo, restituendola alle tante – e io fra queste – che il femminismo l’hanno conosciuto, vissuto, praticato per anni, e ora sono sconcertate da come il mainstream della cultura dell’inclusione abbia deviato dalle premesse di giustizia sociale da cui era partita, stravolgendola, e si è giunti a invocare libertà – per qualcuno (al maschile) – che danneggiano o calpestano esistenze di altre (femminile), e chi non ci sta è omofoba o transfobica o fa discorsi d’odio.
Le questioni trattate quindi sono identificabili all’interno delle aree tematiche che ho menzionato; che, come si può capire, sono legate tra loro con un fil rouge, da una precisa economia simbolica, radicate in un impianto politico, filosofico e di diritto sessuato che lo sorregge, impianto acutamente argomentato nella introduzione di Francesca Izzo, dove le tessere del discorso sono poste e sviluppate in una prospettiva di politica sessuale coerente con l’eredità del femminismo.
«I problemi che ci stanno di fronte non sono affrontabili accumulando e sovrapponendo diritti, si tratta invece di rivoluzionare i fondamenti della cittadinanza perché l’ingresso delle donne significa la rottura e lo sconvolgimento degli assetti istituzionali. La logica dei diritti impedisce di “vedere” questi dati sistemici e punta invece a neutralizzarli con un approccio individualistico e neutro-maschile. Mai come dalla prospettiva delle donne il paradigma individualistico… appare fuorviante. I risultati li abbiamo sotto gli occhi, con un uno scambio della concezione della libertà come affermazione positiva dell’integralità della persona con l’idea mercantile della libertà come assenza di vincoli nel disporre di sé sul mercato. Sino al punto di invocarla per giustificare la pratica della maternità surrogata, per ridurre la prostituzione a sex work, un lavoro come un altro, o per pensare la sessualità come scelta soggettiva, come nel caso dell’identità di genere».
L’idea di libertà si è inquinata, stritolata dalla morsa narcisistica dell’ultraliberismo. La tendenza che si sta affermando, dunque, è quella di rivendicare libertà in spregio alla benché minima idea di reciprocità e interdipendenza; rivendicazioni che sgomitano per emergere sopra le vite dell’altro/a, che si vuole tacitare o manipolare o dipingere come consenziente, in una relazione alla pari, dove invece tra i due si configura un rapporto di potere.
Molteplici sono gli elementi che sbalordiscono in questo delirio idolatrico: una sistematica appropriazione di elementi della soggettività femminile; un oblio o un travisamento della cultura femminista, tra cui spicca l’irrilevanza del corpo, oscurato nella celebrazione dell’identità di genere (essendo il genere una costruzione sociale performativa che si declina in pura esperienza interiore, personale, svincolata dalla corporeità); la confusione di elementi contraddittori: «Contemporaneamente si moltiplicano gli appelli per la parità e il rispetto per le donne… e sono molto partecipate le manifestazioni al grido di “donna, vita, libertà”. Tante, in questa confusione di parole e di slogan, non vedono il punto in cui l’esecrazione della violenza domestica si trasforma in acclamazione della violenza a pagamento nella prostituzione e nella GPA», scrive Stella Zaltieri Pirola.
Fanno parte di quest’atmosfera mafiosa l’intolleranza, l’insulto, l’ingiuria, il boicottaggio, lo screditamento sul piano politico per chi si sottrae al «conformismo ideologico che vuole fare piazza pulita della pluralità delle idee… la nuova intolleranza di chi impone il pensiero unico» (Daniela Dioguardi); per chi pensa che sex work, GPA, ecc. siano un arretramento, non un progresso, e lo si bolla di moralismo, oscurantismo e di collusione con la destra. E nemmeno ci si prende l’onere di argomentare le proprie ragioni, si squalifica e basta; tecniche tipiche dei regimi autoritari, messe in atto anche nel consenso acritico e conformista nel dibattito pubblico veicolato dai media, medusizzati dal progressismo di cui sopra. «L’accusa di moralismo sposta immediatamente le posizioni contrastanti da un piano che dovrebbe essere di parità antagonista a un piano dove una delle due parti è automaticamente preminente: l’una progressista, l’altra retrograda» scrivono Lorenza De Micco e Anna Merlino.
Una delle parole d’ordine è “autodeterminazione”. È bene soffermarsi su questa pietra miliare del movimento degli anni ’70, anch’essa stravolta: «Con lo slogan (“L’utero è mio e lo gestisco io”) non si mutilavano i corpi. Negli anni Settanta quelle parole erano antitetiche a una visione che istituisce una barra di separazione tra mente e corpo: l’utero/corpo non era assolutamente vissuto come strumento di cui si poteva disporre, anzi, ci si opponeva radicalmente alle logiche biopolitiche strumentali, prefigurando piuttosto una riappropriazione di sé, del proprio organismo, nell’orizzonte di un insieme inscindibile di mente e corpo, di una ritrovata ricomposizione. L’impianto della regolamentazione (e della legittimità del sex work) si fonda, al contrario, su una disunione con il corpo, su un’ideologia di individualismo proprietario acquisitivo, da cui discende il disporre del proprio corpo, interpretato come “bene economico a disposizione”, strumento inscritto nell’orbita della merce: la dissociazione tra mente e corpo è evidente già in queste premesse di fondo… Comprendersi incarnati/e è assai più difficile che inneggiare alla libertà: una libertà che non fa i conti con il principio di realtà, che non accetta il limite, la relazione e l’esistenza dell’altra/o»2. Il brano è tratto da Religioni e prostituzione, le voci delle donne, dove il focus era il sistema prostituente; ma è possibile estendere le argomentazioni a tutta l’area delle questioni trattate in Vietato a sinistra, un pamphlet in cui si respira indubbiamente la voce femminile inaddomesticata, una voce che fin dalle origini del femminismo è sempre stata a favore della libera espressione e manifestazione dell’orientamento sessuale; ma come narrano con lucidità le donne di Noi le lesbiche, essere lesbiche non coincide con il conformismo ideologico dai tratti mafiosi così bene documentato in Vietato a sinistra.
La voce di una cristiana e femminista quale io sono è forse inopportuna, alla fin fine, in merito alle finalità del libro? Voci come la mia confermerebbero le accuse di moralismo e bigottismo che ci vengono rivolte?
La Chiesa cattolica, per lo più affossata in un clericalismo misogino, si è spesso pronunciata irriducibilmente contraria alle questioni qui esposte.
Ma non si cada in rozze semplificazioni. A volte le istanze convergono negli esiti finali, pur partendo da visioni e posizioni inconciliabili, nella teoria come nella prassi. Per esempio la Chiesa cattolica si colloca su posizioni di sostanziale esclusione dei gay all’interno nel clero, praticando così una inaccettabile discriminazione.
Non poche femministe cristiane, alcune presenti tra le autrici, partono quindi da assunti assai distanti da quelli dell’istituzione ecclesiastica; piuttosto hanno come apice quella carica sovversiva che è la libertà delle donne; hanno ben chiaro che «le religioni istituzionalizzate sono state il più fermo piedistallo della millenaria supremazia maschile» (Carla Lonzi)3, sono attrezzate e mature nell’operare discernimento sulla realtà di una Chiesa per lo più sessista, immersa in stereotipi antifemministi e per lo più maestra in strategie mafiose (occultate: vedi le dinamiche che la coinvolgono negli abusi di coscienza e sessuali) per ostacolare la presenza delle donne, per umiliarle, per inferiorizzarle.
Ripeto: alcuni posizionamenti possono avere esiti simili, ma hanno radici differenziate. Rigettiamo l’accusa di moralismo: i nostri cammini e la teologia femminista a cui ci richiamiamo sono esempi di spirito libero antidogmatico. Pensiamo e agiamo senza preoccupazione alcuna di un possibile accordo o disaccordo con l’insegnamento disciplinare della Chiesa. L’energia della Ruah affiancata alla luce della fede (e non della religione) ci sono compagne, in armonia con le parole di Simone Weil: «… Non riconosco alla Chiesa alcun diritto di limitare le operazioni dell’intelligenza o le illuminazioni d’amore nell’ambito del pensiero»4.
(Paola Cavallari)
Note
1. Alessandra Bocchetti (2013), “Il diritto alla felicità”, intervista ad Alessandra Bocchetti realizzata da Barbara Bertoncin, in Una città, 200, febbraio 2013.
2. Paola Cavallari, Doranna Lupi, Grazia Villa (a cura di), Religioni e prostituzione. Le voci delle donne, VandA edizioni, 2024.
3. Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, Rivolta femminile, 1970, p. 16.
4. Simone Weil, Lettera a un religioso, Adelphi, 1996, p. 91-92.
Da L’indiscreto – Nel 1390 Sibilla Zanni e Pierina Bugatis, due contadine milanesi, furono bruciate sul rogo in piazza Sant’Eustorgio, o in piazza Vetra, a seconda dei resoconti. La loro colpa era quella di far parte di una misteriosa società capeggiata da Madonna Oriente. Sibilla e Pierina erano state condannate a morte in seguito a due processi, il primo dei quali si era però concluso con una lieve condanna: frate Ruggero, il primo degli inquisitori, riconobbe che Sibilla e Pierina avevano creduto ingenuamente alle promesse di Madonna Oriente, come quella di poter resuscitare i morti. Nel secondo processo, le due donne ammisero però di partecipare ancora al “gioco” di Madonna Oriente, soprannominata Domina Ludi, riunendosi con lei una volta a settimana per mangiare carne e compiere riti. Stavolta la condanna fu severa ed esemplare: Sibilla e Pierina non si erano limitate a credere, ma avevano continuato a giocare.
La filosofa femminista Luisa Muraro ha raccontato questa storia in un celebre libro del 1976, La signora del gioco, in cui sostiene che la caccia alle streghe sia stata «un collasso di certi confini tra fantasia e realtà», dove la dimensione del sogno e la capacità di mediazione femminile con la natura sono state brutalmente represse dall’ordine patriarcale.
Il gioco, ancora oggi, è una dimensione negata alle donne, sia simbolicamente che materialmente. Secondo il Gender Equality Index dell’Istituto europeo della parità di genere, solo il 29% delle donne ha tempo per svolgere attività sportive, culturali o ricreative fuori casa più di una volta a settimana. I dati Istat sull’Italia confermano che le donne usufruiscono più degli uomini dell’intrattenimento culturale (libri, cinema, teatro), ma quando si tratta di attività che coinvolgono il gioco, come lo sport o andare allo stadio, sono in netto svantaggio. Le donne non solo hanno meno tempo libero degli uomini, perché sono oberate dal doppio carico di lavoro salariato e domestico, ma per loro la dimensione ludica sembra preclusa a un livello più profondo, come denunciato da Muraro.
Il gioco, scrisse Johan Huizinga nel suo classico del 1938 Homo Ludens, «è innegabile»: «Si possono negare quasi tutte le astrazioni: la giustizia, la bellezza, la verità, la bontà, lo spirito, Dio. Si può negare la serietà. Ma non il gioco». Il gioco travalica la biologia e la cultura; anzi, sostiene Huizinga, alla cultura è precedente, perché gli animali non hanno imparato a giocare dagli esseri umani. Anche da adulti, gli esseri umani continuano a cercare spazio per il gioco nelle proprie vite, dai giochi di società, ai giochi a premi televisivi, passando per il gioco d’azzardo. Negli ultimi vent’anni, il gioco prende sempre più spazio nelle vite degli adulti, come dimostra l’enorme mercato videoludico (un’industria in crescita da 217 miliardi di dollari) e il fenomeno della gamification, che inserisce le dinamiche del gioco in settori che ne sarebbero privi, se non antitetici, come la scuola o il lavoro.
Le donne, però, continuano a restare fuori dai giochi. Come fece Olympe de Gouges nel 1791, chiedendosi se la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo” riguardasse i diritti della donna, bisogna chiedersi se l’“homo” di “homo ludens” si riferisca al genere o alla specie.
Il gioco delle donne viene socialmente sanzionato, a differenza di quanto accade per gli uomini che sono più liberi di esprimersi come homini ludentes. All’uscita del film di Greta Gerwig Barbie nel 2023, molti critici uomini rimanevano sconcertati all’idea che fosse stato realizzato un film su una bambola e che fosse piaciuto a un pubblico così vasto. Una delle critiche principali stava proprio nel fatto che il film fosse in realtà un’operazione commerciale per «vendere più Barbie», una critica che si potrebbe applicare alle decine di film sui supereroi che da vent’anni escono a cadenza regolare, producendo un’enorme quantità di action figures e merchandise. Ma le critiche al Marvel Cinematic Universe, che di certo non mancano, si basano più sulla qualità dei prodotti audiovisivi che sul pericolo che possano indurre degli adulti a giocare con le bambole. Eppure il mercato delle action figures, dominato dagli uomini, supera di più di un miliardo di dollari quello del collezionismo di bambole.
Ciò che ha dato scandalo di Barbie, o forse non è stato compreso fino in fondo, è proprio la celebrazione del gioco e del divertimento che, se associata al genere femminile, non può mai essere fine a se stesso: Barbie è «carino ma non molto profondo», ha scritto il Time; è soltanto «nostalgia celebrativa per un giocattolo», ha scritto il Guardian. Per le donne, cui viene inculcato subito un enorme carico di responsabilità e cura, il gioco deve per forza finire nell’infanzia e, se prosegue nell’età adulta deve trovare una giustificazione plausibile.
Secondo Simone de Beauvoir, la manipolazione che confonde il gioco con il dovere comincia sin dall’infanzia: i maschi sono incoraggiati a giocare “a essere e fare”, due verbi indistinti, mentre le femmine sono incoraggiate a ripetere il modello materno con il gioco delle bambole. Anche le faccende domestiche sono presentate come un gioco, attraverso un meccanismo di retribuzione che si ripeterà poi nella vita adulta. Per la massaia, fare la spesa, strappare il prezzo più basso al commerciante, montare gli albumi, fare la marmellata diventano gli unici divertimenti possibili in una vita altrimenti priva di ogni altro piacere. Oggi, in una società in cui le donne non sono più solo schiave del focolare, questi divertimenti casalinghi sono sostituiti soprattutto dalla moda, dal trucco e dalla cura di sé, regni del piacere femminile che però concorrono inevitabilmente all’accumulazione del capitale erotico.
Il gioco, quindi, serve a rinforzare un ruolo piuttosto che a costruire un’identità basata sulla libertà di azione. Quando quel ruolo è stato ricoperto nell’età adulta, allora il gioco delle donne va o capitalizzato o strappato nei ritagli di tempo.
L’interdizione delle donne dal gioco senza altro fine se non il piacere è dimostrata ampiamente dalla loro esclusione dall’industria videoludica. Le donne, in realtà, giocano molto ai videogiochi: secondo il rapporto di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) il 38% dei e delle gamers in Italia sono donne; negli Stati Uniti, la percentuale si alza al 46%. Tuttavia, il settore resta dominato dai maschi, che costituiscono la stragrande maggioranza dei lavoratori nell’industria e il genere più rappresentato nei videogiochi. Anche il modo di giocare è diverso: quasi il 70% delle donne usa solo mobile, una modalità che consente di giocare anche per brevissimi periodi di tempo senza interferire troppo nel resto delle attività quotidiane.
Le incursioni delle donne nella fortezza machista dei videogiochi sono punite non solo a livello simbolico, ma anche materiale. Nel 2014 il Gamergate, un’enorme campagna di molestie e doxxing [divulgazione pubblica non autorizzata dei dati privati della vittima, Ndr] ai danni di videogiocatrici, giornaliste e lavoratrici dell’industria videoludica, dimostrò che nel settore non solo le donne non sono le benvenute, ma vengono anche punite per la loro presenza. Le campagne, condotte rigorosamente in modo anonimo, colpivano donne identificabili con nome e cognome. Ancora oggi, molte donne che giocano in multiplay si fingono uomini per evitare di essere molestate.
Il “gioco” della Signora del gioco, una figura misteriosa che compare in numerosi processi per stregoneria nell’Italia settentrionale, è il sabba. Muraro lo descrive non tanto come un momento di trasgressione e divertimento, ma come uno spazio di alleanze femminili e di fuoriuscita dal reale, dove le fatiche della sottomissione domestica possono essere dimenticate e si può costruire un mondo di fantasia, magia e comunione con la natura. La signora del gioco lascia doni nelle case delle donne che trova in ordine, poi le invita fuori a giocare nel sabba, per sperimentare una vita al di fuori dall’ordinario. L’ordine patriarcale non può tollerare il gioco, non perché metta in discussione la dottrina della Chiesa, ma perché col suo potenziale rivoluzionario fa uscire la donna dal ruolo che le ha sempre assegnato.
Cose da sapere:
«Nel III secolo a.C. il poeta greco Apollonio Rodio raccontava che Zeus avesse regalato a suo figlio Minosse, re di Creta, un gigante di bronzo chiamato Talos, dotato di intelligenza e capace di proteggere l’isola dagli attacchi nemici. Talos era stato programmato per svolgere un compito: difendere Creta, agendo autonomamente rispetto al controllo umano.
Sin dall’antichità l’uomo ha sempre cercato di realizzare macchine pensanti create con capacità superiori, come quelle di un dio. Se oggi chiudiamo gli occhi e pensiamo all’intelligenza artificiale, immaginiamo qualcosa di etereo, divino, che può distruggere l’uomo, ma può anche permettergli di fare scoperte straordinarie. Qualcosa di astratto: una serie di codice blu, un robot bianco, la nuvola del cloud che contiene, gestisce ed elabora i nostri dati in uno spazio indefinito.
Eppure l’intelligenza artificiale ha una natura estremamente materica, ha un legame molto forte con la terra, che viene sfruttata per estrarre i minerali critici necessari per la produzione di batterie che ne determinano l’esistenza. Finora, l’elemento fondamentale che ci permette di usare ChatGpt è il litio, definito anche “oro bianco”*.
I giacimenti di questo metallo sono principalmente nelle salamoie dell’America Latina: soluzioni saline naturali ricche di minerali, che si trovano in grandi laghi salati in regioni aride o semiaride. Le più famose sono il Salar de Uyuni in Bolivia – che contiene circa il 60% delle riserve mondiali di litio – il Salar de Atacama in Cile e il Salar del Hombre Muerto in Argentina.
Secondo le leggende Aymara, il Salar de Uyuni nasce dalle lacrime e dal latte materno di Tunupa, un vulcano femmina che aveva partorito un bambino che le era stato rubato. Ricordando questo antico mito, il regista australiano Liam Young ha detto che «il nostro smartphone funziona con le lacrime e il latte materno di un vulcano e che questo paesaggio – nel sud-ovest della Bolivia – è collegato a ciascuno di noi tramite fili invisibili di commercio, scienza, politica e potere». Ci sono giacimenti di litio anche in Africa occidentale e poi in Australia e in Cina, dove le riserve ammontano rispettivamente a 4,7 milioni e 1,5 milioni.
Squilibrio idrico
Il litio può essere estratto in due modi: dalle formazioni rocciose solide, utilizzando una tecnica tradizionale simile all’estrazione mineraria, o attraverso l’essiccazione di grandi laghi – come avviene in America Latina – tramite un processo di evaporazione solare. Le salamoie vengono pompate in grandi vasche dove l’acqua evapora sotto il sole, lasciando un concentrato di minerali da cui si estrae il metallo. Per ricavare il materiale in questi bacini salati occorrono 1,8 milioni di litri d’acqua per tonnellata di litio.
Nelle salamoie dell’America Latina, lo squilibrio idrico ha provocato un aumento della siccità e della desertificazione. Il rilascio di sostanze tossiche utilizzate nell’attività estrattiva ha impoverito e inquinato le falde acquifere. Nel Salar di Atacama, in Cile, l’estrazione del litio ha consumato il 65% della quantità d’acqua presente, aggravando la crisi idrica che il paese stava già affrontando.
Inoltre, l’industria dell’oro bianco produce emissioni di anidride carbonica, che variano dalle 5 alle 15 tonnellate per singola tonnellata di litio estratto. Lo sfruttamento di queste terre ha un impatto molto forte sulle comunità che le abitano.
In Cile, in Bolivia e in Argentina è in atto una dura repressione delle popolazioni indigene che cercano di resistere all’imporsi delle attività estrattive nella regione. Mentre sono 100 milioni le persone nel mondo – tra bambini, donne e uomini – che lavorano in condizioni di sfruttamento all’estrazione del litio, soprattutto in Africa occidentale.
Estrattivismo
Lo svuotamento dei materiali della terra e della biosfera è strettamente connesso a un altro tipo di estrazione: la cattura e monetizzazione dei nostri dati. Maggiore è la quantità di dati che l’intelligenza artificiale richiede per funzionare, maggiore è l’energia che verrà impiegata per immagazzinarli e aggregarli. Maggiore è l’energia di cui i sistemi di Ia hanno bisogno, maggiore sarà l’approvvigionamento di minerali critici come il litio.
Questa interconnessione tra la estrapolazione dei dati personali delle persone e quella dell’oro bianco rientra nel concetto che Sandro Mezzadra, professore di filosofia politica all’Università di Bologna, definisce come estrattivismo. «Questo termine nasce in America Latina e si riferisce all’industria estrattiva in senso letterale, ai grandi progetti minerari che in quella parte del mondo sono sempre stati fattore fondamentale di integrazione all’interno del mercato mondiale sin dal XVI secolo», spiega Mezzadra.
«Successivamente, il concetto di estrattivismo assume un significato più ampio, riferendosi all’agricoltura estensiva e a come le attività estrattive determinano espulsione e spostamento di popolazioni indigene fin dagli anni Novanta. Io personalmente ho trascorso molto tempo in America Latina e ho maturato delle perplessità nei confronti di una focalizzazione esclusiva sulle attività estrattive in senso letterale. Nei primi anni Duemila ho incominciato a lavorare con una mia amica argentina, Verónica Gago, che stava facendo una serie di ricerche sulla penetrazione della finanza all’interno delle economie popolari del Sud America. Quello che emerge è la natura fortemente estrattiva del capitalismo contemporaneo».
Amazon Echo
Questo concetto viene ripreso anche nel lavoro della ricercatrice australiana Kate Crawford, che, per spiegare la correlazione tra estrapolazione e manipolazione dei dati, estrazione dei materiali e lavoro povero, ha deciso di tracciare l’intero ciclo di vita di un singolo prodotto: Amazon Echo.
Il suo progetto – che è anche un libro – si chiama Anatomia di un Sistema AI. Attraverso delle mappe viene spiegato il ciclo di Echo, dall’estrazione del litio per costruirlo fino alla fine della sua vita nelle discariche di rifiuti tossici in Pakistan e in Ghana dove si trova il cosiddetto “cimitero dell’e-waste” che impiega circa 70mila persone, tra cui migliaia di bambini che sono costretti a raccogliere rifiuti pericolosi a mani nude per pochi centesimi al giorno.
«Le piattaforme digitali sono attori capitalisti che valorizzano e accumulano capitale attraverso operazioni estrattive», dice Mezzadra, «c’è una correlazione tra l’estrazione dei materiali e quella dei dati, ma c’è anche un elemento che differenzia queste due operazioni: le risorse naturali come il litio esistono in natura, i dati invece sono prodotti attraverso le interazioni umane. E poi c’è l’obiettivo finale che unisce i punti di queste due attività estrattive: il profitto, che ha delle ricadute immediate nel nostro quotidiano. È una costruzione di mondi al cui interno ci muoviamo e veniamo mossi, sempre più manipolati e orientati».
(Facebook, 21 giugno 2024)
(*) Nota della redazione del sito
Il litio, elemento che moltissime applicazioni di varia natura (dalla psichiatria, alla produzione di vetri e ceramiche e di grassi lubrificanti) viene anche utilizzato per la costruzione di batterie (27% della produzione), in particolare per le auto elettriche e i dispositivi portatili, tra cui pc tablet e telefonini. Non ha un legame diretto con l’intelligenza artificiale, ma un rapporto mediato perché l’IA si “nutre”, per sua stessa natura, delle informazioni presenti sulla rete informatica, e quindi delle innumerevoli informazioni che vengono prodotte tramite questi dispositivi. L’importanza che ha attualmente dipende soprattutto dal ruolo centrale che ha nella produzione di auto elettriche o ibride, ma comunque il suo maggiore utilizzo (29% della produzione) riguarda le ceramiche e il vetro.
Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Heide Goettner-Abendroth, quando nel 2014 l’ho invitata a parlare alla Libreria delle donne di Milano delle sue ricerche, sfociate nel libro Le società matriarcali. Studi sulle culture indigene nel mondo” (Venexia 2013).
Ho grande ammirazione sia per il suo coerente e coraggioso percorso di studiosa sia per gli straordinari risultati della sua ricerca.
Infatti dal 1973 al 1983 Heide Goettner-Abendroth aveva insegnato filosofia e teoria della scienza all’università di Monaco ma contemporaneamente, analizzando studi di archeologia, linguistica, antropologia, dunque con un metodo interdisciplinare, cominciava a rendersi conto che il Matriarcato non è il “dominio o regola delle madri”, non è quindi equiparabile al Patriarcato che correttamente significa “dominio o regola dei padri”. Entrambi i termini sono composti da archē che oltre a ‘dominio’ ha anche il significato di ‘origine’, ‘inizio’, come troviamo nelle parole archeologia, studio delle origini, e archetipo, prototipo originale. Matriarcato significa dunque ‘in principio le madri’. Infatti, se attraverso la documentazione storica ed etnografica si cercano società dominate dalle madri o dalle donne, è impossibile trovarle perché il porre all’origine le madri produce una diversa forma sociale.
Già nel 1976 presentò al pubblico i suoi primi risultati che divennero nel 1980 il libro in tedesco La dea e il suo eroe, tradotto quindici anni dopo in inglese e che prossimamente verrà tradotto anche in italiano da Gabriella Galzio.
Nell’università però non vi era spazio per queste ricerche, infatti vigeva, come spesso anche oggi, quella che la storica María-Milagros Rivera Garretas chiama violenza ermeneutica. Quindi nel 1983, ormai 40 anni fa decise di non insegnare filosofia ma di dedicarsi completamente agli studi matriarcali e nel 1986 fondò l’International Academy Hagia (www.hagia.de) per gli Studi Moderni sul Matriarcato e la Spiritualità Matriarcale, che con Cécile Keller dirige ancora oggi.
Mi è parso significativo il suo percorso in cui, madre di due figlie e un figlio, ha saputo lasciare una posizione consolidata per continuare ad approfondire e diffondere le sue scoperte.
È oggi riconosciuta come la fondatrice degli Studi Matriarcali moderni, un nuovo campo epistemologico che ha messo a punto una definizione strutturale della forma sociale matriarcale. Decenni di studi antropologici e viaggi presso società matriarcali tuttora esistenti, ma anche donne e uomini di queste società le hanno fornito molte informazioni e confermato molte ipotesi, messe a confronto nei diversi convegni internazionali, da lei promossi, come nel 2003 in Lussemburgo, nel 2005 a San Marcos (Texas), nel 2009 a Roma, Milano e Bologna e nel 2012 a San Gallo in Svizzera. Dall’edizione canadese degli Atti del convegno del 2005 sono stati pubblicati in italiano, nel libro Società di pace. Matriarcati del passato, presente e futuro (Castelvecchi, 2018), curato da Luciana Percovich, alcuni saggi generali anche con uno sguardo ampio sulle caratteristiche di alcune società matriarcali delle Americhe, dell’Asia e dell’Africa.
Leggendo i suoi libri ricchissimi non solo di informazioni ma di connessioni che portano a un nuovo paradigma interpretativo della società, provo grande riconoscenza, come del resto è avvenuto e avviene da parte di molte donne, infatti è stata eletta una delle mille Donne di Pace del mondo e candidata ben due volte al Premio Nobel per la Pace ed è stata posta in suo onore una pietra nel Frauen-Gedenk-Labyrinth di Francoforte.
Quali caratteristiche presenta la forma sociale matriarcale da lei delineata?
A livello economico, poiché le donne gestiscono i beni essenziali come la terra, la casa, il cibo e cercano di bilanciare la ricchezza con la redistribuzione, senza accumulazione ma attraverso il dono, possiamo parlare di società di reciprocità basate su un’economia in equilibrio, un’economia del dono di origine materna, in cui vi è la pratica del dare doni non quella dello scambio del mercato, come ci ricorda anche Genevieve Vaughan (Per-donare. Una critica femminista dello scambio, Meltemi 2005).
A livello sociale la maternità è considerata la funzione basilare perché crea le nuove generazioni ma non è necessario essere madri biologiche perché la maternità è condivisa tra sorelle. Si vive in clan legati dalla parentela matrilineare e spesso matrilocali (residenza presso la madre) dove i sessi hanno lo stesso valore (parità di genere) pur avendo ciascuno una propria sfera di attività: ad esempio le donne sono socialmente al centro della vita collettiva e gli uomini sono rappresentanti del clan all’esterno.
A livello politico si tratta società del consenso dove le decisioni vengono prese localmente nelle case del clan e, solo quando si raggiunge una decisione condivisa, la si mette in pratica e, se coinvolge altri clan, si delega agli uomini di essere i portavoce del clan in incontri allargati, dove le decisioni sono solo comunicate ma non modificate.
A livello culturale si può parlare di cultura sacra perché basata su una profonda visione in cui il divino è immanente e tutto il mondo – uomini, donne, piante, animali, pietre, corpi celesti – è considerato divino, un divino femminile. L’universo è frutto della creazione di una grande madre e le feste, che seguono i ritmi della vita e delle stagioni, celebrano la natura nelle sue infinite manifestazioni. Non c’è separazione tra sacro e profano e c’è continuità tra vivi e morti perché si crede che gli e le antenate si reincarnino.
Farsi guidare da una definizione strutturale, come quella sopra presentata, non significa proiettare un tipo ideale di società fisso e immutabile ma di contribuire a un processo creativo di «comprensione ricettiva ma rigorosa delle variegate forme sociali matriarcali esistenti», utilizzabile anche per interpretare i reperti e i risultati archeologici. Heide Goettner-Abentroth ha potuto infatti nell’ultimo decennio sviluppare ed esporre la storia culturale delle società matriarcali e affrontare il problema dell’origine del patriarcato, un processo protrattosi per millenni, in luoghi e tempi diversi.
E lo ha fatto nel suo ultimo libro Le società matriarcali del passato e la nascita del patriarcato. Asia Occidentale e Europa (Mimesis 2023)appena tradotto in italiano da Luisa Vicinelli e Nicoletta Cocci del collettivo Le matriarcali che in Italia promuove con diverse iniziative i moderni studi matriarcali (https://lematriarcali.wordpress.com/).
Leggere questo libro è stata per me una triplice avventura della conoscenza, quel conoscere che ti trasforma. Innanzi tutto ho potuto seguire, come in un giallo, il modo in cui l’autrice smantella le false interpretazioni ideologiche presentando e confrontando le scoperte archeologiche fra loro e con le società matriarcali del presente e disvelando così quelle che finora erano confuse rappresentazioni delle società dei primordi per farci credere che la civiltà nasce con le forme patriarcali di dominio.
La seconda avventura è stata viaggiare, partendo dall’Africa, attraverso soprattutto i territori dell’Europa e dell’Asia Occidentale insieme alle popolazioni antiche ma anche alla scoperta delle centinaia di siti archeologici imparando a vedere segni che prima erano indecifrabili o interpretati in modo proiettivo e approssimativo: una guida affascinante anche per i miei futuri viaggi.
La terza avventura è stata andare nel passato dell’umanità scoprendo il modificarsi di strutture economiche, sociali, politiche e culturali e riconoscere le diverse origini del patriarcato e le forme di resistenza al suo lento instaurarsi in modi differenti.
In ogni pagina ho trovato sempre tre o quattro informazioni, interpretazioni, immagini del tutto nuove per me, pur essendo io stata un’insegnante di storia. Leggere per la seconda volta le 550 pagine del testo si è rivelata un’esperienza piena di sorprese perché ho potuto soffermarmi su particolari delle prove che via via l’autrice presentava e cogliere anche il suo stile nel dialogare con interpretazioni proiettive del presente sul passato di alcuni archeologi, un dialogo a volte ironico ma molto ben documentato (tra bibliografia e autorizzazioni delle immagini vi sono oltre venti pagine).
L’autrice, dopo un’introduzione in cui si sofferma su come si sono sviluppati i moderni studi matriarcali, nel primo capitolo rifiuta la divisione tra storia e preistoria perché implica lo svilimento e la deformazione delle conquiste non solo intellettuali dell’umanità antica e propone invece primevo e primordi. Dimostra la falsità dell’ideologia della guerra infinita, che legge, ad esempio, ogni resto di muro come fortificazione contro nemici e non come protezione da inondazioni o da animali e ogni cimitero collettivo come frutto di violenza e non come forma di culto per le e gli antenati. Un’ideologia di cui oggi, più che mai, avvertiamo la grande pericolosità, perché porta a una svalutazione della pace intesa solo come assenza di guerra e non invece come l’invenzione e messa in pratica di strategie per la risoluzione dei conflitti. Non si tratta dunque di parlare di società pacifiche, in cui non avvengono conflitti ma in cui essi possono sfociare in faide non in guerre perché non vi sono strutture organizzate come gli eserciti. Si tratta invece società in cui la violenza non è glorificata e, quando nascono conflitti, vengono risolti, ad esempio, con alleanza tribali o con matrimoni tra clan o con accordi rituali.
Gli altri sette capitoli sono strutturati in maniera simile tra loro e ciascuno è dedicato a un periodo preciso. Si aprono con una tabella cronologica, una descrizione degli ambienti e degli spostamenti delle popolazioni e una mappa in base ai ritrovamenti archeologici.
In quello dedicato al Paleolitico e nei due al Neolitico, seguendo un vasto percorso temporale e geografico, vengono delineate società con caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali complesse, capaci dell’uso di simboli, grazie a un’attenta e non ideologica interpretazione delle evidenze archeologiche, ad esempio nel Paleolitico le pitture parietali, le statuette femminili, i cimiteri collettivi o nel Neolitico le costruzioni megalitiche, i palazzi di Creta, le forme di irrigazione artificiale in Mesopotamia.
Nel quarto capitolo sull’età del bronzo nella steppa euroasiatica si descrivono le società del primo nomadismo con le loro iniziali forme di dominio e si mostra la resistenza delle donne, in particolare si affronta la questione delle Amazzoni.
Negli ultimi tre vengono presentate le diverse situazioni nell’età del bronzo e del ferro: dapprima si vede in Asia occidentale la nascita della forma stato e poi impero e l’inizio di una teocrazia che abolisce la Dea per giungere al monoteismo, poi si esamina come nell’Europa meridionale resistono le società tardo matriarcali, ad esempio in Sardegna, a Creta, in Etruria. Infine a Nord delle Alpi si mostra la permanenza di elementi matriarcali in società patriarcali come tra i popoli celtici e germanici.
Ogni capitolo è corredato da una documentazione di immagini e al termine troviamo una sintesi del capitolo e una definizione del periodo.
La struttura del libro dunque lo rende anche un’opera di facile consultazione, di cui possiamo rileggere anche solo quei capitoli sui periodi, sulle popolazioni, sui temi che più ci interessano.
Posso aggiungere che questa lettura mi ha trasformato nel senso di avermi fatto riconoscere e radicare nel tempo e nello spazio modalità di comportamento mie, di amiche e anche di uomini a me vicini, che prima vedevo in gran parte come caratteristiche individuali ed estemporanee.
Nota: La videoregistrazione dell’incontro del 3 marzo 2024 alla Libreria delle donne di Milano con Heide Goettner-Abentroth dal titolo Quando la civiltà era più umana si trova nel canale YouTube nel sito della Libreria al seguente link:
(*) Luciana Tavernini è impegnata nelle attività della Libreria delle donne di Milano. Ha partecipato fin dall’inizio alla Pedagogia della differenza e alla Comunità di pratica e riflessione pedagogica e ricerca storica, successivamente alla Comunità di Storia vivente di Milano e ora SAMI. Tiene con Marina Santini il corso Historia viviente al master in Studi della differenza sessuale presso l’Università di Barcellona. Con altre ha scritto Libere di esistere (SEI, 1996), Mia madre femminista. Voci da una rivoluzione che continua (Il Poligrafo, 2015), Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione (VandA e-publishing, 2019), La spirale del tempo. Storia vivente dentro di noi (Moretti & Vitali, 2019). Traduce e scrive saggi per diverse riviste.
(AP-Autogestione e politica prima, a. XXXI, n. 2/3, aprile-settembre 2024, pp. 11-13)