da Il Domani
Le motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio aggravato di Giulia Cecchettin depositate in data 8 aprile dalla Corte di assise di Venezia ci restituiscono una fotografia nitida della violenza sessista che ha portato alla morte di una giovane donna intenta a realizzare sé stessa in un mondo fatto di relazioni significative che le hanno consentito di porre un freno, interrompendo la relazione sentimentale, a una dinamica di possesso insostenibile. Vengono riconosciute le aggravanti della premeditazione e della relazione affettiva, mentre non viene riconosciuta quella della crudeltà. È importante, però, chiarire che nel diritto penale l’aggravante della crudeltà non coincide con il senso comune di ciò che può essere ritenuto “crudele”. Tecnicamente, questa aggravante presuppone che l’autore del reato abbia inflitto alla vittima sofferenze ulteriori, non necessarie rispetto alla volontà di uccidere e finalizzate ad accrescere il dolore. Non è, quindi, quella della sentenza una valutazione morale o simbolica, ma una definizione giuridica legata all’intenzione dell’autore di accanirsi contro la vittima oltre la finalità omicida. La sentenza chiarisce dunque questo aspetto della condotta di Turetta, ma nell’insieme sgretola la narrazione tossica del raptus, della fragilità per la delusione o della “sofferenza d’amore” dell’uomo che uccide e smentisce ogni tentativo di patologizzazione dell’autore del reato evidenziandone la piena lucidità, la freddezza, la determinazione con cui Turetta ha perseguito e poi ucciso Giulia Cecchettin. Ha agito non per disperazione, ma perché non accettava che la “sua” donna fosse libera. Non tollerava che Giulia Cecchettin potesse autodeterminarsi, vivere la propria vita, studiare, stare con i propri amici e scegliere per sé senza di lui. La pretesa di esclusività su Giulia Cecchettin che risulta provata nel processo penale è il cuore della dinamica possessiva che ha alimentato il controllo e la negazione dell’altra nella sua soggettività.
Colpisce la violenza sottile ma sistematica che precede il femminicidio: non ci sono solo i momenti eclatanti di aggressività o di minaccia, ma un costante tentativo di sottrarre a Giulia Cecchettin ogni autonomia sulla propria esistenza: il controllo sul rendimento universitario, la richiesta ossessiva di sapere dove fosse e con chi, la svalutazione delle sue scelte, la pressione psicologica mascherata da “sofferenza d’amore”. Le parole di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, vengono riprese dai giudici di Venezia per descrivere questa dinamica: la paura “di lui” si trasformava nella paura “per lui”, alimentata dal ricatto emotivo del suicidio, dalla narrazione vittimistica di un uomo che minacciava di farsi del male per punire l’indipendenza di Giulia.
Ma questo “male di vivere” ostentato da Turetta non trova riscontro nella realtà processuale: il professionista che seguiva Turetta, infatti, non ha rilevato alcuna psicopatologia né ha mai registrato una richiesta di aiuto per intenti autolesionistici, bensì solo una volontà precisa di dominare e annientare. Le minacce di autolesionismo erano, dunque, un ulteriore strumento di controllo, usato per impaurire Giulia, per manipolarla, per colpevolizzarla della sua scelta di libertà. E una dinamica che nei centri antiviolenza gestiti da Differenza Donna conosciamo molto bene: le donne ci raccontano spesso che la paura per la vita dell’ex partner maltrattante o persecutore – insinuata da lui stesso – diventa una gabbia ulteriore, fatta di responsabilità rovesciata, isolamento, non di rado alimentata da un discorso pubblico che accusa ciascuna per non aver fatto abbastanza per prevenire un danno, nella logica stereotipata della considerazione per cui “forse se l’è cercata”, con i suoi comportamenti, con le sue scelte, anche con la sua fragilità, di cui si è sempre un po’ colpevoli.
Questa sentenza è importante perché afferma con chiarezza che la violenza sessista fino al femminicidio è esercizio deliberato di potere, riconosce il contesto sessista in cui si è maturato il femminicidio di Giulia Cecchettin, fornendo al contempo la misura di una chiara consapevolezza della giovane donna cui ha contribuito anche il cambiamento culturale e giuridico che, negli ultimi anni, ha nominato la violenza per ciò che è, incoraggiando a riconoscerne le radici strutturali. La parola “femminicidio”, oggi presente nel nostro lessico giuridico e nel dibattito pubblico, non è solo una definizione tecnica, ma il risultato di un lavoro politico, sociale e culturale, è oggi un terreno di conflitto simbolico e concreto, che impone di interrogarsi sul senso della giustizia e di cambiare la domanda che ci poniamo dinanzi alla questione sociale della violenza sessista: perché ancora gli uomini credono di poter disporre della vita di una donna? Anche le parole del diritto hanno confermato ciò che Giulia aveva già capito: che la libertà femminile è intollerabile per chi concepisce l’amore come possesso e, proprio per questo, non dobbiamo smettere di affermarla e difenderla attraverso le pratiche, le politiche e il diritto.
da Il Sole 24Ore
Niente più obbligo, per il giudice, nei casi di separazione, di adottare provvedimenti «con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli». Al magistrato è affidato solo il compito di disporre che «i figli minori restino affidati a entrambi i genitori». Ruota intorno al principio della bigenitorialità perfetta e dell’affido non condiviso ma paritetico, il disegno di legge 832 “Modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile e al Codice penale in materia di affidamento condiviso”. Il provvedimento in 18 articoli, all’esame della commissione Giustizia del Senato in sede redigente – ossia con una corsia accelerata che ne prevede l’arrivo in Aula blindato – è proposto da 14 senatori della maggioranza (Fdi e Noi Moderati). Primo firmatario è Alberto Balboni, Fratelli d’Italia, presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Relatore è Pierantonio Zanettin di Forza Italia.
Il Ddl, già ribattezzato “Ddl Salomone” nella petizione che ne chiede lo stop firmata da quasi mille persone in poche ore, rischia di mutare profondamente il Dna del diritto di famiglia e di incidere pesantemente sulla vita dei figli di genitori separati. Che in un batter d’occhio potrebbero ritrovarsi a fare la spola tra due case (è previsto l’obbligo di doppio domicilio), costretti alla pari frequentazione con entrambi i genitori stabilita da giudici che, di fatto, si troverebbero le mani legate. Eliminando il riferimento all’interesse del minore, infatti, sono gli adulti e i loro bisogni che assurgono al centro del nuovo diritto di famiglia. Da qui il soprannome di “disegno di legge Salomone”, dalla storia della Bibbia in cui il re noto per la sua saggezza, di fronte a due madri che si contendevano un figlio, suggerì di tagliare a metà il bambino per far emergere quale delle due tenesse davvero sua alla vita. Tagliare a metà i bambini di qualsiasi età è ciò che rischia di accadere nei tribunali italiani. «Gentile presidente Meloni – si legge in una lettera dell’associazione RadFem alla premier Giorgia Meloni – auspichiamo con questa nostra di avere sollecitato la sua attenzione su un disegno di legge che qualora perfezionasse il suo iter sarebbe all’origine di molte sofferenze e di molte ingiustizie ai danni dei bambini e delle loro madri».
Il precedente e la sede redigente
In principio fu Pillon, il senatore leghista che già nel 2018 tentò un giro di vite nella stessa direzione sulla legge 54/2006, quella che tuttora regolamenta in Italia l’affidamento condiviso dei figli di genitori separati. Ma dovette fermarsi di fronte all’ondata di contestazioni che da tutte le parti, in primis dal fronte delle associazioni femministe, piovvero sul suo Ddl: quel provvedimento venne accantonato e andò a finire su uno dei tanti binari morti in cui si dirottano le riforme velleitarie, prive di reale sponda politica. Questa volta, però, i numeri sulla carta ci sono tutti. E la sede redigente permette al nuovo disegno di legge di marciare a tappe forzate: dopo le audizioni – i gruppi ne hanno chieste oltre 60 – i senatori esamineranno e voteranno i singoli articoli in commissione per poi portare il testo perfezionato in Aula dove sarà votato o respinto. Senza alternative. Toccherà poi alla Camera esaminarlo, ma è evidente che a quel punto un passo di lato sarà molto più complicato.
Il mito della bigenitorialità perfetta
Tra i punti salienti contestati anche al Ddl Pillon c’è quello della bigenitorialità perfetta, da garantire a ogni costo. Oggi l’articolo 337-ter del Codice civile afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ogni genitore e «rapporti significativi» con i parenti e affida al giudice, in caso di separazione, il compito di adottare i provvedimenti «con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale» dei figli. Nella formulazione proposta dal Ddl 832, «il figlio minore ha diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con i parenti», mentre «il giudice che disciplina l’affidamento della prole dispone che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori» e che la collocazione nelle case sia paritetica. Il giudice in pratica scompare, ridotto a una sorta di passacarte, spogliato della funzione di valutare il supremo interesse dei bambini.
L’allontanamento in casa-famiglia per «gravi motivi»
Ma non solo. Torna in pista, con tanto di certificazione con il timbro della legge, il ricorso alla casa-famiglia, perché il giudice «può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, preferibilmente dell’ambito familiare o, nell’impossibilità, in una comunità di tipo familiare». Quali potrebbero essere i “gravi motivi” così genericamente definiti? In questi tempi bui in cui il costrutto ascientifico dell’alienazione parentale dilaga con i nomi più disparati (dal “rifiuto genitoriale” alla “madre ostativa”) nei tribunali civili da Nord a Sud della penisola, sembra davvero l’apertura di una autostrada per chi usa la clava dei mille volti della Pas per vendicarsi sulle madri, un assist alla violenza di Stato. Ad avvalorare questo sospetto c’è la relazione introduttiva al Ddl. «L’articolo 16 – si legge – potenzia le previsioni dell’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile intervenendo in tutte quelle situazioni in cui un genitore compie unilateralmente atti che richiedono l’accordo con l’altro, azzerando tali iniziative; ovvero nel caso in cui abbia costruito ad arte situazioni ostative al contatto del figlio con l’altro genitore».
Doppio domicilio e parità di frequentazione
L’esercizio della bigenitorialità imposta dall’alto poggia su alcuni pilastri, anche questi già presenti nel cestinato Ddl Pillon. Il primo è il doppio domicilio. All’articolo 1 si stabilisce che «il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive», «ovvero di entrambi se si trova in affidamento condiviso», prevedendo poi all’articolo 3 che «la responsabilità genitoriale è l’insieme dei diritti e dei doveri dei genitori che hanno per finalità l’interesse dei figli». Viene soppressa la facoltà dei genitori di stabilire in modo condiviso «la residenza abituale del minore». Una previsione, quella del doppio domicilio, che aveva già fatto storcere il naso a molti giuristi, che ne avevano ravvisato sia profili di incostituzionalità per l’indebita ingerenza dello Stato nella vita dei privati sia la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1950, secondo cui «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza».
Frequentazione paritetica e best interest del minore
Chiaramente la previsione del doppio domicilio è prodromica a un altro principio fissato nel Ddl e già sconfessato da diverse sentenze della Cassazione: quello dell’obbligo per i figli di alternarsi in modo paritetico tra l’abitazione materna e paterna, stabilito per i minori di qualsiasi età, anche neonati, senza alcuna valutazione del caso concreto. Fiumi di inchiostro sono stati versati sul principio del best interest [superiore interesse] del minore, che non dovrebbe mai sottostare alle esigenze degli adulti. La giurisprudenza degli ultimi anni si è affannata a sottolineare che il figlio dei genitori separati ha il diritto di non passare come un pacco da una casa all’altra senza soluzione di continuità ma che al contrario, proprio come la storia di Salomone insegna, i genitori devono saper fare un passo indietro e rinunciare al “possesso paritetico” del proprio figlio. La previsione del disegno di legge, invece, travolge l’istituto dell’assegnazione della casa familiare, disciplinato dall’articolo 337 sexies del Codice civile, ossia il concetto dell’abitazione presso la quale si è svolta abitualmente la vita domestica e il diritto dei figli di conservare l’habitat domestico senza dover pagare per la separazione dei genitori il prezzo di essere allontanati dal cuore delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Il mantenimento paritetico
Come conseguenza della pariteticità, il Ddl propone anche il mantenimento a carico di entrambi i genitori e la scomparsa della proporzionalità rispetto alle risorse economiche di ciascuno. «La filiazione – recita la norma – impone pariteticamente ai genitori l’obbligo di provvedere alla cura, all’educazione, all’istruzione e all’assistenza morale dei figli». Facile intuire che, a cascata, sembrerebbe derivarne la scomparsa dell’assegno di mantenimento a favore del mantenimento diretto, con un rimborso delle spese straordinarie sempre stabilito al 50% senza alcuna valutazione sull’eventuale divario economico tra padre e madre. Divario sul quale i dati periodicamente raccolti dall’Istat e dall’Inps non lasciano adito a dubbi: i genitori più fragili dal punto di vista economico sono le madri. Le nuove povere d’Italia. Quelle a più alto rischio di marginalizzazione. Ancora una volta, si prescinde dalla realtà dei casi concreti per rincorrere l’ideale astratto della bigenitorialità perfetta.
Il coordinatore genitoriale
Ciliegina sulla torta, tornano in pista altri due istituti resi “famosi” dal Ddl Pillon: l’obbligo di mediazione e il possibile ricorso al coordinatore genitoriale. Il vecchio disegno di legge aveva provato a infilarli nell’imbuto del diritto di famiglia che, vale la pena ricordarlo, deve sempre fare i conti con le fonti superiori del diritto, dalla Carta costituzionale ai moltissimi accordi internazionali sulla tutela dell’infanzia. In particolare, il provvedimento stabilisce che il giudice «invita le parti a redigere un piano genitoriale, congiunto o disgiunto, che riporta il regime di vita precedente dei figli e dettaglia le regole della loro futura gestione, con l’eventuale ausilio di un operatore specializzato, denominato coordinatore genitoriale, scelto dal giudice o dalle parti stesse nell’ambito degli esperti nella mediazione di coppie ad elevata conflittualità». Se il tentativo non riesce il giudice detta le relative regole e può assegnare al coordinatore, con il consenso delle parti, «il compito di coordinare la responsabilità genitoriale per un determinato periodo di tempo, curando l’osservanza delle regole e l’attuazione del piano».
La mediazione obbligatoria e le spese raddoppiate
Come allora, anche oggi è facile prevedere che la norma sulla mediazione solleverà più di un’obiezione. L’articolo 13 prevede che «in tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista per acquisire informazioni sull’opportunità di un eventuale percorso di mediazione familiare». Solo il primo incontro è gratuito e può svolgersi anche individualmente a richiesta anche di una sola delle parti. Se una delle parti non ottempera, il procedimento si avvia ugualmente per l’iniziativa dell’altra. Laddove l’intesa non si raggiungesse, sarebbe necessario rivolgersi al tribunale, con nuovi costi. Spese raddoppiate, quindi, a tutto discapito, di nuovo, di chi solitamente tra i genitori è più fragile dal punto di vista economico.
E la violenza domestica dov’è?
Mai nel testo del provvedimento compare la questione della violenza domestica, la vera grande assente, la convitata di pietra. Eppure i dati recentissimi del servizio analisi criminale della Polizia sono lì a ricordarci che dal 2019 maltrattamenti e stupri sono cresciuti del 35%. Eppure già con la legge vigente, secondo quanto rilevato da un’indagine dell’associazione Goap che gestisce il centro antiviolenza di Trieste, bambine e bambini finiscono in affido condiviso in oltre il 70% dei casi in cui risultano querele, indagini o condanne per violenza nei confronti del padre da parte delle madri. Quella violenza che nei tribunali civili diventa, appunto, invisibile, derubricata a conflitto, persino quando in sede penale è stata accertata.
La Convenzione di Istanbul, questa sconosciuta
Eppure ancora la Convenzione di Istanbul, che con la ratifica del 2013 è diventata legge dello Stato, all’articolo 31 impone all’Italia di adottare misure legislative o di altro tipo «necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione», nonché «le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini». L’amnesia del disegno di legge sulla violenza contro le donne è evidente. Non solo: a procedimenti già affollati di soggetti terzi chiamati a intervenire – avvocati, tutori, consulenti tecnici, assistenti sociali – il Ddl ne aggiunge di nuovi, confermando la tesi di chi vede nelle separazioni e negli affidi un business sempre più redditizio. Sulla pelle dei bambini.
da Fanpage
Dopo gli omicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula una riflessione è d’obbligo: pochi casi non bastano a identificare un pattern o lanciare un allarme, ma è chiaro che sta succedendo qualcosa di grave nei rapporti fra giovani donne e giovani uomini.
Nel giro di poche ore, l’Italia è rimasta sconvolta dalla notizia di due femminicidi di due studentesse universitarie: Sara Campanella, uccisa per strada a Messina e per il cui omicidio è indagato un compagno di corso che l’avrebbe perseguitata per due anni, Stefano Argentino, e Ilaria Sula, il cui corpo è stato ritrovato in una valigia fuori Roma. L’ex fidanzato Mark Antony Samson ha confessato di essere l’autore del delitto. Campanella e Sula avevano la stessa età, ventidue anni, e i loro presunti assassini sono poco più grandi: ventisette per Argentino e ventitré per Samson.
La questione anagrafica in questi casi è importante da sottolineare. Negli ultimi anni, l’età media delle vittime di femminicidio si sta alzando, anche perché finalmente si cominciano a riconoscere come tali gli omicidi di donne anziane, spesso malate, che per tanto tempo sono stati interpretati come “gesti dettati dalla disperazione”, se non addirittura “dalla compassione” dei mariti. Ma dall’altra parte, ci sono stati anche diversi femminicidi che hanno coinvolto uomini giovani, se non giovanissimi: Filippo Turetta, che aveva ventidue anni quando accoltellò Giulia Cecchettin, sua coetanea; il diciasettenne di Viadana che uccise Maria Campai nel garage di casa sua; Jashan Deep Badhan, diciannovenne che accoltellò la vicina di casa Sara Centelleghe, di diciott’anni; il quindicenne arrestato per aver gettato dal balcone una tredicenne a Piacenza. E ora gli arresti di Argentino e Samson.
Pochi casi non bastano a identificare un pattern o lanciare un allarme, ma è chiaro che sta succedendo qualcosa di grave nei rapporti fra giovani donne e giovani uomini. Non sono solo i casi di femminicidio a dircelo, anche perché l’assassinio è solo la punta dell’iceberg della violenza di genere. Secondo il Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, nel 65% dei casi di violenza sessuale registrati nel 2023, gli autori noti avevano tra i 14 e i 34 anni; il 27% tra i 14 e i 17. Un rapporto del 2024 di Save The Children evidenzia come tra gli adolescenti ci sia una propensione al controllo all’interno delle relazioni, specie attraverso i social, e che persistono stereotipi radicati. Chi si occupa di violenza di genere e ne va a parlare nelle scuole riferisce una sorta di regresso, o la percezione di un divario tra le opinioni delle ragazze – sempre più consapevoli e informate – e quelle dei ragazzi – che sono sempre più ostili e vanno subito sulla difensiva.
Una parte di responsabilità va ascritta alla cronica assenza di educazione sessuale e affettiva a scuola, in uno dei pochi Paesi rimasti in Europa a non prevederla nel calendario scolastico. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, il ministro dell’Istruzione Valditara aveva lanciato il progetto “Educare alle relazioni”, mal concepito ma comunque mai avviato, e molto osteggiato dal fronte anti-gender che lo reputa una forma di indottrinamento. Ma la prevenzione, su cui comunque non si investe abbastanza, è un contenitore che può essere riempito di tante cose diverse, ed è qui che sta la parte più difficile di questa responsabilità.
La prevenzione che abbiamo conosciuto da quando il nostro Paese ha firmato il primo piano anti-violenza nel lontano 2013 è quella delle panchine rosse, degli inviti a chiamare il 1522, dei «Denunciate!» e dei «Se ti picchia non è amore». Messaggi che sono serviti senz’altro a creare consapevolezza del fenomeno della violenza di genere, ma che forse meritano di essere rivisti o superati. Non solo perché il messaggio è arrivato soprattutto alle donne (che in effetti sono più propense a rivolgersi alle forze dell’ordine o ai centri antiviolenza) e quindi ha mancato il vero obiettivo della sensibilizzazione – cioè gli uomini – ma anche perché non dice quasi nulla a questa nuova generazione di possibili vittime e possibili autori di violenza.
I femminicidi di Campanella e Sula, così come quello di Giulia Cecchettin, hanno coinvolto giovani donne brillanti, in procinto di realizzarsi dal punto di vista accademico e professionale. A togliere loro il futuro ci sono uomini quasi loro coetanei, incapaci di accettare forse non tanto la “fine della relazione”, come amano scrivere i giornali, ma l’idea che queste donne potevano vivere la loro vita senza di loro. I dettagli dei casi di questi giorni devono ancora essere chiariti, ma il processo nei confronti di Filippo Turetta ha illustrato perfettamente questo schema: da un lato una giovane donna che vuole soltanto fare le sue cose, dall’altro un giovane uomo incastrato in un vortice di autocommiserazione, risentimento e infine violenza.
Un segno rosso in faccia o uno slogan alla “Se dice no è no” non riusciranno ad arrivare alle radici più profonde di questo divario, che va oltre la questione delle relazioni romantiche e sessuali. Lo vediamo anche nella politica: uno studio durato venti anni e condotto in venti Paesi, fra cui l’Italia, ha mostrato che le donne giovani hanno opinioni sempre più progressiste e aperte al mondo, mentre i loro coetanei maschi sono sempre più conservatori e reazionari.
Questo pattern non è tanto diverso dal centinaio di femminicidi che si consuma ogni anno in Italia, dove il gesto arriva quasi sempre dopo una separazione o nel momento in cui diventa chiaro che la donna si è rifatta una vita che non prevede il coinvolgimento dell’ex partner. Gli ingredienti sono sempre gli stessi perché il patriarcato è sempre lo stesso, ma nei casi che vedono autori così giovani c’è qualcosa che il nostro Paese non ha gli strumenti per affrontare o che fa finta di non vedere. Qualcuno la chiama “crisi del maschio” o “male loneliness epidemic” (epidemia di solitudine maschile), anche se espressioni come queste rischiano di essere autoassolutorie. Qualcuno ci sta già facendo i conti: nel Regno Unito, dove il fenomeno è stato ben raccontato dalla serie Adolescence, la polizia ha cominciato a trattare i casi di “misoginia estrema” come se fossero casi di terrorismo, in cui si riconosce che l’autore ha subìto un vero e proprio processo di radicalizzazione.
La radicalizzazione, di qualsiasi natura, avviene quando un soggetto trova un’ideologia che non solo conferma la sua visione del mondo, ma che sembra spiegare ogni cosa che gli accade nella vita. Finché non si arriva al tipping point, il punto di svolta, un fatto spiacevole che scatena la reazione violenta, come essere lasciati o rifiutati da una ragazza che non è vista come una compagna o una pari, e forse nemmeno tanto come un oggetto, ma come un premio, come qualcosa di dovuto. Come il sorriso che Stefano Argentino avrebbe preteso da una ragazza che aveva paura di lui, che non gli aveva mai dato alcuna attenzione, che lo chiamava “il malato”. Questo messaggio è pervasivo, specie online, dove i guru della mascolinità costruiscono la loro fama rimarcando proprio il fatto che il mondo è ingiusto per gli uomini e che se vogliono qualcosa se lo devono guadagnare da soli. E soli rimangono: Turetta, Argentino, persino Jamie di Adolescence che non sa nemmeno descrivere cos’è l’amicizia, pur avendo in apparenza una vita sociale.
Di fronte all’innalzamento delle età delle vittime di femminicidio, qualcuno tirava un amaro sospiro di sollievo: la violenza di genere è un vecchio retaggio culturale, le nuove generazioni sono la speranza. Purtroppo non è così. E per intercettarle dobbiamo avere il coraggio di abbandonare i vecchi codici e simboli e trovare nuove parole.
Intervento presentato all’incontro Le lettere del mio nome. In ricordo di Grazia Livi del 29 marzo 2025 al Circolo della rosa-Libreria delle donne di Milano, promosso da Elena Petrassi.
Nel 2012 Graziella Bernabò mi fece conoscere personalmente Grazia Livi. Provavo per lei una grande riconoscenza per avermi introdotto con mano esperta e leggera alla lettura di tantissime autrici del Novecento con le sue brevi e dense biografie di grandi scrittrici dove si intrecciavano vita e opere, dove lei stessa si metteva in gioco e, con una scrittura limpida e precisa, tersa e tesa, come diceva Marisa Bulgheroni, riusciva a mostrare il rapporto tra una donna e la creazione letteraria, partendo da piccoli particolari per andare al centro della vita. Ha saputo mostrare scacchi e scatti di resistenza, lacci e invenzioni di libertà delle donne e questo ha permesso a tante di noi di conoscersi meglio, di sentire che un’altra capiva le nostre emozioni e le rappresentava.
Desiderai subito creare una serata al Circolo della rosa sul suo lavoro. Scelsi con lei di costruire un dialogo con Laura Lepetit, che era diventata sua editrice dal 1991, dopo la pubblicazione nel 1984 da Garzanti del libro Da una stanza all’altra. Finalmente, dopo alcuni spostamenti di data in attesa della bella stagione per suoi problemi di salute, il 13 maggio 2013 vi riuscimmo. Con grande disponibilità, ironia e acutezza percorremmo diverse tappe della sua vita. Qui accennerò a episodi e riflessioni sulla sua presa di coscienza come donna e il suo femminismo.
Grazia proveniva da una colta famiglia fiorentina che le aveva permesso di laurearsi ma che rispetto alle donne aveva una visione patriarcale. A questo proposto ci raccontò di come suo padre, professore universitario, figlio e nipote di professori universitari, rivolgendosi ai due figli maschi, che divennero economisti, dicesse “Voi seguirete la mia strada” come difatti fecero. E poi guardando le figlie con leggero compatimento: “E voi farete le mie segretarie”. Infatti le fece studiare anche stenografia, cosa peraltro utile quando diventerà giornalista.
La madre, donna bella, spiritosa e salottiera era “Tutta una lode del padre”, diceva continuamente “L’ha detto il babbo” e proponeva per le figlie l’unico modello femminile che aveva conosciuto. Grazia però aggiunse: “Le madri vanno perdonate perché i tempi erano davvero brutti”. Con questo commento sottolineava la necessità di non incolpare le madri dei danni patriarcali. Oggi noi diremmo che è necessario redimere la relazione con la madre, non tanto perdonarla considerando le tremende difficoltà ad agire diversamente da come fecero. Già qui possiamo cogliere un aspetto del suo femminismo: guardare con curiosità e comprensione le donne e con ironia gli uomini, osservando i loro comportamenti e soprattutto sapere riconciliarsi con la madre.
Appena sposata visse a Londra dove si descrisse come “ragazza inconsapevole del vivere, che era stata una brava studentessa e una brava fanciulla nel pieno del patriarcato”. Fu una delle primissime a leggere Simone de Beauvoir, non ancora tradotto in italiano. “Leggevo per un feeling per le cose interessanti ma il mondo delle donne non esisteva. Esistevano le solitarie appassionate della parola scritta, come me.”
Su richiesta della Società delle letterate scrisse per la serie Parole pensate come era giunta alla pubblicazione del suo primo libro Gli scapoli di Londra.1
«Fui colpita dalle abitudini riservate alle persone colte, dalla cautela delle conversazioni, dal ritmo ordinato della grande città, dove si intrecciavano i riti e le solitudini. Ero pronta a colorare quel che vedevo con descrizioni umoristiche. Osservavo tutto e ridevo di tutto. Un amico giornalista mi disse: “Capisci così bene questo mondo… perché non provi a scriverne?” E mi dette l’indirizzo del suo settimanale prestigioso. La mia istintività allora era spontanea, non ancora appesantita dalla consapevolezza. Tutto pareva possibile. Scrissi, come giocando, e poco dopo vidi l’articolo pubblicato, persino con rilievo. Il sottotitolo era Vita di Londra. Mi furono chiesti altri articoli, ero piena di incredulo stupore. Tuttavia li mandai, ed ebbero una piccola eco, pari all’allegra naturalezza con cui erano stati scritti.
Quando tornai in Italia ero già una ragazza diversa. Il problema, molto grosso allora per una donna, era quello di una identità in fieri in un mondo quasi privo di uscite: il mondo patriarcale. Pianificai di diventare indipendente facendo la giornalista. Era scomparsa l’allegria. La responsabilità piena di conflitti si era insinuata nella vivace incoscienza della ragazza che voleva diventare una persona, secondo se stessa. Avrei potuto mantenermi scrivendo per i giornali.» Infatti divenne inviata per importanti riviste di quel periodo come Il mondo, L’europeo, Epoca, La nazione per cui fece anche diverse interviste di cui ricordò in particolare quelle a Rubinstein e a Giacometti.
L’editore Sansoni – nella persona del suo nuovo proprietario, Federico Gentile – iniziò una collana di libri d’esperienza vissuta, e le chiese di pubblicare i suoi articoli inglesi e nel 1958 uscì Gli Scapoli di Londra, recensito da Montale e che vinse il Bagutta Tre Signore, l’anno in cui vinse Italo Calvino.
Credo si capisca come lo scrivere diventasse allora il suo lavoro per emanciparsi ma la passione per lo scrivere prese corpo nella scrittura dei racconti. Ci disse: “Il racconto mi incanta. Ho scoperto Katherine Mansfield, grande maestra, stupenda esaltatrice della vita minima, della vita del sentire, delle emozioni, con una stupenda sensibilità femminea”. E poi aggiunse: “Scrivo tutto quello che si annida dentro il non detto di una persona. Nella mia grande famiglia nessuno si interessava a sapere la verità, fin da bambina credevo importante capire la verità e dirla, non solo i fatti”.
E poi continuò: “Scrivevo in modo narrativo ancora tradizionale. Ero stata spinta a scrivere da Anna Banti, grande figura di donna, ma non obbedivo a degli incitamenti. Quello che sentivo è ben detto da Carla Lonzi nel Secondo Manifesto di Rivolta femminile Io dico io del 1977”. Nell’incontro lo citò leggendolo direttamente: “Chi ha detto che l’ideologia è anche la mia avventura? / Avventura e ideologia sono incompatibili / La mia avventura sono io”. E aggiunse: “È l’indicazione più bella della singolarità, della potenzialità che una deve riconoscersi, tirar fuori, amare, è il percorso di una persona se è fedele alla propria singolarità per tutta la vita”.
Del femminismo temeva diventasse un’ideologia e invece valorizzò l’importanza della singolarità a partire da se stessa per poi valorizzarla anche rispetto alle scrittrici da lei scelte.
L’incontro con Virginia Woolf nacque grazie ad Anna Banti che dirigeva la parte letteraria della rivista Paragone, dove Livi pubblicava qualche recensione.
Grazia ci raccontò: “Banti mi telefonò dicendomi che sentiva che ero sulla stessa lunghezza d’onda di Virginia Woolf e mi chiese di scrivere un saggio su di lei entro un mese. Non sapevo le regole per scrivere un saggio e gli uomini a cui mi rivolgevo erano sbrigativi, ma scrivere questo saggio mi ha fatto scoprire, uso una parola femminista, la sorellanza perché via via che leggevo la Woolf capivo benissimo, non tanto la lingua ma chi era e che anch’io provavo quello che lei scriveva, sentivo la gioia di ritrovarmi. Ho letto tutto e ho scritto il saggio. Ho provato grande soddisfazione perché Banti mi disse Bellissimo e lo mise in apertura della rivista. Era una cosa incoraggiante ma io percepivo con forza come noi eravamo intrappolate nella subordinazione come donne agli uomini”.
Dal saggio su Woolf successivamente le venne in mente di collocare nella stanza di lavoro altre scrittrici per scrivere della loro vita. La stanza metafora per dire il bisogno di entrare all’interno di una vita, per dare un tocco di empatia. Era incantata da tutte le scrittrici scelte: Woolf per la vicinanza interiore straordinaria; Austen assoluta per non aver bisogno d’altro dentro la sua routine; Dickinson monaca dell’assoluto; Percoto, sua scoperta ridotta in una cartella polverosa nell’archivio di Udine, con una vita quotidiana molto difficile ma donna molto forte; di Mansfield abbiamo già detto, Anaïs Nin donna che giocava col suo aspetto e sapeva giocare con l’amore, cosa che Grazia non sapeva fare ma che l’affascinava. Ci disse: “Ho sentito per tutte latente fiducia, tenerezza, partecipazione per i destini”.
Con Da una stanza all’altra del 1984 inizia un percorso, che continuerà soprattutto con Le lettere del mio nome e Narrare è un destino, di presa di coscienza femminista, o meglio, come precisò, di sviluppo di “una piega della sensibilità che andava verso la condizione reale delle donne e che mi faceva bramare per una chiarezza di rapporti. […] Sono donna, mi riconosco in loro, ho l’istinto di scavare in loro, ne sento la dolorosità che poi ho sentito anche negli uomini”.
Grazia Livi con queste parole ci mostra come ci si possa aprire empaticamente alla differenza maschile quando e perché, partendo da sé, si resta fedeli al proprio essere donna.
1 https://www.societadelleletterate.it/2015/01/6926/
(www.libreriadelledonne.it, 2 aprile 2025)
dal Fatto Quotidiano
La vicenda avvenuta a Roma che vede protagonista una bambina di cinque anni che si è legata con lo scotch a una sedia sotto un tavolo per non essere separata dalla madre, solleva interrogativi profondi e drammatici sull’equilibrio tra tutela dei minori, decisioni giudiziarie e il concetto stesso di giustizia come protezione. Una bambina che rifiutail prelievo forzato è un segnale da ascoltare, non da ignorare. Il gesto estremo e simbolico della minore è l’espressione di un disagio profondo, che va ben oltre la normale opposizione infantile.
Un tale comportamento non è solo frutto di una relazione affettiva intensa con la figura materna, ma manifesta anche una volontà consapevole, espressa nel linguaggio che un bambino può usare con il corpo, l’azione, il rifiuto.
Il punto non è se il provvedimento sia formalmente legittimo. Il punto è se sia giusto provocare un trauma irreparabile.
Quando la giustizia diventa trauma non è più giustizia ma violenza. L’intervento dello Stato, laddove la tutela dei minori sia necessaria, dovrebbe essere proporzionato, tempestivo, rispettoso della dignità e del superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia, ratificata con l. 176/1991). Tuttavia, quando il sistema interviene senza ascolto, senza gradualità, senza mediazione, il confine tra tutela e violenza istituzionale diventa drammaticamente sottile.
In casi come questo, si rischia di produrre l’effetto contrario a quello dichiarato: non si protegge il minore, lo si danneggia.
Il fatto, poi, che un intero condominio si sia mobilitato per impedire il prelievo forzato dimostra che la società civile ha percepito la misura come ingiusta, sproporzionata, disumana. Quando è il popolo a dover contenerel’eccesso dello Stato, siamo di fronte a una rottura del patto fiduciario tra istituzioni e cittadini. Lo Stato non può delegare la propria funzione protettiva alla reazione spontanea della collettività. Deve, invece, interrogarsi su come siano potuti accadere fallimenti sistemici e di ascolto, che hanno portato un’intera comunità a difendere chi, sulla carta, doveva essere già tutelato dallo Stato.
La conferenza stampa che ho organizzato alla Camera dei deputati e l’interrogazione parlamentare che ho presentato al ministro della giustizia, Carlo Nordio, sono atti istituzionali necessari in presenza di una situazione che evoca gravi profili di lesione dei diritti fondamentali della minore.
Questo caso impone una riflessione urgente sulla giustizia minorile, la quale deve essere ripensata in chiave relazionale e non solo procedurale. Ma soprattutto serve una seria revisione della legge n. 54 del 2006. Tale norma ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità, ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la separazione o il divorzio. Un principio condivisibile nei suoi intenti, fondato sull’idea che la presenza di entrambi i genitori sia, in linea generale, un valore per la crescita sana ed equilibrata del figlio.
Tuttavia, a quasi vent’anni dalla sua entrata in vigore, è ormai evidente che il principio della bigenitorialità non può essere applicato come dogma, né in modo automatico e indifferenziato. Esistono contesti familiari, troppo spesso sottovalutati, in cui uno dei due genitori manifesta comportamenti violenti, abusanti o gravemente disfunzionali. In questi casi, insistere sul mantenimento della bigenitorialità senza una reale valutazione del rischio significa sacrificare il superiore interesse del minore sull’altare della formalità.
La giurisprudenza, sia nazionale che della Corte EDU, ha più volte affermato che il diritto del minore alla relazione con entrambi i genitori non è assoluto, ma va sempre valutato alla luce della concreta idoneità genitoriale e della capacità di ciascun genitore di contribuire in modo positivo alla crescita del figlio. Eppure, nella prassi, si continuano a registrare decisioni giudiziarie che, pur in presenza di denunce documentate per maltrattamenti, stalking o abusi, dispongono affidi condivisi o incontri “protetti” con genitori violenti, mettendo a rischio l’incolumità psico-fisica del minore e della madre che lo tutela.
da il manifesto
Da uno scherzoso componimento liceale a una strofa buttata giù alla vigilia della morte: le poesie «disperse» vengono ora raccolte da Andrea Ceccarelli sotto il titolo «Racconto antico», da Adelphi
Cimentandosi nel 1996 in quel particolarissimo genere letterario che è il discorso di accettazione del premio Nobel, Wisława Szymborska deplorava con la consueta ironia il carattere «nient’affatto fotogenico» del proprio mestiere. Nessun regista, a suo dire, si sarebbe mai arrischiato a girare un documentario sulla vita quotidiana di un individuo che «fissa con lo sguardo immobile la parete o il soffitto, di tanto in tanto scrive sette versi, dopo un quarto d’ora ne cancella uno, dopodiché passa un’ora in cui non accade nulla… Quale spettatore reggerebbe uno spettacolo simile?» Peggio ancora, questa sequenza soporifera si sarebbe verosimilmente conclusa con l’attimo in cui il poeta insoddisfatto, dopo tante tribolazioni, annienta i frutti imperfetti del proprio lavoro.
All’esercizio dell’auto da fé Szymborska si dedicava in effetti con una certa ostinazione – lo dimostra il fatto che al momento dell’attribuzione del Nobel fosse autrice di soli nove esili volumetti di poesie, di cui due (quelli degli esordi real-socialisti risalenti a mezzo secolo prima) disconosciuti e mai più ripubblicati.
Eppure nel suo caso il reiterato ricorso al cestino della carta straccia – da lei ritenuto lo strumento più prezioso per chi scrive – non era motivato esclusivamente da una spasmodica tendenza all’autocritica. Altrettanto stringente doveva sembrarle l’imperativo etico di utilizzare con morigeratezza quel potere quasi stregonesco che offre la scrittura: retrocedere al «paradiso perduto della probabilità», addentrarsi tra gli interstizi del possibile e fondare così, sulla base degli elementi trascelti, un ordine diverso da quello esistente. Se scrivere è innanzitutto «la vendetta di una mano mortale», ovvero la creazione di un mondo alternativo di cui l’autore stringe strettamente in pugno le «sorti indipendenti», è chiaro che di un simile dono non si dovrebbe abusare, pena l’incorrere in quei pericoli che Szymborska aborriva, e cioè nel chiacchiericcio o, peggio, nella falsità.
In un lungo arco temporale
Considerando la propensione dell’autrice verso questa sorta di ecologia della creazione, sembra tanto più straordinario che a tredici anni ormai dalla sua scomparsa escano ancora poesie inedite, non incluse in nessuna raccolta pubblicata in vita, ma nemmeno distrutte. Poesie che difficilmente potrebbero essere raggruppate sotto una rubrica diversa da quella di «disperse» scelta da Andrea Ceccherelli per il sottotitolo di Racconto antico, proposto ora da Adelphi a sua cura (pp. 140, € 13,00). L’ampiezza dell’arco temporale (si va da uno scherzoso componimento liceale a una strofa messa su carta alla vigilia della morte), nonché l’ovvia eterogeneità dell’intonazione, rendono infatti impossibile individuare fra questi versi un minimo comune denominatore. Al contempo, non è difficile intravedervi quell’interrogazione tenace e spesso stupita del reale che costituisce la cifra inconfondibile della poetessa polacca. Così come pressoché immutata nel tempo rimane la sua tendenza a procedere secondo una logica accumulativa, che ai risvolti concreti dell’essere affianca innumerevoli varianti irrealizzate.
Queste eventualità inopinatamente scartate dal destino talora restano, a volte, perfino implicite, consegnate a un pudico, quanto scherzoso non detto: «Se mai le cose potessero parlare – / ma se parlassero, potrebbero anche mentire. / Soprattutto quelle ordinarie e poco apprezzate, / per attirare finalmente l’attenzione. // Mi spaventa l’idea / di cosa mi direbbe il tuo bottone caduto, / e a te la mia chiave di casa, / vecchia mitomane».
Altrove, la vita potenziale degli oggetti si condensa in apologhi spassosi, invariabilmente conclusi da appelli edificanti alla gioventù comunista. È il caso di Favole sulla vita delle cose inanimate del 1949, dove la poetessa – allora ventiseienne – immagina le possibili sorti di un libro che, non essendo mai stato letto da nessuno, decida di leggersi da solo; inoltre, di una stufa intenzionata a cambiare quotidianamente nome, a seconda del santo o della santa celebrati quel giorno: e, ancora, di un letto pigro, convinto che non esista nulla di meglio del sonno.
L’alternativa del «se mai» assume tonalità affatto diverse in La dialettica e l’arte, forse una delle poesie più «dissenzienti» di Szymborska, uscita a Parigi sulla rivista dell’emigrazione polacca «Kultura» nel 1985 sotto pseudonimo, e significativamente non inclusa nella raccolta successiva, Gente sul ponte, uscita l’anno seguente. Qui l’autrice passa in rassegna le prevedibilissime conseguenze derivanti per un poeta dal sottomettersi supinamente alle direttive del potere politico o, al contrario, dall’ignorarle: «La tua opera, artista, è sulla bilancia della sorte / Se dirai Sì / subito acquisterà peso / Se dirai No / ne perderà all’istante / Se dirai Sì / diventerai finalmente / migliore dei peggiori / perché i peggiori saranno quelli che hanno detto No».
Quando tutto è bianco o nero
Umori non meno sediziosi trapelano da La tribuna, dissacrante ritratto di non meglio specificate autorità militari e civili, che evoca alla mente i Generali dipinti da Enrico Baj. Più malinconica è invece la riflessione metapoetica contenuta nel componimento dedicato a František Halas, poeta ceco che, malgrado la sua militanza di sinistra e il ruolo attivo svolto nella Resistenza, divenne oggetto di una sorta di damnatio memoriae in epoca staliniana. Irridendo il manicheismo propagandato dall’alto («Semplifichiamo il mondo. L’erba sappia / che anche il suo colore o è bianco o è nero»), la poetessa polacca osserva ironicamente come le «vie di un tempo, non perfettamente rette» non siano ormai più tollerate.
Forse ha origine proprio da questa constatazione la sua successiva tendenza a deviare dagli schemi precostituiti («Sono, ma non devo / esserlo, una figlia del secolo») per progettare «un mondo nuova edizione /, riveduta», che risponda unicamente alle regole della scrittura. È la prospettiva aperta in Racconto antico, forse la più bella tra le «poesie disperse», riemersa dall’archivio del marito dell’autrice Adam Włodek. Sancendo qui per la prima volta l’autonomia assoluta dell’universo letterario rispetto a quello reale, Szymborska afferma scherzosamente il carattere veridico di ogni narrazione, dal momento che chi scrive non può fare a meno di condividere, soprattutto nei momenti più lieti, le esistenze di carta dei suoi personaggi: «L’autore giura che era lì al banchetto / con gli sposi, a bere vino centenario, / che nel mondo non descritto è troppo caro».
da L’Altravoce il Quotidiano
Il 23 marzo 1944, in un pomeriggio di sole, nella Roma occupata dai nazifascisti, un gruppo di giovani partigiani dei Gap (Gruppi di azione patriottica), organizzazione clandestina armata del Partito Comunista, in via Rasella fa strage di tedeschi. Ritanna Armeni con il suo ultimo romanzo A Roma non ci sono le montagne edito da Ponte alle Grazie, ci catapulta in quel pomeriggio. Protagonisti sono giovani borghesi, colti, studenti, assistenti universitari o docenti, qualche operaio, che hanno scelto la lotta armata contro i tedeschi e i loro servi fascisti, in attesa dell’arrivo degli alleati (4 giugno 1944). Carla Capponi (nome di battaglia Elena), Sasà Bentivoglio (Paolo), Carlo Salinari (Spartaco), Franco Calamandrei (Cola), Maria Teresa Regard (Piera), Mario Fiorentino (Giovanni), Lucia Ottobrini (Maria): sono questi i loro nomi e quel pomeriggio ognuno/a è al proprio posto. Giorgio Amendola, dirigente del Partito comunista e componente del Cnl (Comitato di liberazione nazionale) e Spartaco, comandante del Gruppo, controllano che tutto vada secondo i piani. Tutto doveva avvenire entro le 14.00 quando il battaglione Bozen formato da 150 tedeschi, cantando e marciando, avrebbe attraversato via Rasella, secondo il racconto di Mario e Lucia che dalla loro finestra, ogni giorno, sentivano le voci e il rumore degli stivali. Tutti aspettano. Aspetta Sasà vestito da spazzino con il suo carretto pieno del tritolo portato da Carla, andando su e giù per le strade controllate dai tedeschi. Lei aspetta, con la borsa piena di bombe a mano, davanti al portone del “Messaggero” con un impermeabile al braccio che poi darà a Sasà. Tutti gli altri aspettano con pistole e bombe a mano costruite da Giulio, il giovane laureato in fisica. Perché i romani non prendono le armi, non si ribellano contro gli occupanti che in città seminano terrore e morte? «Perché – risponde l’autrice – a Roma non c’erano le montagne dove nascondersi come i partigiani del resto del Paese. Per nascondersi si poteva contare solo sui portici, sulle strade strette del centro, sui quartieri che in periferia si intrecciavano e si confondevano con le chiese o dei conventi. Le truppe naziste non si annunciavano, apparivano all’improvviso, sfilavano per le strade, perquisivano i cantieri, entravano nei portici. Toglievano il respiro […] sfinivano con la loro presenza». Terrore e odio seminava, insieme ai fascisti, Herbert Kappler, comandante della Gestapo, con arresti e torture. Aveva svuotato il Ghetto e deportato gli ebrei dopo averli ingannati facendosi consegnare 50 chili di oro in cambio della deportazione. Intanto a via Rasella il tempo passa ma dei tedeschi non c’è traccia. Sono alla festa nostalgica dei fascisti per l’anniversario della nascita del Partito (23 marzo 1919). Minuto dopo minuto l’autrice ci rivela i sentimenti contrastanti dei partigiani che stanno per annullare l’operazione militare quando alle 15.45 il battaglione arriva, marciando e cantando. L’esplosione è terribile, una strage (33 morti, un ragazzo lì per caso e molti feriti). I partigiani fuggono, i tedeschi sotto shock reagiscono subito, colpiscono le finestre, entrano nei portoni e nei negozi, fanno saltare le serrature, perquisiscono gli appartamenti, prendono i civili, compresi donne e bambini, separano gli uomini dalle donne. Da Berlino arrivano gli ordini di una rappresaglia esemplare che faccia “tremare il mondo”. Hitler vuole fucilati dai 30 ai 50 italiani per ogni tedesco ucciso, ma per paura di una insurrezione si decide 10. E fu l’eccidio delle Fosse Ardeatine (320 innocenti). Nella ricorrenza di quegli eventi come non pensare a Gaza dove, dopo il massacro del 7 ottobre, la rappresaglia è diventata genocidio di un popolo e le Fosse Ardeatine un abisso di odio, disumanità e morti tra cui migliaia di bambine/i innocenti?
(L’Altravoce il Quotidiano, rubrica “Io Donna”, 29 marzo 2025. L’Altravoce il Quotidiano è il Quotidiano del Sud che ha cambiato nome)
da il manifesto
Per un comunismo della cura di Gian Andrea Franchi edito da DeriveApprodi (pp. 192, euro 18) è un testo fondamentale per chi voglia riflettere sul presente, il recente passato e avere una visione del futuro in cui i fenomeni migratori, per ragioni climatiche e scenari di guerra, sono destinati ad aumentare drasticamente. Franchi è uno dei fondatori di Linea d’Ombra, un’organizzazione di volontariato nata a Trieste nel 2019 che riunisce gli attivisti che accolgono i profughi della rotta balcanica, diretti soprattutto verso il nord Europa, nella piazza antistante la stazione di Trieste, ribattezzata Piazza del Mondo.
Si tratta di un’esperienza che nasce da un’azione spontanea di Lorena Fornasir che di fronte allo scenario di uomini e donne coi piedi martoriati dal cammino lungo e difficoltoso, decide di occuparsi di quelle ferite, per aiutarli a proseguire nel loro percorso. Del resto, scrive Franchi, «la cura si esprime efficacemente nel contatto fra i corpi».
La cura, come indica il titolo, è uno dei temi fondamentali di questo testo così denso e allo stesso tempo lucido: «la cura è politica o non è cura» chiarisce però Franchi. In un contesto quale quello neoliberista in cui viviamo, la cura viene rimossa perché non è funzionale al sistema capitalista che è, come già Marx indicava, mortifero più che votato alla salvaguardia della vita.
Del resto, come viene chiarito qui, quando a dominare è la produzione e quindi il tempo deve essere interamente votato al profitto, «il lavoro di riproduzione», cioè la cura, viene declassato o reso invisibile, nonostante sia ciò che garantisce la vita della specie umana, risaputamente vulnerabile. Gian Andrea Franchi sottolinea, poi, come la tanto millantata sicurezza, parola entrata nel discorso pubblico ormai da tempo e che sembra essere diventata l’unico obiettivo dei governi occidentali, abbia la sua etimologia nell’assenza di cura, derivando proprio da sine cura. C’è nel modo in cui l’autore descrive l’esperienza nella Piazza del Mondo qualcosa di miracoloso, non tanto per il valore etico evidente di quello che vi accade, ma per la lucidità con la quale analizza il posizionamento di Linea d’Ombra.
Significativamente in diversi punti del testo Franchi chiarisce che occuparsi degli altri significa prendersi cura di sé: «Chiunque si occupi, in qualsiasi chiave, umanitaria o politica di singoli, gruppi o popolazioni che subiscono gli effetti di situazioni tragiche, lo fa, prima di tutto, perché ne riceve senso per la sua esistenza». Linea d’Ombra affronta appunto la cura degli «esuli» scrive Franchi, utilizzando un’espressione che ha rimandi ben diversi da migranti o profughi: gli esuli sono persone che non possono più vivere nel loro paese per ragioni politiche, a loro volta conseguenze delle azioni colonialiste dei governi occidentali.
Per questo, nominandone la complessità e talvolta i risvolti fallimentari, definisce gli incontri con gli esuli un «furto di senso». Esiste, infatti, quella che Franchi chiama «la linea abissale» che separa noi discendenti dai colonizzatori da loro vittime del colonialismo, una differenza che descrive ulteriormente distinguendo la nostra condizione di «avere un corpo» da quella degli esuli di «essere un corpo». «Avere un corpo» comporta che il sistema capitalista lo voglia ingabbiare e controllare, «essere un corpo» impone di aderire al senso dell’esistenza che presuppone la morte, ma non in termini di castrazione estrema, bensì come parte della vita.
Non c’è un punto in questo testo in cui Franchi definisca il sistema neoliberista migliore o auspicabile rispetto al «game» dell’esilio e la sua visione sorge da un’osservazione diretta, dal «farne esperienza».
Nell’epoca contemporanea prevale, però, l’impedimento dell’esperienza, scrive Franchi, a causa di «quel radicale conformismo» dominante, cioè la normalizzazione imposta dal sistema capitalista. È da qui che deriva secondo lui l’indifferenza dilagante che è a sua volta origine del razzismo. Per un comunismo della cura è un testo in cui coesistono riflessioni a partire dall’esperienza, appunto, nella Piazza del Mondo, ma anche maturate dallo studio costante della filosofia, da Marx a Judith Butler. Infatti, Franchi non solo puntualizza come «l’inferiorizzazione razziale delle donne sia stata la prima e più radicale forma di razzismo», ma ribadisce spesso che il femminismo è l’espressione più efficace della politica di Re-esistenza che lui si auspica. «La tenacia nella durata è un’arte assai difficile» scrive ancora Franchi che la pratica nel suo impegno quotidiano con gli esuli a Trieste, nei suoi studi e nel tentativo indefesso e delicato di comprendere la realtà che ci circonda e che spesso ci curiamo di rimuovere.
(il manifesto, 29 marzo 2025, Trieste, la rotta balcanica e quella linea abissale | il manifesto)
da il Fatto Quotidiano
Dopo 17 mesi di stragi, distruzione e sofferenza, la popolazione di Gaza alza la testa. Da quattro giorni sono scoppiate proteste a Beit Lahia, nel nord di Gaza, per chiedere che Hamas si dimetta dal potere. I civili sono scesi in strada, chiedendo una vita dignitosa e senza guerra. Secondo l’attivista Amin Abed, uno degli organizzatori, i preparativi della protesta sono stati interrotti da pesanti bombardamenti israeliani. La casa di uno dei giovani organizzatori, Yusuf Alayan, è stata colpita dall’Idf, e sono morte nell’attacco la figlia e la madre.
Nonostante le tragedie subite a causa dei bombardamenti israeliani, l’idea della protesta contro Hamas si è diffusa rapidamente anche durante i funerali, portando a una grande partecipazione. Video e foto condivisi sui social media mostravano uomini, donne e bambini che scandivano “Fuori, fuori, Hamas fuori!”. Portavano cartelli con scritto: “Vogliamo vivere”, “Vogliamo dignità”, “Basta guerre” e “Il sangue dei nostri figli non è a buon mercato”. Un anziano di Beit Lahia è diventato virale online mentre diceva: “Vogliamo pace, dignità e diritti. Rifiutiamo lo sfollamento e l’essere governati con la forza”.
Il movimento, iniziato a Beit Lahia, si è rapidamente esteso al campo di Jabalia e a Shuja’iyya. Sono in corso proteste anche a Khan Younis, Nuseirat e Deir al-Balah. L’attivista Abed ha spiegato: “Questo movimento è stato spontaneo, ma ci siamo preparati per sole dodici ore. La gente era pronta a scendere in strada. Si tratta del seguito delle proteste del passato, in particolare del movimento Vogliamo vivere”. Il movimento Vogliamo vivere è nato nel 2017 ed è stato violentemente represso da Hamas. È riemerso nel 2019, ma ha finito per essere nuovamente represso. Molti dei suoi leader, tra cui Abed, Hassan Jamal, Ramzi Herzallah e Amjad Abu Kosh, sono stati arrestati, picchiati e persino uccisi. Lo stesso Abed è stato brutalmente picchiato da uomini di Hamas l’8 luglio 2024, durante questa guerra. Gli sono stati rotti gli arti, i denti sono andati in frantumi e ha riportato gravi ferite alla testa, tanto da richiedere un’evacuazione medica urgente negli Emirati Arabi Uniti. Ma Abed trova ancora la forza di parlare: “Questo movimento riflette la volontà del popolo di porre fine allo spargimento di sangue e di liberarsi da Hamas. Hamas dà a Israele una scusa per continuare a uccidere e sfollare. Per 18 anni ha governato con il pugno duro, causando distruzione senza alcun reale guadagno nazionale o popolare. Hamas e i suoi sostenitori, tra cui Al Jazeera, stanno cercando di demonizzare il nostro movimento per giustificare la sua repressione”. Al Jazeera, ad esempio, ha raccontato le proteste come fossero solo una richiesta di porre fine alla guerra di Israele contro Gaza, ignorando il fatto che si tratta di un movimento anti-Hamas. Molti attivisti palestinesi hanno criticato questa vulgata, sostenendo che i media preferiscono ritrarre i gazawi come vittime piuttosto che come persone che chiedono i loro diritti.
Hamas ha tentato di reprimere alcune delle proteste, ma non è riuscito a metterle completamente a tacere. Le manifestazioni hanno messo in luce un malcontento diffuso, rendendo più difficile per Hamas nascondere la rabbia pubblica. Altri sostengono che le proteste siano sbagliate e che dovrebbero essere rivolte a Israele, che continua a uccidere civili indipendentemente dalla posizione politica. Temono che le proteste possano alimentare il conflitto interno e servire gli interessi di Israele indebolendo l’unità palestinese. I sostenitori della resistenza armata sostengono che le armi di Hamas sono essenziali per la liberazione, mentre i critici ritengono che ci siano altri modi per resistere all’occupazione oltre al confronto militare.
Anche Israele ha guardato alle proteste con sospetto. Il Canale 12 israeliano ha citato un alto funzionario che ha avvertito: “Potrebbe trattarsi di un inganno di Hamas”. Il funzionario ha ammesso di essere sorpreso dalla portata delle proteste, riconoscendo che la frustrazione contro Hamas era cresciuta, ma non era mai stata espressa così apertamente prima. Perché Israele è scettico? Dall’inizio della guerra, Israele ha giustificato i suoi attacchi dipingendo tutti i gazawi come terroristi. I leader israeliani, compreso Netanyahu, hanno ripetutamente definito gli abitanti di Gaza “animali umani” che devono essere eliminati. Sostengono che tutti i gazawi abbiano appoggiato l’attacco del 7 ottobre e sono quindi obiettivi legittimi. Le proteste contraddicono queste affermazioni, dimostrando che molti abitanti palestinesi di Gaza si oppongono a Hamas e vogliono solo vivere in pace. Allo stesso tempo, Hamas si sente sempre più minacciato da queste proteste. A differenza delle precedenti manifestazioni che Hamas ha represso con la scusa di mantenere la “sicurezza”, ora Gaza è nel caos più totale. Non c’è più sicurezza da “mantenere”. L’occupazione israeliana controlla gran parte della Striscia e i bombardamenti quotidiani non lasciano spazio a una normale vita quotidiana. I manifestanti con queste proteste contro Hamas, sempre più estese, stanno esprimendo la loro disperazione di fronte alla guerra e alla sofferenza in corso, di cui anche Hamas è responsabile.
Sia Hamas sia Israele, infatti, stanno usando la popolazione di Gaza come ostaggio: Hamas per la sua sopravvivenza politica e Israele come scusa per continuare a distruggere. La popolazione di Gaza è intrappolata tra due estremi e i civili palestinesi sono le vittime. La guerra ha rubato il loro futuro, i loro figli e le loro case. Nel frattempo, i palestinesi continuano a essere usati: Israele vuole dipingerli tutti come terroristi per giustificare le uccisioni di massa; Hamas vuole controllarli con la forza, ignorando le loro sofferenze; i media arabi vogliono raccontarli come figure tragiche; il resto del mondo vuole che muoiano come vittime o che combattano come eroi. Ma quando la gente di Gaza finalmente alza la voce, chiedendo dignità e pace, viene messa a tacere, accusata di tradimento, repressa o bombardata. Alla fine, Gaza non è solo un campo di battaglia, né una storia che può essere modellata per adattarsi ai programmi politici. A Gaza vivono persone che vogliono vivere, che vogliono sicurezza e che sognano un futuro. Ma per ora le loro voci sembrano essere le più scomode per tutti.
da Minima&Moralia
“Se mai un giorno scrivessi un’autobiografia dovrebbe intitolarsi Troppo. Troppo povera, troppo malata, troppo grassa, troppo debole. Per tutta la vita c’è sempre stato qualcosa di me che era troppo poco. Oppure troppo”.
Sono estratti di una confessione tra le pagine di Bugie su mia madre (L’orma, trad. di Flavia Pantanella) di Daniela Dröscher. La scrittrice e drammaturga tedesca si interroga sulla possibilità che ciascuno abbia tre vite: una pubblica, una privata e una segreta, prendendo in prestito le parole di Gerald Martin in Vita di Gabriel García Márquez. Si muove tra passato e presente con continui flashback per narrare gli anni della sua infanzia, segnati dall’infelicità di sua madre, con cui oggi intesse un dialogo per cercare di dare risposte a drammi che le erano in parte incomprensibili da bambina.
L’autrice ripercorre i primi anni Ottanta sino al disastro nucleare di Chernobyl, isolando il periodo del trasferimento della sua famiglia da Monaco a un piccolo centro, Obach. La ristretta dimensione urbana contribuisce a enfatizzare alcuni aspetti affrontati nell’opera, come il peso del pregiudizio, la calunnia, la necessità di perpetuare una finzione continua per salvare le apparenze, la difficoltà a riconoscere le possibilità di emancipazione e l’indipendenza economica femminile (solo nel 1977 alle donne in Germania è riconosciuto il diritto all’autodeterminazione in ambito lavorativo). Dröscher indaga il corpo della madre, lo scarto tra l’armonia con cui la donna convive con la propria fisicità e l’effetto disturbante che quel corpo genera agli occhi del marito e della comunità.
Il corpo di mia madre rappresentava la visibilità in un mondo che puntava tutto sull’invisibilità.
L’atto politico della rivendicazione di sé attraverso il corpo reso nell’immagine di una donna irriverente, ironica, determinata e sicura di sé sul lavoro, che si piace e che avanza con gioia nell’esistenza, si scontra con i limiti di una visione patriarcale grassofobica che imputa a un aspetto fisico difforme rispetto a una presunta norma il motivo primario di imbarazzo e vergogna altrui. L’inesorabile condanna del dimagrimento forzato costringe la donna a una routine umiliante, come doversi pesare ogni sabato mattina davanti al marito (con vani stratagemmi come appoggiarsi al bastone lavapavimenti per alleggerire il peso). Le proibizioni subite sanciscono un’esclusione sociale e famigliare deleteria, come il divieto di partecipare alle vacanze estive al mare o alla cena natalizia di lavoro. Quel corpo diventa il simulacro di ogni fallimento, dalle cause processuali alla mancata promozione aziendale del marito, al faticoso avanzamento sociale nello scarso riconoscimento da parte della piccola comunità.
In un certo senso è come se mio padre, per tutta la vita, avesse confuso mia madre con una casa. Con la differenza che in una casa si possono fare degli interventi di valorizzazione senza chiedere il permesso, sul corpo di un’altra persona no.
Dröscher rintraccia nella dimensione domestica della sua infanzia il prisma attraverso cui osservare lo smarrimento dell’individuo e della società e dare forma a uno studio narrativo sulla scarsa attenzione verso la depressione, l’isolamento sociale, l’insicurezza emotiva; sull’esposizione infantile alla precarietà economica e affettiva con conseguente inversione di ruoli tra genitori e figli; sul mancato riconoscimento del sovraccarico emotivo e fisico di donne imprigionate nei doveri famigliari che trascorrono la maggior parte della vita a mettere da parte desideri e ambizioni in funzione delle responsabilità verso ruoli prestabiliti; sul velo tragico e triste che sovrasta esistenze condivise, trascorse permanendo in una condizione di estraneità reciproca.
Nel Kammerspiel che chiamiamo «famiglia» il bambino spesso finisce per diventare il parafulmine delle forze cui la donna è sottomessa nel patriarcato. Potrei stilare un lungo elenco dei gesti drammatici di mia madre. Il canovaccio scaraventato in cucina. La pentola sbattuta sulla tavola. Il cucchiaio di legno e il grembiule buttati via e lei che se ne va di punto in bianco lasciando ogni cosa sul fuoco. Lei che sale in macchina con lo sguardo inferocito e sfreccia via. Che all’improvviso smette di spazzare e getta la scopa in un angolo. Che si striglia i capelli lisci a colpi di spazzola. Anche mio padre possedeva questa drammaticità. È il linguaggio di tutta una generazione.
Bugie su mia madre si regge su ingrandimenti continui su scene del quotidiano che manifestano la complessità delle dinamiche relazionali, il significato della sorellanza, il ricatto della vacua armonia famigliare che sottende fratture tra accessi d’ira, silenzi e assoluta abnegazione, con miniature pervase di tristezza. Lei affacciata al balcone, che scruta il cielo con occhi nostalgici. Lei che inforna una torta con l’ultimo briciolo di forza che ha in corpo. Lei che sopporta stoicamente il dolore che le provoca ogni movimento. Ma la cosa peggiore era il suo sguardo. Ci brillava dentro una solitudine grave e grigia come il piombo.”
L’autrice si sofferma sul peso di condizionamenti culturali e sociali infestanti persino per il suo sguardo bambino, aggravati dalla diffidenza verso una donna considerata straniera perché figlia di tedeschi di Slesia immigrati nella provincia renana quando lei aveva sei anni. Tale aspetto è centrale nel comprendere la necessità della donna, in una comunità pervasa da stereotipi, di farsi largo anzitutto attraverso una cura estrema per il linguaggio e per la parola esatta, nella convinzione che la lingua sia la moneta in grado di definire l’appartenenza.
La storia personale si fa portatrice di una condizione condivisa per denunciare anche il paradosso esportato dagli Stati Uniti in particolare nel secondo Novecento in merito alla nuova attenzione riservata alla donna come consumatrice protagonista del mercato e al contempo vittima di canoni estetici irraggiungibili. Aspetti analizzati nell’opera attraverso un continuo rimando linguistico, a partire dalla riflessione sul momento in cui corpo e mente decidono di capitolare, rassegnandosi alla resa definitiva di fronte a un potere superiore.
L’opera è anche uno studio sulla figura del padre, su un patriarca non dominante ma insicuro, che vive un rapporto singolare con l’autorità, inesorabilmente assoggettato a una visione del lavoro con meccanismi proiettati sulla famiglia, e in linea con l’ideologia dilagante dal dopoguerra tedesco basata sulla ricostruzione, sul benessere e sul miracolo economico. Segnato dallo spauracchio del passato di povertà, nel desiderare il benessere finanziario l’uomo finisce per incarnare la figura del self-made man con contraddizioni come l’accettazione dello sbilanciamento salariare e dello sfruttamento di alcune tipologie di lavoratori. Nel profondo di tale visione si cela “la psicologia dell’uomo soldatesco, «corazzato», che traccia confini intorno a sé e li difende”.
Leggere Bugie su mia madre permette di interrogarsi sulla profonda attualità delle istanze sollevate dall’autrice nel porre implicitamente a confronto la società di quarant’anni fa e quella odierna a partire dal riconoscimento della necessità di una rivoluzione per contrastare la tendenza del patriarcato ad assoggettare le donne attraverso il controllo dei corpi, con una riflessione sul ruolo della scrittura come mezzo per indagare l’animo umano sulla soglia di menzogna e verità, sostanza e apparenza.
Scrivere non è una fuga. È fare un passo indietro. Fermarsi. Scrivendo posso abitare il confine tra fuggire e combattere. Senza paralizzarmi.
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.
(Minima&Moralia, 27 marzo 2025, https://www.minimaetmoralia.it/wp/libri/contro-lassedio-patriarcale-del-corpo-bugie-su-mia-madre-di-daniela-droscher/)
da il Corriere della Sera
Il libro che Viktorija Amelina voleva scrivere era il diario di un’investigatrice di crimini di guerra. Il libro che ha lasciato incompiuto è molto di più. La mattina del 24 febbraio 2022, quando è iniziata l’invasione su larga scala, quando i carri armati russi sono arrivati in un attimo alle porte di Kiev e gli elicotteri hanno cercato di conquistare l’aeroporto strategico di Hostomel’ (senza riuscirci), Viktorija Amelina stava rientrando da una vacanza in Egitto.
Ha scoperto che i voli per l’Ucraina erano stati cancellati, lo spazio aereo chiuso. Per alcune ore si è trovata in un non luogo. Non era nemmeno certo che l’Ucraina esistesse ancora. Da persone, gli ucraini erano «diventati la guerra». Amelina non poteva partire, non poteva restare. Alla fine, insieme ad altri, è riuscita a imbarcarsi su un volo per Praga. Solo dopo l’atterraggio si è messa a piangere. «“Mamma, perché piangi?” chiede mio figlio. “Perché siamo a casa” rispondo. “Ma qui non siamo in Ucraina” dice lui confuso. “Questa è Europa” rispondo».
Amelina lascia il figlio al sicuro in Polonia e prosegue il suo viaggio. Farà avanti e indietro molte volte, ma alla fine deciderà che il suo posto è l’Ucraina invasa, lontano dal figlio. Chiederà a un’altra poeta e autrice di libri per l’infanzia, Kateryna Mikhalitsyna, di aiutarla a trovare le parole giuste per spiegare al figlio quella scelta.
Nella prefazione a “Guardando le donne guardare la guerra” che esce per Guanda, Margaret Atwood parla di Viktorija Amelina come dell’Angelo Registratore, «che annota le buone e le cattive azioni». Definisce la sua scrittura «ispida, urgente, personale, dettagliata e sensuale». Io posso solo aggiungere che ho aspettato a lungo questo libro, ma leggendolo ho dovuto fermarmi più di una volta. Per lasciar depositare, per riprendere fiato.
Nella postfazione, invece, è Amelina stessa a spiegarsi: «Dal 24 febbraio 2022, da scrittrice sono diventata investigatrice di crimini di guerra, e poi ho dovuto imparare a fare entrambi i mestieri per raccontare a voi, al mondo, la storia della ricerca di giustizia da parte della società civile ucraina. Qui dovrebbe esserci anche la storia di come sto reimparando a essere madre per mio figlio di undici anni».
Amelina è cresciuta a Leopoli, accanto a una base militare, ma una parte della sua famiglia abitava a Lugansk, nel Donbass, quindi la sua infanzia si è svolta anche lì. Le zone ora occupate dai russi e che forse, chissà, verranno presto cedute in un negoziato ingiusto, rappresentavano per lei il luogo delle vacanze. L’invasione del 2014 le aveva rese irraggiungibili, aveva messo del filo spinato anche attorno alla memoria di Amelina: la linea di contatto, scrive, «mi separa dalla bambina russificata che sono stata in passato». Di quei luoghi irraggiungibili evoca le notti, l’Orsa Maggiore brillantissima in cielo. «Le stelle per me sono associate all’infanzia e a Lugansk. Sono cresciuta, Lugansk è stata occupata dai russi, il mondo è cambiato ma io non ho imparato a riconoscere nessun’altra costellazione».
Il libro incompiuto è pieno d’immagini così, dove la cronaca si fonde con il privato, la storia con la memoria, e cade ogni barriera fra testimonianza e diario intimo, fra scrittura giornalistica e romanzesca. «Tutto ciò che riguarda la guerra russo-ucraina è personale», ma solo una scrittrice di romanzi e una poeta poteva colmare la distanza residua fra attualità e sentimento che esiste ancora in molti di noi.
È per questo che “Guardando le donne guardare la guerra” sarà il libro sull’invasione dell’Ucraina. Anche fra vent’anni, quando ne saranno stati pubblicati molti altri, più compiuti, formalmente perfetti. Leggendolo, guardiamo una scrittrice guardare la guerra, ma non solo: la guardiamo abitarla, subirla e contrastarla, tentare di comprenderla con ogni strumento intellettuale a sua disposizione. «Ogni istante è pieno di significato e consapevolezza, o addirittura può essere cruciale».
Ci ricordiamo qual è il contributo insostituibile degli scrittori, cosa aggiungono alle migliaia di pagine di cronaca, ai filmati, alle analisi: i dettagli. I dettagli marginali, trascurabili eppure pieni di significato, memorabili. Come il momento in cui Amelina raggiunge la sua casa di Kiev, a pochi chilometri dal fronte, dopo il viaggio faticosissimo dall’Egitto attraverso la Repubblica Ceca e la Polonia, e nella dispensa trova «i biscotti comprati prima dell’invasione», che «non sono ancora andati a male».
Spesso le donne che Amelina intervista, tutte forti, determinate, crollano parlando degli animali. Il racconto ne è pieno. Cani, conigli, mucche e pecore uccise senza motivo, uno scarabeo portato in salvo nel mezzo di un bombardamento. È un tratto comune a molte guerre: le atrocità subite dagli esseri umani raggiungono presto un livello di saturazione emotiva, ma la violenza che si rovescia sugli animali innocenti scatena ancora delle reazioni. Il 12 marzo 2022 Amelina accoglie un’amica giornalista, Olena Stepanenko, alla stazione di Leopoli. Olena è riuscita a fuggire da Buča. Con un distacco raggelante le dice: «Ho visto cose terribili durante la fuga, ma non riesco a ricordarmele». Però si mette a piangere poco dopo, parlando del gatto che ha chiuso in casa nella speranza di tornare a nutrirlo. Olena si augura che i russi abbiano sfondato la porta e lui sia potuto fuggire. Strani, paradossali, i desideri che la guerra produce.
All’improvviso un appunto a pagina 109 ci fa sobbalzare. Amelina scrive: «Lo vedo, il futuro. Certo, possiamo essere colpiti da un Iskander da un momento all’altro, ma in qualche modo io vedo l’Ucraina dopo la guerra». È una premonizione. Un missile Iskander la ucciderà il 27 giugno 2023, mentre si trova nel ristorante Ria di Kramators’k. Un collaboratore dei russi verrà condannato per aver fornito le coordinate del bersaglio. Il resto della premonizione, vedere l’Ucraina dopo la guerra, rimarrà così una fantasia. Lo è ancora. Il tempo che è seguito all’assassinio di Amelina è bastato a finire il volume al suo posto, a tradurlo, a pubblicarlo anche qui, senza che la guerra di fermasse.
Proseguendo, la lettura diventa più difficile. Non solo perché il libro si frantuma in una raccolta di appunti, ma perché proprio la frantumazione lascia scaturire la violenza senza più mediazione, senza ritegno. Le torture, gli stupri, le detenzioni, le deportazioni, le mutilazioni. Le tre curatrici e il curatore di “Guardando le donne” hanno fatto bene a lasciare le frasi di Amelina interrotte, non sarebbe stato giusto confezionare una guerra ancora in corso, tentare di ripulirla. Solo Amelina avrebbe potuto farlo. Se ne avesse avuto il tempo avrebbe lavorato le sue note, levigandole, invece ci vengono consegnate crude, e anche per questo diventano all’istante una parte indispensabile della letteratura europea: «Abbiamo trovato Valya, ma non ne sapeva nulla. L’abbiamo abbracciata, perché ha perso suo figlio, e mi ha dato un sacchetto pieno di noci».
Nelle pagine si trovano molte considerazioni teoriche – su come istituire una nuova Norimberga, sul significato profondo della parola “genocidio” e sui limiti della definizione, sul proprio ruolo di scrittrice-investigatrice – ma non ci viene mai permesso di astrarre la guerra in considerazioni geopolitiche, in fantasie. Subito veniamo risbattuti a terra. Sono i dettagli a farlo, ancora una volta, i dettagli che Amelina raccoglie:
«Balaklija, giugno-agosto 2022: condizioni di detenzione disumane, minacce di essere usato come cavia per lo sminamento, tortura con pistola stordente, percosse con manganelli;
«Vesele: 2 persone, torture per annegamento in un secchio d’acqua… torture per impiccagione, percosse…;
«Husarivka: finte esecuzioni;
«Balaklija, aprile 2022: stupro».
Guardiamo Amelina guardare la guerra, perdere via via la capacità di trasfigurarla, aderire sempre di più al piano di realtà. Diventare in tutto e per tutto un’investigatrice di crimini, attenta al chi, al cosa, al come, al quando, perché la vera giustizia potrà iniziare solo così, da una documentazione meticolosa e ripetitiva, lontana dal sensazionalismo.
Il suo destino si salda a quello degli intellettuali ucraini uccisi in altre epoche. Il Rinascimento Giustiziato degli anni Trenta. Gli scrittori e gli artisti degli anni Sessanta. Vittime dei sovietici, della Russia che desidera più di ogni altra cosa eliminare ogni traccia della cultura ucraina, come se non esistesse. Ma ogni generazione indaga su quello che è accaduto alla precedente, evitando che accada.
In uno dei suoi viaggi di ricerca nelle zone liberate dalla controffensiva, Amelina ha fatto la scoperta più importante della sua vita. Sepolto nella terra del cortile della sua casa di Kapytolivka, ha trovato il diario di Volodymyr Vakulenko, uno scrittore come lei, sequestrato e ucciso dai russi. Ne ha curato la pubblicazione, lo ha mostrato al mondo. Un atto letterario che va oltre la letteratura, un atto civile che va oltre la civiltà.
Nell’ultima pagina di “Guardando le donne” Viktorija – “Vika” per tutti i suoi amici – è sul balcone della casa di Kiev e si accinge a scrivere la prefazione al diario di Vakulenko.
È cosciente che quello sarà il suo contributo alla storia dei massacri che proseguono nei secoli, ma non sa che non sarà il suo contributo più importante. Guardando i missili della contraerea levarsi in cielo annota queste frasi: «Non devo combattere alcuna paura. Non ho più paura di morire. Riesco perfino a immaginare quando tutte le donne che ho raccontato alla fine si incontreranno al mio funerale. Sono così prese a lottare per la giustizia che quella non sarà solo una buona occasione, bensì l’unica. Ma poi mi ricordo che devo ancora finire questo libro, guardare mio figlio crescere e forse, tra qualche anno, anche arruolarmi nell’esercito. Così lascio il mio balcone e questa magnifica seppure pericolosa vista e torno a scrivere».
Il volume
“Guardando le donne guardare la guerra. Diario di una scrittrice dal fronte ucraino”
di Viktorija Amelina (Leopoli, Urss, ora Ucraina, 1° gennaio 1986-Dnipro, Ucraina, 1° luglio 2023) esce il 18 aprile per Guanda (introduzione di Margaret Atwood, traduzione di Yaryna Grusha, pp. 330, euro 20). Viktorija Amelina è stata una scrittrice, saggista e poetessa. Si definiva una “investigatrice di crimini di guerra”. Nel 2021 Amelina aveva vinto il Joseph Conrad Literary Award per le opere in prosa ed era stata finalista allo European Union Prize for Literature e allo UN Women in Arts Award; nel 2024 le è stato assegnato postumo il Prix Voltaire Special Award. È morta quattro giorni dopo essere stata ferita da un attacco russo su Kramators’k.
da Doppiozero
Ci sono arrivata di colpo, come se la verità si fosse imposta con la forza dell’evidenza: chi commette i crimini più inimmaginabili alla luce del sole, alla lettera sotto i nostri occhi, può godere di una perfetta impunità proprio perché li commette apertamente, con sfrontatezza, senza bisogno di giustificarli.
Li commette, potremmo dire, “perché sì”.
Se così è, più il crimine è grande, più l’impunità è data. Era – e sotto altra veste e/o sigla continua a esserlo – la regola degli Imperi coloniali, ma anche del Ku Klux Klan. Si può, perché si è sicuri del vantaggio e dunque del consenso di alcuni, e della paura, dell’indifferenza o del servilismo dei più.
Lunedì 24 marzo 2025, mentre a Rafah, lembo meridionale della Striscia di Gaza, si bombardava uccidendo alla rinfusa civili, combattenti, giornalisti, personale sanitario, operatori umanitari, bambini, anziani, donne, a Susya, nell’area di Masafer Yatta, in Cisgiordania, le IDF, forze di difesa israeliane, arrestavano Hamdan Ballal, uno dei quattro registi di No Other Land, “pestato”, “linciato”, “picchiato a sangue” – secondo il vocabolario sempre più impreciso dei media – da coloni israeliani in armi spalleggiati dall’esercito di Israele.
Esattamente tre settimane prima, nella notte tra il 2 e il 3 marzo, quel film – realizzato dai palestinesi Hamdan Ballal e Basel Adra e dagli ebrei israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor – era stato insignito del premio Oscar come miglior documentario dell’anno. E gli occhi del mondo si erano puntati, d’un tratto, su quell’angolo di terra che molti neanche sapevano dove fosse e di quali eventi, da decenni, fosse scenario.
Nel febbraio scorso, scrivendone per “Doppiozero”, mi domandavo che cosa possa il cinema e come faccia a ottenerlo. Un film, in particolare se si definisce “documentario”, deve informare, mostrare, denunciare, commuovere, indignare? Oppure il suo compito è, appunto e innanzitutto, quello di documentare, ponendosi indirettamente come strumento politico del presente da un lato e prezioso contenitore di memoria dall’altro?
Come, in ogni caso, fare l’una e/o l’altra cosa, discostandosi attraverso la scrittura filmica dai reportage televisivi e dalle cronache in presa diretta diffuse dalla rete? Oggi, alla luce dei fatti appena accaduti, la questione è un’altra ed è infinitamente più grave e, sì, sconvolgente.
L’attenzione mondiale che l’Oscar ha richiamato sul diligente, appassionato lavoro di documentazione e denuncia dei quattro autori di No Other Land li ha sovraesposti, facendone un bersaglio ideale per chi sembra voler verificare senza tregua di quanto si possa spostare impunemente verso l’alto l’asticciola del consentito, del tollerabile, del moralmente lecito. Trasformati in star mediatiche e in oggetto di culto spettatoriale dal riconoscimento hollywoodiano, in altri tempi Ballal, Adra, Abraham e Szor sarebbero stati “intoccabili”. La loro fama avrebbe fatto loro da scudo: nessuno si sarebbe azzardato a sfiorarli, a rischio di produrre un effetto boomerang. Oggi, invece, è proprio la loro visibilità globale a suggerire di colpirli, ottenendo un duplice
effetto: punire e neutralizzare loro e misurare la soglia di tolleranza dell’opinione pubblica mondiale, lo stato di assuefazione o di sedazione in cui versiamo, la nostra residua capacità di distinguere il reale dall’immaginario e di reagire.
E se a Gaza, ridotta a camera della morte, è ripresa la mattanza è perché anche lì si sta testando l’atrofia del sensibile cui siamo giunti o – ma non è in fondo la stessa cosa? – la nostra incapacità di convertire in passioni attive e aggreganti i sentimenti di inquietudine, angoscia, depressione, vergogna, indignazione che pure abbiamo.
***
A distanza di ventiquattro ore dall’arresto e di una notte violenta in un carcere israeliano, Hamdan Ballal è tornato a casa. A difenderlo, l’avvocata ebrea israeliana Lea Tsemel, una delle figure più luminose, coerenti e incrollabili della galassia democratica di quel paese. Dalle cronache giornalistiche e televisive che riportano il fatto non è dato tuttavia capire perché Ballal sia stato oggetto di quell’angheria. Certo è che il suo “non anonimo” caso ha attirato l’attenzione dei media, distraendo l’opinione mondiale da quanto intanto accadeva a Gaza e, al contempo, confermando la legittimità dell’arbitrio. L’arbitrarietà, che si sa al di sopra del diritto, non è forse il corollario dell’evidenza di cui parlavo poc’anzi?
Il 19 luglio 2018 il parlamento israeliano approvava una legge costituzionale che faceva di Israele lo “Stato nazione del popolo ebraico”. Quel giorno stesso, dalle pagine del quotidiano israeliano “Haaretz”, il giornalista Gideon Levy la commentava con queste parole: «La legge sullo Stato nazione (che definisce Israele come la patria storica del popolo ebraico, incoraggia la creazione di comunità riservate agli ebrei, declassa l’arabo da lingua ufficiale a lingua a statuto speciale) mette fine al generico nazionalismo di Israele e presenta il sionismo per quello che è. La legge mette fine anche alla farsa di uno Stato israeliano “ebraico e democratico”, una combinazione che non è mai esistita e non sarebbe mai potuta esistere per l’intrinseca contraddizione tra questi due valori, impossibili da conciliare se non con l’inganno.
Se lo Stato è ebraico non può essere democratico, perché non esiste uguaglianza. Se è democratico, non può essere ebraico, poiché una democrazia non garantisce privilegi sulla base dell’origine etnica. Quindi la Knesset ha deciso: Israele è ebraico. Israele dichiara di essere lo Stato nazione del popolo ebraico, non uno Stato formato dai suoi cittadini, non uno Stato di due popoli che convivono al suo interno, e ha quindi smesso di essere una democrazia egualitaria, non soltanto in pratica ma anche in teoria. È per questo che questa legge è così importante. È una legge sincera».
Cito le parole di Levy, perché sincerità rima non da oggi con prepotenza. Si dice quel che si fa, si fa esattamente quel che si dice. In altri termini, tra il dire e il fare non c’è soluzione di continuità: si dice “inferno” e inferno è; si dice “li riporteremo all’età della pietra” ed ecco che la Striscia di Gaza si trasforma in un’apocalisse di macerie; si dice “li trasferiremo” ed ecco che i campi profughi di Cisgiordania vengono capillarmente smantellati, disperdendone gli abitanti e cancellando quel che resta dell’idea di “diritto al ritorno”.
Non credo sia necessario dire altro di ciò che sta avvenendo in Palestina. Per vedere, basta guardare. Mi preme invece ricordare che nulla di tutto ciò sarebbe possibile se lo “stato di esenzione” di cui Israele gode non fosse suffragato dai nostri governi, che in vario modo lo sostengono, legittimano e armano. Sì, il massacro oggi in corso a Gaza è un “genocidio assistito”. E altrettanto “assistito” è il piano di colonizzazione e annessione della Cisgiordania. Poiché ci pregiamo di essere cittadine e cittadini di uno stato democratico, se rimaniamo in silenzio ne siamo direttamente responsabili.
Ecco un raccolto strano e amaro*.
(*) Titolo e ultima frase dell’articolo si riferiscono alla canzone Strange Fruit (‘Strano frutto’) del 1939, interpretato dalla cantante blues Billie Holiday, in cui gli “strani frutti” che pendono dagli alberi sono i corpi dei neri linciati e impiccati dal Ku Klux Klan.
da Roba da femmine
È il 1987 quando, per iniziativa della Libreria delle donne di Milano, viene pubblicato “Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di donne”. Si tratta di un lavoro collettivo e alla base c’è un’idea dalla portata rivoluzionaria: scrivere una vera e propria genealogia femminile, non solo ricostruendone le radici passate ma soprattutto mettendo in parola, nero su bianco, l’esperienza di un gruppo di donne che, a Milano tra il 1966 e il 1986, hanno fatto materialmente pratica di cura, amicizia e collaborazione tra loro. In altre parole e più sinteticamente:hanno fatto pratica e politica femminista
Ho deciso di partire da qui per affrontare il tema di questa settimana perché ricordo chiaramente il momento in cui, leggendo questo libro per la prima volta, sono rimasta rapita dal concetto di affidamento. L’espressione si riferisce a un tipo di relazione particolare in cui quello che avviene è che una donna si affida a un’altra donna, osservandone i comportamenti, seguendo gli insegnamenti, imparando a stare al mondo.
È molto importante tenere a mente che il contesto è quello dell’Italia degli anni ’70 in cui, grazie al movimento femminista, si prende coscienza del fatto che le donne sono completamente escluse dalla sfera pubblica e l’unico modo per entrarci è replicare il comportamento della cultura maschile. In passato, costruire una rete simbolica, linguistica, comportamentale tutta al femminile, ha rappresentano una risposta al modello egemone maschile, una alternativa che ha reso possibile una modalità di conoscenza e apprendimento in cui le donne, ispirate e guidate da altre donne, sono riuscite a trovare la loro strada, a conoscere se stesse, costruendosi una propria identità. Le donne sono state modello per le altre donne. Vi chiedo di tenere a mente questo punto perché ci servirà tra poco.
Ho pensato alla pratica di affidamento femminista per tutta la settimana perché – per tutta la settimana – mi sono ritrovata a discutere dei temi affrontati dalla miniserie Netflix Adolescence.Ne ho parlato ampiamente dal mio profilo Instagram e se volete saperne di più vi rimando agli ottimi articoli di approfondimento scritti da Paolo Armelli, Sara Uslenghi e Lorenza Negri per Wired. A distanza di giorni continuo a credere che il grande merito della serie sia stato quello di mostrare gli effetti di fenomeni la cui conoscenza non è scontata né mainstream. Abbiamo sentito nominare parole come incel, manosfera, redpille non meno importante persino Andrew Tate, l’influencer misogino attualmente sotto processo per tratta di esseri umani e stupro. Adolescence fa conoscere al pubblico ciò che la teoria femminista conosce e monitora da molto tempo.
Partiamo dalla base: si identificano sotto l’etichetta di InCel (Involuntary celibates) uomini soli, incapaci di instaurare relazioni sentimentali e sessuali con le donne. Questa incapacità non è riconosciuta come tale anzi, al contrario, dal loro punto di vista ad essere colpevoli di questa mancanza relazionale sono proprio le donne che, per questo motivo, sono viste come il sesso nemico da perseguitare e, nei casi estremi, distruggere, annientare.
Si tratta di una sottocultura radicalizzata che agisce soprattutto nelle piattaforme online, blog, canali telegram dedicati dove è possibile portare avanti senza alcun controllo idee misogine e campagne di odio verso le donne. Questa fittissima rete virtuale viene indicata con il nome di manosphere (maschiosfera), una dimensione maschiocentrica in cui tutto ruota attorno a una determinata idea di uomo e di mascolinità. La sottocultura InCel e le questioni ad essa connesse sono al cento dei Men’s studies il filone di ricercaanglosassone che si occupa di studiare in che modo le influenze culturali e sociali agiscono sui modelli di mascolinità dominante. Tuttavia è dagli anni 2000 che, con l’affermazione dei social media e in concomitanza con stragi connesse a gravi episodi di violenza maschile, il fenomeno InCel diventa una questione estremamente urgente.
I celibi involontari vengono anche chiamati “casti non per scelta” e io trovo molto centrato il riferimento alla castità (e dunque alla sessualità) perché il sesso – lo sappiamo bene – è uno strumento di potere e di controllo e attraverso la sua assenza, ovvero la mancanza della sessualità agita e scelta dagli uomini, emerge la frustrazione di una modalità di vivere la condizione maschile che non conosce alternative.
Questo gruppo di uomini che odia le donne individua nel femminismo l’origine di tutti i mali perché lo considera colpevole di avere promosso l’emancipazione femminile attraverso la conquista dei diritti, prendendo di mira la maggiore e nuova esposizione delle istanze femministe, resa possibile anche grazie al femminismo della quarta ondata la cui spinta è connessa al mondo online. Ma l’incitamento allo stupro o alla schiavitù sessuale – pratiche considerate necessarie per riportare all’ordine le donne – rappresenta solo la manifestazione più estrema di un problema che in realtà resta diffuso perché completamente normalizzato, e che, inevitabilmente, sfugge al confinamento virtuale e prende vita nella realtà. La misoginia quotidiana è introiettata nella nostra società al punto da essere invisibile. Ci siamo assuefatti alla misoginia.
Se vi state chiedendo in che modo questo sia possibile, vi invito a fare un giro su Youtube o Spotify per vedere – per esempio – quanti podcast, fatti da uomini per gli uomini, sono interamente dedicati alla promozione di una cultura misogina dove viene veicolata una violenza indicibile senza nessun tipo di conseguenza, tranquillamente alla luce del sole; esistono interi profili di dating coach, ovvero coloro che si definiscono “artisti della seduzione”, che sono impegnati a condividere tecniche per conquistare le donne ridotte semplicemente a meri oggetti sessuali. Anche questi impuniti e alla luce del sole.
Recentemente un personaggio controverso come Fabrizio Corona ha calcato due teatri importanti, Il teatro Nazionale di Milano e l’Alfieri di Torino, portando avanti uno spettacolo di quasi due ore dove vessava e insultava letteralmente donne note come Selvaggia Lucarelli, Elodie o Giorgia Meloni.
Tutto questo davanti a un pubblico visibilmente divertito e – ricordiamolo – pagante. La nostra società è disposta a pagare per vedere una violenza che dovrebbe essere sempre e solo condannata.
Tra gli InCel compaiono anche gli MRA (men’s rights activists) ovvero gli attivisti per i diritti degli uomini che nell’ultima campagna elettorale americana sono stati individuati da Trump come una fetta elettorale importante su cui concentrare le energie e infatti hanno rappresentato il 60% dei voti andati al partito repubblicano.
Anche in Germania, abbiamo assistito a uno scenario simile dove il partito dell’ultradestra Alternative für Deutschland è stato il più votato dai giovani maschi mentre le giovani donne tra i 18 e i 24 anni hanno votato per il 34% il partito di estrema sinistra Die Linke. Si chiama Modern Gender Gap ed è il fenomeno per cui le giovani donne (tendenzialmente più formate, lavoratrici e indipendenti) sono sempre più progressiste e votano a sinistra e i giovani uomini, sempre più conservatori, votano a destra.
Se i giovani uomini votano a destra è perché nelle destre dei nazionalismi vedono rappresentata quell’idea di forza, prepotenza e mascolinità che reputano un modello da seguire. Vedono rappresentata una visione di mondo ostile alle donne, sempre più misogina e violenta, che ostacola intenzionalmente i diritti civili e la libertà femminile. Il sessismo e il razzismo diventano una fortezza per assicurarsi di poter mantenere una identità che deve essere preservata.
Se ho iniziato questa newsletter raccontandovi della pratica dell’affidamento femminista è perché ritengo necessario che una pratica simile venga messa in atto anche nella sfera maschile. Abbiamo un disperato bisogno di uomini che si facciano carico di altri uomini, diventando modelli alternativi a quelli machisti promossi dalle destre mondiali. È un compito difficile perché se, nella loro storia, le donne lo hanno sempre fatto, gli uomini no. Si tratta ora di un richiamo alla responsabilità che è anche un richiamo alla sopravvivenza.
Questa volta non quella femminile, ma soprattutto maschile.
(Newsletter Roba da femmine, 26 marzo 2025)
da Doppiozero
«Anche noi siamo così abbagliati dal potere e dal prestigio da dimenticare la nostra fragilità essenziale: col potere veniamo a patti, volentieri o no, dimenticando che nel ghetto siamo tutti, che il ghetto è cintato, che fuori dal recinto stanno i signori della morte, e che poco lontano aspetta il treno.» Primo Levi, I sommersi e i salvati
«Se la solidarietà del genere umano deve essere basata su qualcosa di più solido della giustificata paura riguardo alle demoniache capacità dell’uomo, se la nuova e universale vicinanza di tutte le nazioni deve avere come risultato qualcosa di più promettente del terrificante aumento di odio reciproco e di una alquanto generale irritabilità di tutti contro tutti, allora deve verificarsi su scala macroscopica un processo di reciproca conoscenza e di crescente comprensione di sé.» Hannah Arendt, Humanitas mundi
Un duplice esergo, che segue una dedica: «A PalFest e JVP, due fari», dove abbreviazione e acronimo stanno per Palestine Festival of Literature e Jewish Voice for Peace.
Si apre così Il mondo dopo Gaza (tr. it. di Tiziana Lo Porto, Guanda 2025), saggio storico e politico in tre parti più un prologo e un epilogo fulminanti, pubblicato simultaneamente negli Stati Uniti, in Inghilterra, Germania, Spagna, Italia. Ne è autore il saggista e narratore indiano Pankaj Mishra, noto in Italia per i romanzi I romantici (Guanda 2020) e Figli della nuova India (Guanda 2023) e per le sue collaborazioni con le principali testate angloamericane – “Guardian”, “London Review of Books”, “New York Times”, “New Yorker” – e il settimanale italiano “Internazionale”. Nonostante la sua densità e la sua multidisciplinare erudizione, lo si legge in un soffio, come se la passione e la magnifica penna narrativa di Mishra, il suo sguardo acuto e sghembo di “osservatore distante”, la sua dichiarata alterità culturale producessero nel lettore occidentale quel tipo di spaesamento fertile che si prova quando ci si scopre non più detentori assoluti della visione e dunque dell’interpretazione.
Pankaj Mishra conosce perfettamente la storia occidentale, l’ha studiata, letta, osservata, potremmo dire che l’ha vissuta sulla propria pelle come cittadino di un paese che è stato colonia dell’Impero britannico fino al 15 agosto del 1947, giorno in cui fu proclamata l’indipendenza e sancita la partizione del subcontinente indiano in due stati sovrani, il Pakistan (poi Repubblica islamica del Pakistan) e l’Unione dell’India (poi Repubblica dell’India).
La sua dunque è una “posizione eccentrica”, che gli permette di non impigliarsi nelle storie altrui, ma di riconoscersi in esse per via di comparazione, empatia e immaginazione. La sua prospettiva non è la nostra: è più ampia, meno locale. E tuttavia ciò che ha segnato il nostro orizzonte storico lo interpella al punto da farglielo sentire anche suo. Lo sapevamo, vero, che il Centro – troppo a lungo ritenuto coincidente con l’Occidente – è così autoriferito da essere cieco? È dai cosiddetti margini, la porzione più grande di mondo, che si vede con nitidezza. In questo particolare momento della storia ciò che da lì si vede deve essere assai simile a una mischia per vedere chi è il più forte.
Il mondo e Gaza, dunque. Da un lato, uno spazio geografico immenso e un’entità politica variegata, disomogenea, conflittuale; dall’altro, un’esile striscia di terra, 360 km² in tutto, oggi in via di rapido, progressivo restringimento. Una popolazione complessiva di oltre 8,2 miliardi di persone (dati aggiornati al 21 marzo 2025) contro una popolazione di 2 milioni e trecentomila persone (dati ottobre 2023), oggi falcidiata dall’operazione “Spade di ferro” condotta dalle forze armate israeliane a partire dall’ottobre del 2023 e dall’evacuazione in corso con il beneplacito dell’Occidente e dei paesi arabi.
Tra i due termini, l’autore ha scelto di collocare un avverbio di tempo: dopo. Come se Gaza non fosse un luogo, ma un evento periodizzante, uno spartiacque epocale che disegna una nuova, disastrosa cartografia. Trasformata in camera della morte, sottoposta a una radicale opera di sbancamento, la Striscia parla di un prima in via di cancellazione e di un dopo che alternativamente somiglia – per usare i termini adottati dal primo ministro di Israele e dal presidente degli Stati Uniti – a un “inferno” e a un gigantesco “cantiere”.
Per Pankaj Mishra tale scansione temporale non riguarda solo quel lembo di terra e il popolo che lo abita, bensì appunto il mondo e tutte e tutti noi. «Le mie origini indiane e il mio interesse per le società non occidentali», scrive, «mi hanno predisposto a guardare all’apocalisse razziale europea di metà Novecento insieme, piuttosto che separatamente, ad altre atrocità subite dalle minoranze e dai popoli colonizzati nell’era moderna». È questo che gli permette di individuare il «dispotismo intellettuale» che oggi governa il pensiero e le azioni delle istituzioni occidentali e di reagire scrivendo un libro il cui fine è «alleviare il mio sconcerto di fronte al degrado morale generalizzato e invitare i lettori ad approfondire, a cercare spiegazioni più urgenti che mai in questo periodo buio».
La sua è altresì una motivazione personale: non si può essere spettatori silenti e passivi della barbarie senza esserne corresponsabili. Movente e motore della scrittura sono dunque «il senso di colpa, una condizione umana diffusa dopo la distruzione in diretta di Gaza, e il dovere che i vivi hanno nei confronti dei morti innocenti».
Per capire bene la magnitudine e il coraggio dell’operazione compiuta da Mishra va detto che il suo saggio può essere letto come un romanzo di formazione: dall’originaria fascinazione per il nascente stato di Israele del 1947/48 e le sue successive imprese di conquista territoriale alla consapevolezza sempre più critica della natura coloniale del progetto sionista in terra di Palestina. «Crescendo in India negli anni Settanta», scrive Mishra, «avevo sulla parete una foto di Moshe Dayan, ministro della Difesa israeliano durante la Guerra dei sei giorni», aggiungendo subito dopo che quell’infatuazione per gli eroi israeliani «era irresistibile anche perché in India era fascinosamente illecita». Ed ecco il personale autobiografico intrecciarsi per contrapposizione all’allineamento politico dell’India di Nehru, che insieme all’Iran e alla Jugoslavia sostiene un piano per includere due stati autonomi, uno arabo e l’altro ebraico, in una Palestina federale unificata. Bocciato quel piano, l’India si unirà ai paesi asiatici e africani votando contro la Risoluzione 181 delle Nazioni Unite, che il 27 novembre 1947 approvano il Piano di partizione della Palestina, e fino al 1992 resterà saldamente dalla parte dei palestinesi e dei loro diritti di popolo usurpato.
Nella prima parte del saggio, intitolata “L’aldilà della Shoah”, Mishra indica altresì un diverso intreccio, che potremmo definire generazionale e transculturale. La sua educazione sentimentale alla storia e alla geopolitica avviene sulle stesse opere che all’epoca facevano piangere e sognare gli adolescenti d’Europa e d’America: Exodus di Leon Uris, Dossier Odessa di Frederick Forsyth, 90 minuti a Entebbe di William Stevenson. Il “discorso” fortemente persuasivo e toccante in cui l’Olocausto si inquadra a livello globale ha finito per eclissare la storia e il ruolo modernizzante giocato dagli ebrei proprio là dove sono stati sterminati, cancellandoli due volte. «Di certo», commenta Mishra, «nessun gentile poteva competere in quanto a passione per l’uguaglianza con Karl Marx, Rosa Luxemburg e Lev Trockij. In tutto l’Occidente molti tra coloro che sostenevano i diritti uguali e inalienabili dell’uomo e i concetti di legge naturale universale e sovranità popolare erano ebrei. Ma questa identificazione con il cosmopolitismo liberale e l’universalismo sociale non fece altro che contribuire ulteriormente a identificare gli ebrei con tutti gli odiati turbamenti dell’umanità».
C’è, in questa prima parte del libro, una messe di citazioni che si propongono come una sorta di bibliografia ideale – da Einstein a Freud, Arendt, Zweig, Amery, Levi, Klemperer, Musil, Bauman – contro la tentazione nazionalistica. Nel 1919 Zweig, oppositore del sionismo immaginato da Herzl, scrive: «Politicamente vedo il compito degli ebrei nello sradicare il nazionalismo in tutti i paesi». E Victor Klemperer, autore di LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, nel 1934 annota nel suo diario: «Per me i sionisti, che vogliono tornare allo stato ebraico del 70 d. C. (distruzione di Gerusalemme da parte di Tito), sono offensivi tanto quanto i nazisti. Con il loro fiuto per il sangue, le loro antiche “radici culturali”, il loro in parte snob, in parte ottuso riavvolgere il mondo, sono assolutamente tali e quali ai nazionalsocialisti». E nel 1939 ribadisce: «Le comunità ebraiche in Germania oggi sono tutte fortemente inclini al sionismo, e a me sta bene quanto potrebbe starmi bene il nazionalsocialismo o il bolscevismo. Liberale e tedesco per sempre».
Nella seconda parte del saggio, intitolata “Ricordare per ricordare la Shoah”, Mishra affronta di petto due temi scomodissimi: da un lato, la mancata denazificazione della Germania e al contempo la sua non paradossale transizione «dall’antisemitismo al filosemitismo»; dall’altro, «l’americanizzazione dell’Olocausto». Quello che ci propone è un ragionamento sulla memoria e sulla sua strumentale manipolazione. Il nazismo, ci ricorda l’autore, oltre alla sua opera di sterminio, ha creato centinaia di migliaia di rifugiati. «Ma né il dipartimento di stato americano né il ministero degli Affari Esteri britannico desideravano salvarli. Al contrario: temevano costantemente, e lavoravano per evitarla, una situazione in cui la Germania e le potenze del suo schieramento avrebbero costretto decine di migliaia di ebrei a consegnarsi nelle mani degli Alleati.»
Ecco perché, oggi, è indispensabile indagare tanto l’aspetto morale e ideologico della simbiosi americano-israeliana quanto l’irrigidimento filoisraeliano della Germania. A che cosa e a chi giova quel patto, che non può essere solo frutto di un senso di colpa inestirpabile. Come si spiegherebbe, se no, che quei due paesi siano così ciechi e consenzienti, se non direttamente complici, del genocidio in atto a Gaza e del piano di espulsione e annessione che sta investendo la Cisgiordania? E se, si domanda Mishra, Israele facesse da testa di ponte ridisegnando la morale e indicando un futuro in cui le regole democratiche maturate nel secondo dopoguerra non valgono più? Che sia un caso che le tecniche di “contenimento” e repressione delle IDF siano migrate nelle strade dei quartieri neri e ispanici degli USA, nelle piazze della contestazione studentesca a fianco della resistenza palestinese, ai confini sempre più vigilati dell’Occidente?
Tenete d’occhio «la linea del colore», suggerisce l’indiano Mishra, e dal magma nebuloso del presente comincerete a vedere affiorare forme chiare e distinte: l’“altro”, il nemico interno ed esterno, lo straniero, l’immigrato, il richiedente asilo, colui/colei che attenta alla bianchezza e ai suoi privilegi.
Ed è su questo punto che il saggio si chiude, sull’incapacità di un Occidente sempre più inconsistente e inquieto di andare “Al di là della linea del colore”, di prendere in considerazione «che l’evento più importante del Ventesimo secolo potesse non essere la Prima o la Seconda guerra mondiale, la Shoah, la Guerra Fredda o, per estensione, il crollo del comunismo, bensì la decolonizzazione». Schematici, pigri o forse semplicemente autoriferiti, gli opinionisti occidentali della seconda metà del secolo scorso, cresciuti in «un mondo privo di scelte difficili, economiche o politiche» si sono assestati nella comoda riorganizzazione post-1945 in tre sfere geopolitiche: l’Occidente, l’Unione Sovietica e il Terzo Mondo. Attribuendo alle democrazie occidentali il ruolo di garanti della libertà e di rappresentanti della civiltà di contro a nemici totalitari o autoritari e, a partire dagli anni Novanta, irreversibilmente votati al terrorismo, parola passe-partout o chiave universale per indicare ogni forma di resistenza, insubordinazione, rivolta. Un mondo sempre più in bianco e nero, conclude Mishra, sempre più diviso in “noi” e “loro”.
Il confine tra etnie, religioni, razze è tuttavia del tutto artificiale, poroso e instabile. Per renderlo invalicabile è necessario fare un assillante lavoro di propaganda. Ed è qui, con un atto di omaggio tra i più commoventi del libro, che lo scrittore cede la parola all’autore di I sommersi e i salvati: «Primo Levi avvertiva nel suo ultimo libro che anche le testimonianze dei sopravvissuti, “al di là della pietà e dell’indignazione che suscitano”, dovrebbero essere lette con “occhio critico”», dal momento che la memoria tende a una stilizzazione e a una semplificazione eccessiva. Levi deplorava la «tendenza manichea» nei resoconti storici «che rifugge dalle mezze tinte e dalle complessità: è incline a ridurre il fiume degli accadimenti umani ai conflitti, e i conflitti a duelli, noi e loro».
Eppure quella tendenza è di nuovo tra noi ed è particolarmente insidiosa, perché nasce dalla paura, da un vero e proprio panico da “sostituzione”, come se non ci fosse spazio per noi e loro insieme. Il paradigma di Gaza non illustra proprio questo? Una furia di annientamento, contagiosa perché – ove necessario – ogni Occidente è capace di crearsi il proprio irredimibile “altro” e di attrezzarsi per sterminarlo. A questa «psicosi di sopravvivenza», che ha prodotto «i crimini di Gaza e i numerosi atti di complicità e voluta indifferenza che li hanno resi possibili», stanno oggi rispondendo, proprio nel cuore dell’Occidente, i più giovani. Feriti nell’anima da un mondo che inscena con orgoglio lo sterminio “giustificato” di bambini, donne e uomini innocenti, i ragazzi e le ragazze – ed è su questa nota che conclude Mishra – non esitano a scendere in piazza. «Non hanno fatto, e probabilmente non faranno, cambiare idea all’indurita opinione pubblica occidentale. […] Ma le manifestazioni di indignazione e gli atti di solidarietà che hanno avuto luogo in questi mesi potrebbero avere in qualche modo alleviato la grande solitudine del popolo palestinese.»
Per approfondire
Segnalo, accanto all’imperdibile libro di Pankaj Mishra, il “dopo Gaza” delineato da una serie di altre preziose pubblicazioni degli ultimi mesi:
– Raja Shehadeh, Che cosa teme Israele dalla Palestina? (Einaudi, 2024)
– Samah Jabr, Il tempo del genocidio. Rendere testimonianza di un anno in Palestina (Sensibili alle foglie, 2024)
-Jean-Pierre Filiu, Perché la Palestina è perduta ma Israele non ha vinto (Einaudi, 2025)
– Lorenzo Kamel, Israele-Palestina in trentasei risposte (Einaudi, 2025)
– AA.VV., Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza (Fazi, 2025)
– Rashid Khalidi, Palestina. Cento anni di colonialismo, guerra e resistenza (Laterza, 2025)
da Emma
Il commissario Simon Häggström invita le politiche e i politici tedeschi che continuano ad avere dubbi sulla punibilità dei clienti. Ha raccontato nel suo libro “Auf der Seite der Frauen” [Dalla parte delle donne] come funziona il “modello nordico” e come lui e le sue colleghe e colleghi arrestano i clienti e proteggono le prostitute
Naturalmente gli si deve porre quella domanda, perché è l’argomento principale contro la perseguibilità del cliente, che la Svezia ha introdotto già nel 1999. «Molta gente obietta: se si punisce il cliente, la prostituzione scivola nell’illegalità e dopo la polizia non può più individuare i trafficanti di donne. Che cosa ne pensa?» chiede quindi Kerstin Neuhaus dell’associazione “AugsburgerInnen gegen Menschenhandel”1. E benché Simon Häggström abbia sicuramente risposto già migliaia di volte a questa domanda negli ultimi dieci anni, lo fa anche stasera a Bonn, una volta di più e in tutta chiarezza: «Questa è la più grande menzogna che si racconta sul “modello nordico”!».
Questa era la risposta breve. La versione lunga suona così: «La prostituzione non può sprofondare nell’invisibilità perché prostitute e clienti devono incontrarsi», spiega Häggström. Il commissario della polizia criminale svedese lavora dal 2009 nel Dipartimento Prostituzione della polizia di Stoccolma e ora ne è il dirigente. «Quando una donna arriva in città, deve potersi proporre ai clienti. Quindi si mette su Internet. E se i clienti possono trovarla, possiamo anche noi».
Simon Häggström ci ha scritto un libro, su come fanno lui e i suoi tre collaboratori e collaboratrici a scovare i clienti. E ad aiutare le donne che si prostituiscono. Innanzitutto, a difendersi dai clienti brutali. E contemporaneamente a sfuggire ai loro sfruttatori e ad uscire dalla prostituzione. Per questo il libro si intitola “Auf der Seite der Frauen” [‘Dalla parte delle donne’, NdT] nell’edizione tedesca. Il commissario lo sta presentando in quattordici città tedesche, tra cui Bonn su invito di Solwodi2. Che il libro, già apparso in svedese e in inglese fin dal 2017, sia stato finalmente tradotto e pubblicato in tedesco lo si deve a un’iniziativa privata: le “AugsburgerInnen gegen Menschenhandel” ne hanno organizzato la traduzione, la stampa e anche il giro di presentazioni. Kerstin Neuhaus modera la serata.
Bisogna anche considerare cosa succede se una donna non si registra all’autorità. Qua in Germania sono registrate ufficialmente soltanto 40.000 prostitute circa, però complessivamente nel paese ci sono circa 300.000 donne in prostituzione, quindi più di un quarto di milione esercita illegalmente l’attività. «Questo fa sì che si crei della prostituzione in nero» constata il commissario, e spiega: «La probabilità che in Germania una donna che si prostituisce illegalmente denunci un problema alla polizia è pressoché nulla».
In Svezia va in tutt’altro modo. Lì la polizia si presenta alle donne e spiega loro che dalle forze dell’ordine non hanno niente da temere. E che hanno diritto ad aiuto e protezione. Molte donne arrivano da paesi in cui erano le “ultime degli ultimi”, per esempio le Sinti in Romania. «Alcune non hanno mai avuto l’esperienza di vedersi parlare rispettosamente da qualcuno che le guardasse negli occhi. Questo ci apre delle porte».
Simon Häggström ha avuto un vero e proprio shock quando durante la sua visita è stato a vedere le zone a luci rosse tedesche. La cosa peggiore per lui sono state le Verrichtungsboxen, le “cabine da prestazione” nella Kurfürstenstraße di Berlino. Lì il Comune ha installato dei gabinetti per le prostitute da marciapiede, in cui i clienti usano le donne.
Simon Häggström non può farsene una ragione e si scusa con il pubblico per il suo linguaggio. «Lì dentro c’è merda, urina, sporcizia. È fuori da ogni dignità umana». Anche se si considera la prostituzione un lavoro come un altro, com’è opinione corrente in Germania, sono comunque condizioni di lavoro che non si possono imporre a nessuno. «In Svezia però la prostituzione non la consideriamo un lavoro come un altro, bensì un aspetto della violenza maschile contro le donne». Per questo gli uomini che comprano le donne in Svezia vengono perseguiti. Quando la Svezia nel 1999 introdusse la punibilità del cliente – come parte del programma Kvinnofrid [‘pace per le donne’] di contrasto alla violenza contro le donne – la pena consisteva solo in un’ammenda proporzionale al reddito. «Tuttavia in seguito ci sono state sempre più proteste da parte dell’opinione pubblica perché gli uomini che comprano le donne se la cavavano troppo a buon mercato», racconta Simon Häggström. Dall’estate del 2022 per l’acquisto di sesso si commina sempre un mese di detenzione con due anni di libertà condizionata. Inoltre il reato resta per dieci anni sulla fedina penale. «E con questo in Svezia diventa difficile trovare lavoro, perché l’acquisto di donne è uno dei reati più vergognosi che abbiamo».
Il divieto di comprare sesso in Svezia ha avuto «un grande effetto normativo. Ha cambiato la mentalità», spiega il commissario. Soltanto un uomo su dieci/quattordici (a seconda dei sondaggi) in Svezia frequenta ancora prostitute. In Germania uno ogni quattro.
Ma anche nel nostro paese sono successe molte cose. Grazie, non da ultimo, al lavoro di informazione fatto da EMMA e da altre realtà che sono nate negli ultimi anni. Hanno tutte contribuito a fare chiarezza sulle drammatiche conseguenze della riforma rosso-verde della legge sulla prostituzione del 2001. Riforma che ha reso la Germania il paradiso dei tenutari di bordello, dei magnaccia e dei trafficanti di donne. Mentre in Germania gli sfruttatori della prostituzione giubilavano e si riempivano le tasche, seguendo l’esempio svedese un paese dopo l’altro introduceva la punibilità del cliente, depenalizzando contemporaneamente la posizione delle donne prostituite. Il cosiddetto “modello nordico” è in vigore oggi in quasi tutta l’Europa occidentale e arriva fino a Israele e al Canada. Arriverà presto anche in Germania?
Finalmente la CDU/CSU3 ha inserito nel programma politico del partito l’introduzione del modello nordico. Stiamo in attesa della posizione che risulterà dalla trattativa per la coalizione con la SPD4. Tuttavia anche tra i socialdemocratici aumentano le prese di posizione a favore della perseguibilità del cliente. Perfino il cancelliere uscente Olaf Scholz aveva spiegato che trova «inaccettabile che gli uomini comprino le donne».
«Che cosa consiglierebbe ai politici tedeschi?» chiedono al commissario Häggström a fine serata.
«Di guardare da dove arrivano i dati in loro possesso», risponde lui. «Naturalmente circolano molte menzogne sul modello nordico, perché è una grande minaccia per tutti gli sfruttatori della prostituzione. Tutte le zone a luci rosse della Germania dovrebbero chiudere». Ed esprime un invito alle politiche e ai politici scettici: «Venite in Svezia e verificate sul posto come funziona il modello nordico!» Sarebbe auspicabile che quelle e quelli che hanno ancora dei dubbi accettassero l’invito del commissario.
(www.emma.de, 25 marzo 2025, traduzione di Silvia Baratella)
(1) ‘Cittadine e cittadini di Augusta contro la tratta’ (NdT).
(2) acronimo di di Solidarity with Women in Distress – Solidarität mit Frauen in Not, ovvero ‘Solidarietà con donne in emergenza’, associazione tedesca che sostiene le donne vittime di tratta e di violenza sessuale e domestica (NdT).
(3) Christlich-Demokratische Union, Christilich-Soziale Union nel Land della Baviera, Unione Cristiano-democratica (cristiano-sociale in Baviera), il maggior partito conservatore in Germania.
(4) Sozialdemokratische Partei, Partito Social-democratico, il maggior partito di centro-sinistra.
Di seguito il testo originale tedesco,
Fordert Kommissar Simon Häggström deutsche PolitikerInnen auf, die immer noch an der Freierbestrafung zweifeln. Wie das „Nordische Modell“ funktioniert und wie er und seine KollegInnen Freier verhaften und Prostituierte schützen, erzählt er in seinem Buch „Auf der Seite der Frauen“.
Natürlich muss man ihm diese Frage stellen, denn sie ist das Hauptargument gegen die Freierbestrafung, die Schweden schon 1999 eingeführt hat. „Viele Menschen behaupten: Wenn man die Freier bestraft, rutscht die Prostitution in die Illegalität und dann kann die Polizei die Menschenhändler gar nicht mehr fassen. Was sagen Sie dazu?“ fragt also Kerstin Neuhaus von der Initiative „AugsburgerInnen gegen Menschenhandel“. Und obwohl Simon Häggström diese Frage in den letzten zehn Jahren wohl schon an die tausend Mal beantwortet hat, tut er es an diesem Abend in Bonn noch ein weiteres Mal, und das in aller Klarheit: „Das ist die größte Lüge, die über das Nordische Modell erzählt wird!“
Das ist die kurze Antwort. Die lange Fassung geht so: „Prostitution kann nicht in den Untergrund rutschen, weil sich Prostituierte und Kunden finden müssen“, erklärt Häggström. Seit 2009 arbeitet der Kriminalkommissar im Stockholmer Dezernat für Prostitution und ist inzwischen dessen Leiter. „Wenn eine Frau neu in die Stadt kommt, muss sie sich den Freiern anbieten. Sie inseriert im Internet. Und wenn die Freier sie finden können, können wir es auch.“
Simon Häggström hat ein Buch darüber geschrieben, wie er und seine drei MitarbeiterInnen das machen: die Freier finden. Und den Frauen, die sich prostituieren, helfen. Dabei, sich gegen brutale Freier zur Wehr zu setzen. Dabei, ihren Zuhältern zu entkommen und aus der Prostitution auszusteigen. „Auf der Seite der Frauen“ lautet deshalb der Titel des Buches. In 14 deutschen Städten hat der Kommissar es gerade vorgestellt, so auch auf Einladung von Solwodi in Bonn. Dass das Buch, das schon 2017 auf Schwedisch und Englisch erschienen ist, jetzt endlich auch in deutscher Übersetzung vorliegt, ist einer privaten Initiative zu verdanken: Die „AugsburgerInnen gegen Menschenhandel“ haben Übersetzung, Herstellung und auch die Lesereise organisiert. Kerstin Neuhaus moderiert den Abend.
Das gilt auch, wenn eine Frau sich nicht bei den Behörden anmeldet. Da in Deutschland nur rund 40.000 Prostituierte offiziell registriert sind, sich hierzulande aber insgesamt rund 300.000 Frauen prostituieren, gehen also eine Viertelmillion Frauen einer illegalen Tätigkeit nach. „Das verursacht doch Prostitution im Dunkelfeld“, stellt der Kommissar fest und erklärt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in Deutschland eine Frau, die sich illegal prostituiert, mit einem Problem an die Polizei wendet, ist darum gleich Null.“
In Schweden sei das anders. Dort stellt sich die Polizei den Frauen vor und erkläre ihnen, dass sie von ihr nichts zu befürchten hätten. Und dass sie Anspruch auf Schutz und Hilfe haben. Viele Frauen kämen aus Ländern, in denen sie zu den „Untersten der Untersten“ gehören, zum Beispiel Sinti in Rumänien. „Sie haben noch nie erlebt, dass jemand auf Augenhöhe und respektvoll mit ihnen spricht. Das öffnet uns Türen.“
Regelrecht schockiert hat Simon Häggström, was er bei seinen Besuchen in den deutschen Rotlichtbezirken zu sehen bekam. Am schlimmsten seien für ihn die „Verrichtungsboxen“ in der Berliner Kurfürstenstraße gewesen. Dort hat die Stadt am Straßenstrich Klohäuser aufgestellt, in denen die Freier die Frauen benutzen.
Simon Häggström kann es nicht fassen und entschuldigt sich beim Publikum vorab für seine Wortwahl. „Da ist Scheiße, da ist Urin, da ist Dreck. Das ist jenseits der Menschenwürde.“ Selbst wenn man, wie in Deutschland üblich, Prostitution als normalen Job betrachte, seien das trotzdem Arbeitsbedingungen, die man niemandem zumuten könne. „In Schweden betrachten wir Prostitution aber nicht als normalen Job, sondern als Teil der Männergewalt gegen Frauen.“
Deshalb werden Männer, die Frauen kaufen, in Schweden bestraft. Als Schweden die Freierbestrafung 1999 einführte – als Teil des Programms „Kvinnofrid“ (Frauenfrieden) zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen – bestand die Strafe noch in einer einkommensabhängigen Geldbuße. „Doch dann gab es immer mehr Beschwerden aus der Bevölkerung, dass die Frauenkäufer zu billig davon kommen“, berichtet Simon Häggström. Seit Sommer 2022 steht auf Frauenkauf immer ein Monat Haft mit einer zweijährigen Bewährung. Außerdem steht die Tat zehn Jahre lang im Vorstrafenregister. „Und damit ist es in Schweden schwierig, einen Job zu finden. Denn Frauenkauf ist eins der beschämendsten Verbrechen, das wir haben.“
Das schwedische Sexkaufverbot habe einen „großen normativen Effekt gehabt. Es hat das Mindset verändert“, erklärt der Kommissar. Nur noch jeder zehnte bis 14. Mann (je nach Umfrage) ist in Schweden Freier. In Deutschland ist es jeder vierte.
Aber auch hierzulande hat sich eine Menge getan. Nicht zuletzt dank der Aufklärungsarbeit von EMMA und vieler Initiativen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Sie alle klären über die dramatischen Folgen der fatalen rot-grünen Prostitutionsreform von 2001 auf. Die machte Deutschland zum Paradies für Bordellbetreiber, Zuhälter und Menschenhändler. Während die Profiteure der Prostitution in Deutschland jubelten und sich die Taschen füllten, führte nach Schweden ein Land nach dem anderen die Freierbestrafung ein, bei gleichzeitiger Entkriminalisierung der Prostituierten. Das sogenannte „Nordische Modell“ gilt heute in fast ganz Westeuropa bishin nach Israel und Kanada. Bald auch in Deutschland?
Endlich hat sich die CDU/CSU die Einführung des „Nordischen Modells“ ins Parteiprogramm geschrieben. Wir dürfen gespannt sein, was die Koalitionsverhandlungen mit der SPD ergeben. Doch auch bei den Sozialdemokraten mehren sich die Stimmen für die Freierbestrafung. Sogar Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz hatte erklärt, er finde es „nicht akzeptabel, dass Männer Frauen kaufen“.
„Was raten Sie deutschen Politikern?“ wird Kommissar Häggström am Ende des Abends gefragt. „Schauen Sie, woher Sie Ihre Fakten bekommen“, antwortet der. „Natürlich kursieren viele Lügen über das Nordische Modell, denn es ist eine große Bedrohung für alle Profiteure der Prostitution. All die Rotlichtbezirke in Deutschland müssten schließen.“ Und er spricht eine Einladung an die SkeptikerInnen in der Politik aus: „Kommen Sie nach Schweden und schauen Sie sich vor Ort an, wie das Nordische Modell funktioniert!“ Es wäre zu wünschen, dass diejenigen, die immer noch zweifeln, der Einladung des Kommissars folgen.
(www.emma.de, der 25 März 2025)
www.emma.de/artikel/prostitution-nordisches-model-simon-haeggstroem-kommen-sie-nach-schweden-341655
da il manifesto
Si dice che la storia sia “maestra di vita”, ma è lecito dubitarne: le cose più orrende, a partire dalla guerra, si ripetono suscitando passioni simili a quelle – nazionalismi, imperialismi, razzismi, sogni reazionari e virili – che hanno prodotto catastrofi non troppo distanti nel tempo. Sono ancora tra noi persone che le hanno vissute.
Ma di fronte al pessimo spettacolo a cui assistiamo (intorno ai Trump, Musk, Putin, Netanyahu, Erdoğan ecc. ma anche ai vertici della cara Europa e della carissima Italia) la ricerca nella storia di qualcosa che ci illumini e ci consoli si riaffaccia.
Rileggiamo con attenzione, quindi, il Manifesto di Ventotene, contestualizzandolo, come consiglia Letizia Paolozzi su DeA. E magari chiediamoci perché uomini che non erano bolscevichi stalinisti (senza dimenticare che Stalin in quel momento era alleato di Churchill e Roosevelt contro Hitler) parlano esplicitamente di classe operaia, socialismo, e di alleanza con i comunisti, in vista del loro ideale federale e democratico.
Forse perché una politica capace di combattere le tendenze liberticide, i cattivi sentimenti, la produzione di disuguaglianze tipiche del capitalismo era già allora immaginata da veri democratici?
Venerdì scorso ho partecipato a Genova a un ricordo di Aldo Tortorella (organizzato dalla Fondazione Diesse con, tra altri, Gianni Cuperlo, Valentina Ghio, Ubaldo Benvenuti, Mario Paternostro) e ho citato un suo articolo su Via Dogana, rivista della Libreria delle donne di Milano. Un numero sul «comunismo di cui non possiamo fare a meno», gennaio/febbraio 1993. Era passato poco più di un anno dalla dissoluzione dell’Urss. Lia Cigarini e Franca Chiaromonte aprivano con un articolo (“Il comunismo a portata di mano”) che proponeva questo: finito il comunismo-Stato e entrato in crisi il comunismo-partito, realtà estranee al femminismo della differenza, «inizia una ricerca che coinvolge, in prima persona, quelle di noi che pensano la differenza femminile come irriducibile al sistema del profitto e del mercato, oppure quelle che sono “sentitamente” (cioè lo sentono) legate alle vicende del mondo operaio». Ricerca che parte «nell’unico modo possibile per noi: da quello che abbiamo a portata di mano, cioè dalla possibilità di modificare il nostro rapporto con la realtà». E insieme a uomini «che hanno dato segno di riconoscere autorità femminile nel mondo».
Il contributo di Aldo (“L’esempio di Eva”) pone domande radicali: capire perché «l’idea comunista, nata come tendenza alla liberazione umana, abbia originato – o non abbia efficacemente contrastato – la politica liberticida dello stalinismo». E indica una risposta molto impegnativa: «La pratica del movimento operaio non ha prodotto alcuna significativa nuova scoperta teorica della realtà e delle medesime modificazioni che esso stesso determinava, e perciò si è ristretta a una dottrina del potere e a una pratica del potere». Eppure non vuole abbandonare la “parola maledetta”, considerandola da sempre non una cosa, ma «l’idea-limite di una società libera e liberata dagli impacci posti dalla non conoscenza, dal non sapere, come l’altro terminale (teorico, s’intende) del cammino voluto da Eva con il rifiuto della inconsapevolezza, con il rifiuto della naturalità, con la conquista della conoscenza (e, naturalmente, dei suoi tormenti)».
Seguono ragionamenti sugli inganni della “naturalità” del capitalismo e sulla possibilità di elaborarne una “nuova critica”. Sono passati più di trent’anni e anche qui dobbiamo contestualizzare.
Ma credo valga la pena di ripensarci.
(il manifesto – In una parola – rubrica settimanale a cura di Alberto Leiss, 25 marzo 2025)
dal Corriere della Sera
«Dare ai figli solo il cognome della madre». E poi: «È una cosa semplice ed anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere». Al Senato, ieri, si stava svolgendo quella che doveva essere un’assemblea di routine del gruppo del Pd. Ma a un certo punto l’ex ministro della Cultura Dario Franceschini ha sparigliato, spiegando ai colleghi senatori la volontà di presentare «un disegno di legge» per sancire una svolta «dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre». Gli eletti del Partito democratico stavano discutendo delle proposte di legge sul doppio cognome, quando l’ex ministro (e peso massimo dei dem) ha preso in contropiede molti dei presenti, tanto che, quando a ruota è partito il fuoco di fila dal centrodestra, non c’è stata una risposta altrettanto forte dal Pd. C’è però, dall’ala sinistra dem, Laura Boldrini che applaude: «Ne parleremo e troveremo la strada migliore da seguire. Ma quello che è sicuro è che questo tema non si può più rimandare».
Il commento più duro, da destra, è quello di Matteo Salvini: «Ecco le grandi priorità della sinistra italiana: – attacca via social il leader della Lega – invece del doppio cognome, togliere ai bimbi il cognome del padre! Ma certo, cancelliamoli dalla faccia della terra questi papà, così risolviamo tutti i problemi… Ma dove le pensano ’ste idee geniali?». Gli ribatte Annalisa Corrado: «Per Salvini, dare ai figli il cognome della madre significa cancellare i padri dalla faccia della terra – scrive l’eurodeputata del Pd. – Ammette quindi che, per secoli, le donne sono state sistematicamente rimosse dalla storia e dalla memoria formale delle proprie famiglie. Ammette, dunque, la grande ingiustizia che hanno subito». Sarcastica la reazione di Galeazzo Bignami: «Quindi invece che il cognome del padre, gli diamo il cognome del nonno», scrive il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.
Critiche alla proposta del senatore del Pd, un po’ a sorpresa, arrivano anche dagli ipotetici alleati: «Io ho fatto un salto sulla sedia quando ho visto la proposta di Franceschini – afferma Alessandra Maiorino, vicepresidente del M5S a Palazzo Madama–. Evidentemente al buon Dario sfugge quanto sia stato difficile già lavorare alla giustapposizione dei cognomi di entrambi i genitori». E poi: «Quindi interpreto la sua proposta come una provocazione, una boutade… Anche perché non si risponde a una discriminazione, sia pur millenaria, con un’altra discriminazione». Anche Carlo Calenda è piuttosto perplesso: «Altre priorità non ne abbiamo? Boh». Dal punto di vista prettamente legislativo, c’è infine l’opinione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, che non ha dubbi: «Il ddl Franceschini sarà criticabile ed impugnabile per illegittimità costituzionale: introduce una diseguaglianza».
da Erbacce
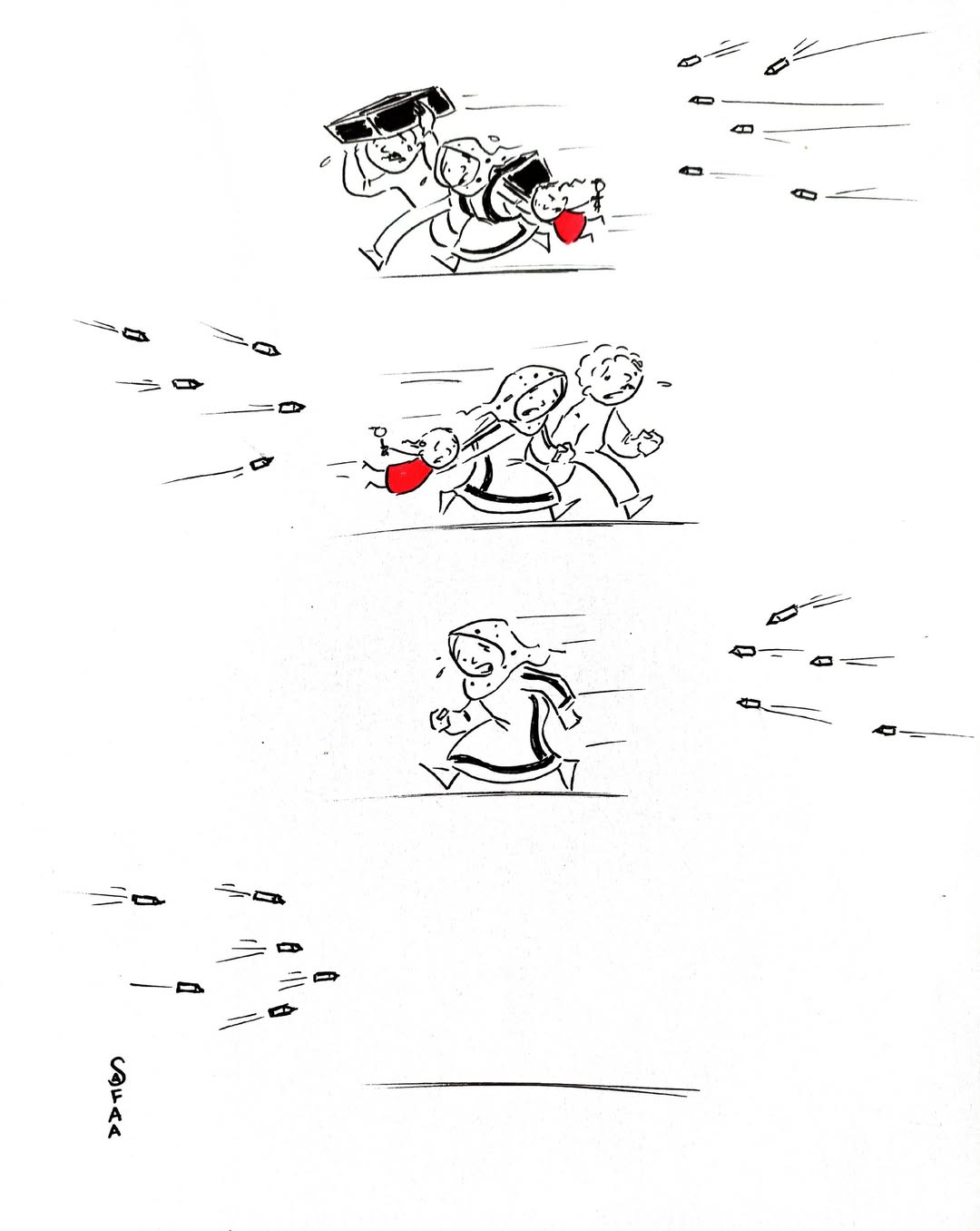
La città dove mi trovo, Rafah, è ora sottoposta a pesanti bombardamenti, gli abitanti rimasti sono stati sfollati e non sappiamo quale sarà il nostro destino. Paura e ansia stanno prendendo il sopravvento.
Quando finirà questo incubo?
Vi informo, sto avendo un problema con internet e sta diventando difficile accedervi.
Le vostre preghiere.
da Exibart
Prima io la guerra non sapevo proprio cosa fosse. Ho visto tutti i film e letto tutti i libri che ti consigliano, ma non sapevo nulla. Ci ha provato anche il mio nonno a raccontarmi dell’Italia, del fascismo e delle montagne emiliane che custodiscono il coraggio di chi non si voleva arrendere, ma le sue parole sapevano di storie lontane, da “c’era una volta”, come quelle che ti raccontano quando sei piccolo e fortunato appena prima di addormentarti. Questa volta invece la guerra è vicina e io sono andata a visitarla. Cosa significa andare a visitare un paese in guerra quando il tuo ha il privilegio di essere in pace ancora non lo so, di sicuro la prospettiva te la cambia. Prima banalità: la guerra è uno strumento per vedere le cose in modo diverso, vorrei essere originale, ma a volte la verità è banale. Ho scritto qui di seguito un diario di viaggio delle lezioni super-banali e mai-scontate che la guerra mi ha insegnato in una settimana.
Kyiv, giorno 1 – Il primo allarme drone non si scorda mai
O meglio notte 1, sono le 23.30 e sono molto stanca. Per raggiungere Kyiv da Milano ho preso un treno alle 6.00 del mattino, poi un aereo per arrivare a Varsavia in Polonia e dopo circa sei ore di attesa ho preso il pullman. Quello che sembrava essere l’ultimo step del viaggio in realtà inaugura la mia epopea. Sedici ore di pullman dopo, quattro di controllo alla frontiera e un panino con lisiecka arrivo a Kyiv, capitale dell’Ucraina, paese in guerra contro la Russia dal 2014 e che dal febbraio 2022 si difende dall’invasione su larga scala. Alla fermata del pullman mi aspetta un giovane biondo ucraino, Andrys Lutsiv, vestito con colori camouflage. Seconda banalità, ma la verità è banale. Andrys ha le braccia piene di tatuaggi e le scritte in latino Veni Vidi Vici io le riconosco subito, mi sorride e mi porge un bellissimo mazzo di fiori rosa: «Benvenuta in Ucraina». È tardi, mi faccio la doccia più desiderata di sempre e corro sotto le coperte. Tutti mi hanno sempre detto che ho il sonno pesante, «non ti svegliano neanche le bombe» mi dicevano e invece eccome se mi svegliano. All’improvviso, durante la notte, il mio cellulare squilla all’impazzata con un volume così alto che neanche lo sapevo potesse arrivare a questi decibel. «Allarme-allarme» ripete l’app del governo e qualche secondo dopo si aggiunge anche l’allarme dell’albergo «Pericolo: attacco droni. Correre immediatamente nel rifugio». Mi sveglio di soprassalto, mi ricordo dove sono e capisco quello che sta per succedere. Con una velocità da gazzella mi infilo le scarpe, prendo una felpa e faccio otto rampe di scale volando e corro al rifugio sotterraneo. Io non lo so dove ho imparato a reagire così alle situazioni di pericolo, sinceramente prima di venire qui pensavo di essere una schiappa, una di quelle persone che si paralizza e diventa un cubetto di ghiaccio. Evidentemente no, beh meglio così, penso. Il rifugio è quasi vuoto e ancora il perché non lo capisco, lo scoprirò solo tra qualche giorno. Le ore nel rifugio mentre c’è un pericolo di attacco drone in corso sono noiosissime. Niente a che vedere con i film, dove è tutta un’azione, adrenalina e elaborazione di piani per la fase successiva. Il telefono nel bunker non prende, quindi non puoi neanche collegarti alle news in tempo reale e fare finta che si rivolgano a te. Il libro nel mio scatto da gazzella me lo sono dimenticata e allora prendo una copertina sintetica gentilmente offerta dall’albergo, bevo un tè e mi metto a sonnecchiare sulla sedia. Dopo qualche ora l’allarme passa, possiamo tornare in camera. Che bello finalmente il letto!
Kyiv, giorno 2 – Quando le città vanno a dormire
È tardo pomeriggio e raggiungo lo studio dell’artista ucraino Nikita Kadan. Insieme a me ci sono gli altri compagni che sono venturi a fare visita alla guerra: due artisti (Stefan Klein e Nicola Zucchi), una giornalista esperta di zone ad alto rischio (Marie-Line Deleye), un curatore/artista che studia la danza come strumento di esorcizzazione del trauma in situazioni di conflitto (Bogomir Doringer) e un operatore e educatore culturale di Magnum Photo Agency (Pierre Mohamed-Petit). Insieme a Nikita ci sono altri artisti ucraini, il pittore Yuriy Bolsa, la curatrice Alona Karavai, le artiste Sana Shahmuradova Tanska e Olga Stein. Trascorriamo la serata sul terrazzo del suo studio all’ultimo piano di un elegante palazzo di Kyiv. Se gli artisti hanno studi enormi in palazzine borghesi della capitale significa che il mercato immobiliare è proprio crollato. Mangiamo pizze dal cartone e beviamo champagne. Parliamo di tutto e poi di niente. Di fronte a noi fa capolino la luna, piena come non lo è mai stata. Nel cercare le sigarette faccio un fermo immagine: artisti, una luna piena e discorsi sulla resistenza. La sera di un martedì e una dose di verità dritta in vena. In Ucraina la notte è stata rapita tre anni fa, da quando c’è la legge marziale e il coprifuoco obbligatorio per tutti. Sono le 23 ed è ora di rientrare in albergo. Rientro a piedi e Google Maps mi accompagna a casa passando a fianco a un parco. È notte e buio, eppure io non me lo ricordavo che fosse così buio di notte. Mi guardo attorno e non c’è neanche un lampione acceso, neanche un’insegna luminosa per chilometri. O almeno così penso, sono miope quindi le distanze le calcolo un po’ a spanne. Mi sembra veramente tanto buio, ho paura e inizio a guardarmi attorno. Se sei una donna cresciuta in Italia sai benissimo che dei parchi di notte devi avere paura, che qualcuno arriva, ti assalta, nessuno ti sente e poi ti tocca convivere tutta la vita con il trauma e combattere contro la magistratura che non ti crederà. Poi però mi viene in mente che uno dei compagni che visita la guerra insieme a me aveva già notato il buio e qualcuno gli aveva detto che è una precauzione militare, che anche le città devono andare a dormire non solo gli abitanti, perché se le luci sono accese e i lampioni raggianti, i russi lo vedono meglio dove colpire. Buio per camuffarsi e coprifuoco per tutti. Allora il drone fa più paura di un parco di notte.
Kharkiv, giorno 3 – Il negozio di pennelli con la porta spalancata
Quando penso a Kharkiv la mia mente fa un gioco strano, è come se il cricetino che regola i miei pensieri iniziasse a correre fortissimo e la mia memoria diventa in modalità x4-x6-x8, come quando clicchi il telecomando per velocizzare un film. Immagini di case bombardate, militari mutilati, futuri mancati scorrono velocissimi e poi appaiono immagini del parco rigoglioso della città, Viktor che chiede a Marija di sposarlo in stazione con un mazzo di rose rosse e la panetteria di quartiere. Quel giorno è a frammenti, come tanti pezzi di vetro rotto, non riesco ancora a ricostruire cosa fosse prima di schiantarsi a terra. Forse ci vuole tempo anche per ricordare meglio. O forse il tempo lenisce il ricordo e a un certo punto te ne freghi dei frammenti di vetro pungenti che ti tagliano i ricordi.
Eppure quando penso a Nataliia tutto rallenta. Nataliia Ivanova è la curatrice del centro Yermilov aperto dal 2012 come museo, prima come strip club. Da sempre in un rifugio antibomba, prima una scelta cool per uno spazio di arte contemporanea, ora una scelta salvavita. La direttrice ha curato la recente mostra Sense of Safety e nell’installazione di Thomas Hirschhorn insieme ai compagni che visitano la guerra abbiamo fatto una discussione, una tavola rotonda dove ci siamo chiesti se l’arte può avere un potere curativo, di healing. Mi siedo sulla sedia-opera d’arte del Yermilov Center e mi chiedo cosa ne so io del potere curativo dell’arte, ché prima di venire qui quando parlavo dei musei come spazi sicuri pensavo alla sicurezza del pensiero critico e il libero dibattito, robe teoriche mica spazio sicuro “se no ti esplode la testa”. A Kharkiv ho imparato che più sei vicino alla guerra, più la vita si impone rigogliosa. Siccome di immagini di dolore e di morte è pieno il mondo e anche il web e tanto frega poco a quasi tutti, io vi racconto della gioia e della felicità che ho trovato a Kharkiv. All’angolo con uno dei tanti monumenti impacchettati, non da Christo e Jeanne-Claude ma dallo stato perché alle bombe delle firme degli artisti d’arte pubblica non interessa nulla, c’è un duo rock and roll che canta al bordo della strada e da lì sono vicinissimo alla panetteria per provare «i dolcetti alla cannella più buoni del mondo». Sono seduta fuori dalla panetteria con i miei compagni che visitano la guerra e da quando siamo in compagnia di chi invece con la guerra ci abita, abbiamo tutti abbassato la suoneria del cellulare perché gli allarmi sono tantissimi e non smettono mai e non ti fanno neanche finire una conversazione in pace. Allora meglio abbassare la suoneria e godersi ogni momento, ché quando la vita ti obbliga a scegliere preferisco morire con un biscotto alla cannella in bocca e la luce del sole addosso invece che come uno scarafaggio sottoterra.
Ora di cena, ora di provare la famosissima zuppa boršč di Kharkiv. Per raggiungere il ristorante passiamo in una strada bombardata, dove i palazzi le cicatrici le hanno ancora sanguinanti, ma siccome per le tragedie ci sono i giornalisti e io sono una curatrice vi racconto del negozio di pennelli. Nella tragedia urbana, il frastuono degli allarmi e le cicatrici dei palazzi, il negozietto a conduzione famigliare di tempere e pennelli è aperto. Non vende né acqua, né cibo, né altri beni di prima necessità, solo strumenti per fare arte. Lo so che sembra assurdo ma quando non hai più nulla da perdere, l’arte torna a essere essenziale. Poter disegnare è un modo per sopportare, buttare fuori quello che altrimenti ti mangia dentro. Qualcuno dice che così ti traumatizzi da solo, non lo so forse ha ragione, ma a volte non hai scelta e da qualche parte come ti senti lo devi vomitare. La porta del negozio è letteralmente spalancata, come a voler urlare che le bombe fanno paura, ma da lì non ci si muove, qui si resiste perché se qualcuno oggi avesse bisogno di dipingere, il negozietto di pennelli sul confine con la guerra è aperto.
Kyiv, giorno 4 – Parla come mangi
Da oggi cambio il linguaggio con cui mi esprimo. Non sono più “stanca morta” e non ti “bombarderò” più di mail. Esistono luoghi nel mondo dove queste parole non sono metafore e allora vale la pena fare uno sforzo e pensare a immagini nuove per veicolare idee diverse da questo schifo.
Kyiv, giorno 5 – Pensieri di cui mi vergogno
Stare in una zona di guerra mi è piaciuto. Lo so suona pazzesco e forse perché un po’ pazza lo sono davvero, ma se scrivo è perché ho deciso di essere sincera altrimenti cosa lo perdo io il tempo a scrivere e voi a leggere. Credo che la guerra mi sia piaciuta perché mi ha fatto sentire “la vertigine della storia”. Quando sei in una zona di guerra, non sei più in un paese a caso, a fare cose a caso, con persone che a caso ti trovi vicino, o meglio forse sei comunque tutte queste cose, ma ti senti che un senso ce lo hai. La sensazione è quella di essere nel centro degli eventi, di stare nel nucleo delle cose, di essere parte di qualcosa di più grande e anche la tua piccola azione a caso in realtà ti sembra possa plasmare il corso degli eventi e il futuro delle generazioni che verranno: vertigine della storia. Un artista ucraino durante un allarme drone e una bottiglia di vino rosso affacciati in un cortile di Kyiv mi ha rivelato un altro pensiero di cui si vergogna. Mi dice che vivere in Ucraina è sempre stato piuttosto noioso, che era tutto banale e piatto e che ora in qualche modo è felice perché anche se si muore la sensazione è quella di fare la storia.
La guerra è una dose di verità in vena. Crudele che ti mangia l’anima e che ti ama fortissimo, non lo so come è possibile ma più sei vicino al dolore e più risuona l’amore. È tutto così fragile e temporaneo che i momenti si vivono con il cuore e l’anima aperta verso tutto e tutti. Le anime spalancate come la porta del negozio di pennelli di Kharkiv. Allora chissenefrega se perdo la metro e alla mail magari ti rispondo domani, ora brindo alle dieci del mattino al primo studio-visit della giornata perché anche oggi sono viva io, sei vivo tu e lo studio esiste ancora con le opere che custodisce. Come una droga, la guerra ti entra in vena e dopo che ha iniziato a circolare nel corpo e l’adrenalina pulsa insieme al sangue, allora i pensieri si armonizzano su livelli di amore e di dolore così intensi che quando torni tutto è lento, stupido e inutile. O almeno questa è la sensazione di chi la guerra è andata a visitarla, per chi la abita sono sicura che sarà molto diverso.
Giorno 6 – Studio-visit in guerra
Sono venuta in Ucraina per conoscere la scena artistica locale, fare studio-visit, incontrare gli artisti, i colleghi e le colleghe e immaginare progetti culturali internazionali. Networking, solo in una versione più pericolosa del solito. Non me lo aveva detto mica nessuno che la Sofia che è partita una settimana fa ora non esiste più, che quando vedi la guerra per la prima volta è come se perdessi la verginità e poi ti tocca renderti conto di chi sei e di quale spazio occupi nel mondo. Dopo che vedi la guerra adulto lo diventi per forza, anche se hai otto anni e giochi a palla. Siccome io a palla ho avuto la fortuna di giocarci per tanti anni e di non dover pensare ad altro che correre, ora bisogna che anche io protegga la partita a palla di qualcun altro. Quindi networking, quindi curatrice, quindi fare progetti internazionali con artisti ucraini. Io non lo so se gli artisti ucraini fossero già bravi prima della guerra, forse sì ma io qui prima non c’ero mai stata, quello che posso dire è che – loro malgrado – tra un’esplosione e l’altra, la guerra li ha resi dei maestri. Non ci sono più ricerche che si possono permettere di viaggiare in superficie, di galleggiare fra una tematica e l’altra e di sfiorare i materiali. Fuori dalla finestra dello studio c’è la guerra, la gente muore e i bambini salutano i papà alla stazione del bus per andare al fronte. Come un incantesimo inquietante, tutte queste energie rientrano dalla finestra dello studio e si impossessano della mano dell’artista per produrre opere straordinarie. Uso il termine impossessarsi perché la guerra non è una tematica che gli artisti affrontano, è a tutti gli effetti la co-autrice delle opere. Quando fai gli studio-visit e gli artisti ti mostrano i lavori e inizi a confrontarti, poi devi chiacchierare anche con la guerra che anche lei ha le sue cose da raccontarti. Ho riscontrato che questa co-autorialità fra artista e guerra ha nella produzione artistica la conseguenza di essere un crudele inno alla vita. Sembra paradossale ma è così.
Qui le tensioni ricorrenti fra gli artisti ucraini che abitano la guerra:
1. Sono ossessionati dalla memoria. C’è una generale postura compulsiva alle date e al ricordo preciso. Dimenticare è un peccato perché quando sei morto il mondo si scorda di te.
2. Presenza dei sogni e dell’onirico. Non importa se dipingono nel Medioevo, nel Novecento, a metà anni 2000: se la realtà fa schifo, allora ne inventano di altre.
3. Infanzia. Se la guerra è il fallimento totale degli adulti, allora gli artisti tornano ai bambini, all’infanzia, a chi puro e innocente lo è per forza. Morte e vita si rincorrono sempre.
4. Disegnano tantissimo, forse perché un foglio e qualche pastello te li porti appresso facilmente, anche se devi correre veloce.
5. Molti di loro sono ossessionati dal sottosuolo e dalla terra. Io che la guerra sono andata solo a visitarla ero ossessionata dal cielo, che per me era tramonto e alba con gli amici, mentre qui avevo paura del cielo perché è da lì che vengono i missili.
6. Tanti lavorano con il sonoro, perché la guerra oltre che negli occhi, ti entra nelle orecchie.
7. Mediamente sanno come costruire un drone. Se non lo sai fare te lo insegnano, anche a un techno-party il venerdì sera, perché se i droni li sai fare magari in prima linea ci va qualcun altro.
Kyiv, giorno 7 – Le paure degli uomini
Sul pullman di ritorno siamo tutte donne, alcune anziane altre meno, molte mamme e tanti bambini. Gli unici pullman su cui possono salire gli uomini sono quelli verso la guerra. Sì, perché in Ucraina c’è la legge marziale, nessun uomo lascia lo stato e tutti (almeno fino ai sessantacinque anni di età) possono essere mobilitati. Essere mobilitati, mi spiegano, significa che ti arriva una lettera a casa e in tre mesi se ti va bene o in uno di norma ti insegnano a fare la guerra. Ora che sono ormai dieci anni dall’inizio della guerra e due dall’invasione di larga scala gli uomini servono sempre di più, un po’ perché i militari sono stanchi, un po’ perché altri sono stanchi e morti. Allora la polizia ogni tanto decide di mobilitare la gente per strada. Tu stai camminando per la capitale e la polizia ti ferma e ti manda a fare la guerra, magari volevi solo bere un caffè o leggere il giornale all’aria aperta perché è domenica, ma ora devi fare la guerra. Qui gli uomini sembrano tutti grandi, forti e palestrati eppure io non ci credo che non hanno paura. Forse se sei grande, grosso e palestrato impari a nasconderla bene e le pressioni della società ti obbligano a chiuderla in un cassetto e buttare via la chiave. Certe emozioni non puoi proprio permetterti di provarle, perché devi salvare la famiglia, la madre e la patria. E se hai paura poi ti ricordi che i codardi non piacciono a nessuno e che non esiste neanche un monumento ai vigliacchi, allora deglutisci ti fai un tatuaggio sul braccio e appendi la bandiera della nazione. Forse mi sbaglio, io d’altronde un paese in guerra sono venuta solo a visitarlo e ci sono venuta da donna.
(Exibart, 23 marzo 2025. L’articolo è stato tradotto dall’inglese da Sam Vassallo. La sua versione originale è stata pubblicata su NERO. Fotografie su: https://www.exibart.com/attualita/una-settimana-per-imparare-la-guerra-viaggio-di-una-curatrice-in-ucraina/)
da il manifesto
Nell’ancoraggio a sé Carla Lonzi trova il punto di partenza per affrancarsi dagli assunti oppressivi della metafisica patriarcale, e della psicoanalisi, rivale ombra della filosofia: “Taci, anzi parla”, 1972-1977
A due anni dal “Manifesto di Rivolta Femminile” (1970) e dai primi esplosivi scritti femministi, l’anima radicale di Carla Lonzi avverte la necessità di avanzare in prima persona. Incompleto sul piano delle domande, teso nelle relazioni fra donne, il passaggio storico di Rivolta l’aveva mantenuta “in incognito”, intenta a schivare o mimetizzare l’espressione diretta di sé: «rischiavo di continuare a cogliere in me stessa dati di coscienza generali per il femminismo, piuttosto che ricostruire i momenti che li avevano prodotti». Senza conoscere il movente di quei dati, i capisaldi di Rivolta le parevano un lessico di intuizioni senza collegamento con possibilità reali della sua vita. Restava sospesa nelle generalità anche «l’illuminazione improvvisa» che le aveva rivelato quel suo rifugio incognito e misconosciuto come «il nuovo campo di soggettività della donna».
Le proclamazioni teoriche di “Sputiamo su Hegel” (1970) e di “La donna clitoridea e la donna vaginale” (1971), dopo aver fornito il propellente ai gruppi separatisti di autocoscienza e all’avanzata del femminismo di seconda ondata, andavano esposte alla prova di fuoco dell’esperienza personale.
L’opera che ne esce è un diario, la diuturna scrittura in prima persona congeniale alle donne tacitate. Comparso nei libretti verdi di Rivolta nel 1978, “Taci, anzi parla – Diario di una femminista 1972-1977” viene ora riedito a cura di Annarosa Buttarelli come tappa imprescindibile dell’opera omnia, in corso di pubblicazione per La Tartaruga (ora nel catalogo di La Nave di Teseo, pp.1082, € 25,00).
«Questo lavoro mi ha assorbito anni, giorno dopo giorno», «mi teneva in uno stato di concentrazione fortissima», «immersa in un’impresa al limite delle mie forze». Preso congedo da ogni programma di emancipazione e dalle promesse dell’oggettività – trappole tutte del patriarcato – il diario di Lonzi attraversa la densità dell’esistenza tenendosi alla sola fune dell’autenticità e di una caparbia fedeltà a sé: «Mi sono incamminata senza seguire nessuno».
Una struttura ardita articola i resoconti quotidiani con sogni, lettere non spedite, citazioni, vecchi scritti, poesie – registrazioni sensibilissime tanto dei moti di coscienza quanto delle vibrazioni sotterranee dell’incoscienza.
Tutte le scritture sono riportate alla dimensione generativa del presente e qui si riattivano e si connettono fino a rendere leggibile il profilo di una vita intera. Nessuna identità personale vi compare come già data e neppure è conquistata una volta per tutte – «Mi sento come una pupilla al variare della luce, sono un continuo dilatarmi e restringermi»; al lavoro sono piuttosto le relazioni – oppressive o liberatorie, sempre condizionanti e cariche di illusioni – col padre e la madre, con l’uomo e le amiche.
Una lunga introspezione, condotta «all’apprendistato di ciò che vivevo» e affidata a lettere, diari di adolescenza, poesie, era rimasta chiusa nel baluardo della cittadella interiore fino alla prova di fiducia ricevuta da Ester (Carla Accardi), che aveva sgretolato la prima cerchia di difesa facendo prorompere il femminismo e i gruppi di autocoscienza.
Quasi epilogo e traguardo della fase di Rivolta, è il riconoscimento imprevisto di Sara – l’atto circolare per cui si diventa soggetti «reciprocamente, cioè di fatto e non solo nelle intenzioni» – che consente a Lonzi, ancora inceppata nell’autodifesa, di proiettarsi in una vita nuova «con tutta la freschezza di persona inespressa».
Risalire la corrente della messa in secondo piano – quella che lei chiama inferiorizzazione – richiede in realtà costosissimi sforzi di coerenza sul piano delle relazioni e gesti radicali di svuotamento dalle acquisizioni culturali interiorizzate. In primis dalla dialettica, che era stata il lasciapassare di Lonzi per entrare nel mondo della cultura e reggere il confronto con il «momento più alto raggiunto dall’uomo». Dopo la sicura confutazione di “Sputiamo su Hegel”, è ora la volta di «sputare questo Hegel che ho dentro di me».
Sparite come “assoluti” e sganciate da ogni meccanismo necessario, arti, religioni e filosofie compaiono nel diario come estrazioni impreviste dalla fucina del singolare presente, «atti vitali per superare la solitudine, il dubbio, la disperazione». Il braccio della filosofia in particolare cessa di essere armato di teorie per caricarsi di tonalità personali: «Adesso ogni filosofo che incontro mi sembra di ritrovarlo dentro di me». Leggendo Bergson: «vi ho trovato quello che sto facendo, cioè registrare tutti i mutamenti della coscienza, che sono infiniti»; quanto a Spinoza: «L’ho letto d’un fiato: come tutto è chiaro, comprensibile, quante riflessioni in comune», «è proprio uno che parla di sé, ha la certezza dall’avere trovato in sé. Certo, questo è il filosofo, cosa pensavo che fosse?».
Una a cui scappa da ridere
In questo ancoraggio a se stessi senza altre garanzie Lonzi trova il punto di partenza per la liberazione dagli assunti oppressivi non solo della metafisica patriarcale, ma anche della concezione psicanalitica, che crede a una normalità senza autocoscienza.
Anche la psicoanalisi – rivale ombra della filosofia e della filosofa Carla Lonzi – viene infatti superata d’un balzo assieme all’intero costrutto dei sensi di colpa: «Inconscio, tu e io andiamo alle Bahamas. Non mi metterai più bastoni tra le ruote, adesso ti colgo sul fatto, te e i tuoi simboli»; e, ancora, «Se ti affacci, in qualsiasi enigma tu sia travestito, mi butto su di te. Ti spoglio in quattro e quattr’otto».
Nella pulsazione tra discese fino alla perdita del senso di sé e risalite spensierate verso la leggerezza del proprio essere – «sono una a cui scappa da ridere» – affiora nell’animo di Lonzi una mancanza di unità mai saturata, anzi quasi salvaguardata come premessa autentica del sé.
Nessuna conciliazione armonica risolve le fratture della coscienza, che sono tenute insieme solo dal filo ininterrotto della scrittura.
Fra sdegno e dolore
Nelle poesie giovanili come nel procedere concentrato dei primi scritti femministi, Lonzi trova il grande piacere della corrispondenza a sé: «ci vedevo il riserbo, la lucidità, il tremito impercettibile che ha il mio modo di ragionare tra lo sdegno contenuto e la sofferenza risolta ma non dimenticata e il giro del pensiero che sdrammatizza il contenuto e raffredda l’urgenza espressiva».
Scrivere si rivela strumento necessario proprio nella sua funzione originaria di fermare i pensieri, precisarli e renderli comunicabili, immetterli nella relazione. Una modalità a un tempo espressiva e architettonica, che non richiede vocazioni e talenti eccezionali, né ambisce a inserirsi nelle forme della cultura maschile, ma è alla portata di tutte e di ciascuno, sulla via di una società «basata sui rapporti umani».
Proprio in virtù di una scrittura priva di movenze letterarie, che pare aderire direttamente ai moti del pensiero, pagina dopo pagina il diario trova l’eloquenza splendente di una lingua senza eguali e può apparire con la sua “montagna di parole” il romanzo avventuroso di una vita esaminata.