Il 12 gennaio, a poco più di un mese dal decimo anniversario dell’omicidio della dirigente indigena e attivista popolare Berta Cáceres, il Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (GIEI) ha presentato un rapporto con i risultati di una lunga e complessa indagine, che aveva l’obiettivo di far luce sui responsabili della pianificazione, finanziamento ed esecuzione del crimine.
Nel novembre 2024, la Sala Penale della Corte suprema di giustizia dell’Honduras ha deciso di confermare le sentenze emesse contro i sette esecutori materiali [1], con pene comprese tra i trenta e i cinquant’anni di reclusione. Per David Castillo, coautore dell’omicidio, ex presidente della società Desarrollos Energéticos SA (Desa) ed ex membro dei servizi segreti delle forze armate honduregne, la Sala ha deciso di modificare le circostanze aggravanti e di ridurre la pena di 22 anni e 6 mesi inflitta in primo grado. Inoltre, a Castillo sono stati aggiunti altri cinque anni per frode relativa al progetto idroelettrico Agua Zarca.
Nonostante questo primo importante passo avanti, il Consiglio civico delle organizzazioni popolari e indigene dell’Honduras (Copinh), la famiglia dell’attivista popolare e il team di parte civile continuano a chiedere cattura e punizione per i mandanti dell’omicidio. Finora, è stato emesso un solo mandato di arresto nei confronti di Daniel Atala Midence, ex direttore finanziario di Desa e ancora latitante.
Si crea il GIEI
Il GIEI si è insediato in Honduras il 14 febbraio 2025, a seguito di un accordo tra la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), lo Stato dell’Honduras, il Copinh e il Centro per la giustizia e il diritto internazionale (Cejil). Tra le prime rivelazioni del rapporto del gruppo di esperti figura la “non occasionalità” dell’omicidio della Cáceres. «L’irruzione armata che ha posto fine alla vita di Berta Cáceres non è stato un fatto fortuito, né un atto di violenza comune. È stato il culmine di un lungo processo di persecuzione, sorveglianza, criminalizzazione e violenza esercitato contro la leader indigena, che per anni ha guidato la difesa del territorio [della popolazione] Lenca contro l’imposizione del progetto idroelettrico Agua Zarca, in un contesto caratterizzato dalla concentrazione del potere economico e da istituzioni cooptate da interessi privati», sottolinea il GIEI. I tre esperti internazionali [2] hanno poi continuato chiarendo che l’omicidio di Berta Cáceres era prevedibile e prevenibile: «Le autorità non hanno attivato meccanismi di prevenzione, non hanno ampliato le intercettazioni, né hanno effettuato arresti tempestivi. Questa inazione, di fronte a una “scoperta inevitabile”, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza». Inoltre, gli esperti determinano che il crimine contro l’attivista è stato preceduto da molteplici operazioni illegali di intelligence, sorveglianza sistematica e pianificazione logistica, nonché da ostacoli deliberati alle indagini penali e omissioni strutturali sin dalle prime ore successive all’omicidio, che di fatto hanno impedito un’indagine completa.
Un omicidio d’impresa
Il crimine è stato finanziato con risorse provenienti dal progetto idroelettrico, erogate dalle banche internazionali BCIE e FMO [3] e deviate dal loro scopo originario. Su un totale di 18,5 milioni di dollari, il 67% (quasi 12,5 milioni) è stato dirottato o gestito in modo irregolare. «È stato identificato un modello sistematico di distrazione di fondi, caratterizzato da trasferimenti internazionali ingiustificati, conversione di fondi bancari in contanti, uso ricorrente di dipendenti di basso livello come incassatori di assegni e frammentazione degli importi per eludere i controlli antiriciclaggio delle istituzioni finanziarie». Questo circuito finanziario, spiega il GIEI, avrebbe permesso di pagare i sicari e di finanziare la logistica prima e dopo l’omicidio di Berta Cáceres. Per questo motivo, i tre esperti concludono che «si è trattato di un crimine aziendale, finanziario e politico, perpetrato attraverso una complessa architettura criminale che ha articolato interessi economici, finanziamenti internazionali, strutture di sicurezza, corruzione istituzionale e gravi omissioni statali, configurando un modus operandi sostenuto nel tempo». Principali responsabili del crimine sono, quindi, gli azionisti di maggioranza del progetto Agua Zarca, che ricoprono anche ruoli rilevanti nella costituzione e nel funzionamento del dispositivo societario e finanziario che, in ultima analisi, ha reso possibile l’omicidio di Berta Cáceres.
Il GIEI punta il dito contro José Eduardo, Pedro e Jacobo Atala Zablah e Daniel Atala Midence, che ricoprivano cariche dirigenziali sia in aziende legate al progetto Agua Zarca, sia in istituti bancari, e contro BCIE e FMO per avere firmato accordi di credito a favore di Desa «conoscendo la situazione di violenza già generata dal progetto» e l’inesistenza di un processo valido di consultazione libera, preventiva e informata. La ricostruzione effettuata dal GIEI ha permesso di dimostrare che l’omicidio è stato «il risultato di un’operazione criminale pianificata, eseguita da una struttura articolata tra sicari, attori con formazione militare, dirigenti della Desa e reti di sostegno statale», la cui responsabilità è stata solo parzialmente indagata dalle autorità honduregne, senza approfondire la possibile responsabilità penale dei rappresentanti del capitale azionario maggioritario (Inversiones Las Jacarandas / Jacobo Atala). In questa struttura, Desa ha svolto il compito di pagare informatori, strutture paramilitari e logistica repressiva, funzionari pubblici ed ex funzionari. Ha anche cooptato autorità ambientali, municipali e di sicurezza, ha manipolato la narrativa pubblica attraverso pagamenti a giornalisti e media, ha utilizzato audit e consulenze per legittimare un progetto irrealizzabile e illegale, assicurando la continuità dei finanziamenti internazionali.
Riparazione e giustizia integrale
La parte conclusiva del rapporto del GIEI è dedicata al Piano di riparazione e giustizia integrale per le vittime (famiglia, Copinh e comunità lenca di Río Blanco), che include la chiusura definitiva del progetto idroelettrico Agua Zarca, la titolazione definitiva del territorio ancestrale della comunità lenca di Río Blanco, la cancellazione dal registro commerciale e lo scioglimento di Desa, nonché la depurazione e l’apertura degli archivi dei servizi segreti relativi a Berta Cáceres, al Copinh e ad altri difensori dei diritti umani. Sono anche state consigliate allo Stato dell’Honduras misure concrete di riabilitazione, compensazione, soddisfazione e garanzie di non ripetizione (pag. 373 del rapporto), dove si persegue «un processo integrale, collettivo e trasformativo, indispensabile per ripristinare la dignità delle vittime, ricostruire il tessuto sociale del popolo indigeno Lenca di Río Blanco e garantire che crimini come l’omicidio di Berta Cáceres non si ripetano».
Note
[1] Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edison Duarte (autori materiali), Sergio Rodríguez (autore per induzione) e David Castillo (coautore)
[2] Roxanna Altholz, Pedro Biscay, Ricardo Guzmán
[3] Banca centroamericana di integrazione economica e Banca di sviluppo dei Paesi Bassi
(Pressenza, 20 gennaio 2026)
Da tre anni, il Ministro dell’Istruzione non consente al Forum delle Famiglie Israeliane-Palestinesi in Lutto di accedere alle scuole. Le famiglie che hanno perso i propri cari e hanno scelto, proprio a causa del lutto, di impegnarsi per il dialogo e un futuro diverso sono state definite dal Ministero dell’Istruzione un “fattore ostile” che potrebbe danneggiare la “rettitudine del cammino”. In che modo, esattamente? In che “modo” le famiglie in lutto, comprese quelle che hanno perso i propri cari il 7 ottobre e nella guerra che ne è seguita, e che ritengono di avere il dovere di agire in ogni modo possibile per garantire un futuro migliore a tutti noi, possono essere considerate un “fattore pericoloso”?
Sulla base di questo equivoco, al Forum è stata negata l’opportunità di proseguire il programma educativo “Dialogue Meetings”, che aveva operato con grande successo nel sistema educativo per anni. Le famiglie israeliane e palestinesi in lutto incontravano gli studenti nelle scuole, non per predicare, ma per raccontare storie, ascoltare e consentire loro un incontro umano con la complessa realtà del conflitto. Non l’ideologia e l’incitamento dei politici, ma le persone. Non slogan, ma vite spezzate. Il Ministro dell’Istruzione Yoav Kish teme apparentemente che gli studenti israeliani, compresi e soprattutto quelli che si avvicinano all’età della leva obbligatoria, siano esposti alla possibilità che la guerra, il lutto e un ciclo di spargimenti di sangue non siano scontati. Teme che sviluppino un pensiero critico, che ascoltino voci diverse, che capiscano che c’è un popolo palestinese che vive proprio accanto a loro e che i conflitti tra i popoli sono stati risolti in passato e possono essere risolti anche qui.
Grazie al Ministro Kish, nel 2026 gli studenti israeliani completeranno dodici anni di scuola senza alcuna reale conoscenza del conflitto stesso, delle sue radici, del suo costo umano e della possibilità di porvi fine. Saranno qualificati per essere soldati leali, ma difficilmente qualificati per essere cittadini dotati di pensiero critico, capaci di accogliere opinioni diverse e di affrontare la complessità. In un sistema educativo che pone al centro l’eroismo, il sacrificio e la volontà di combattere fino alla fine delle generazioni, non c’è posto per chi è in lutto e vuole parlare di vita, riconciliazione e responsabilità civica. Naturalmente, altre famiglie in lutto che santificano l’eroismo e il sacrificio sono invitate a scuola senza alcun problema; il problema inizia quando chi è in lutto pone un punto interrogativo e chiede un futuro diverso.
Questa lotta non è una questione specifica del Forum. Fa parte di un più ampio processo di silenziamento e persecuzione nel sistema educativo: insegnanti e presidi vengono trattenuti in udienza a causa delle loro posizioni, articoli di Haaretz vengono rimossi dagli esami di maturità, e vengono attaccate organizzazioni della società civile come “Brothers in Arms”. Allo stesso tempo, organizzazioni che promuovono la coercizione religiosa, l’esclusione delle donne, l’intolleranza verso le persone LGBTQ e l’opposizione alle donne che prestano servizio nelle Forze di Difesa israeliane operano nelle scuole senza alcuna restrizione. Il messaggio è chiaro: è lecito educare all’obbedienza e alla guerra, ma è proibito educare alla democrazia e alla pace.
Per giustificare il silenziamento, il Ministero dell’Istruzione si impegna anche in una deliberata delegittimazione: presenta il Forum come un’organizzazione di “famiglie di terroristi”, cancellando sistematicamente l’identità condivisa israelo-palestinese e il lutto israeliano al suo interno. Ciò fa parte di un profondo processo di disumanizzazione, in cui il riconoscimento stesso dell’umanità dell’altra parte e del dolore condiviso è percepito come un pericolo.
Tutte queste azioni, insieme agli attacchi al mondo accademico e alla creatività israeliani, sono interconnesse. Una società che desidera una guerra eterna non può permettersi un’educazione alla pace, nonostante l’educazione alla pace, alla tolleranza e alla dignità umana sia al centro della Legge sull’Istruzione Statale fin dalla fondazione dello Stato.
Chi impedisce agli studenti israeliani di essere esposti alla possibilità di un futuro diverso li condanna a continuare a vivere in un ciclo di spargimento di sangue. È imperativo educare alla pace. Non ci sarà altra realtà e altro futuro qui se non saremo educati e non agiremo consapevolmente, coerentemente e coraggiosamente per la pace. Solo una società che educa alla speranza può viverla.
(Haaretz, 20 gennaio 2026)
[…] domenica 18 gennaio 2026, decine di donne e attivisti si sono radunati in un presidio pacifico davanti alla base militare di Sigonella, storica infrastruttura italo-statunitense nel cuore della Sicilia, per lanciare un forte messaggio contro la guerra e la militarizzazione dei territori. L’iniziativa, promossa dal movimento “Le donne contro tutte le violenze”, si inserisce nel 35° anniversario dell’inizio della Guerra del Golfoe nella mobilitazione nazionale delle “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace”, contro i conflitti ancora in corso nel mondo.
Un presidio tra protesta e cultura
La manifestazione, iniziata alle ore 10.30 davanti la base militare di Sigonella, ha visto la presenza di cittadini, attiviste e musicisti. Tra slogan, canti e performance, le partecipanti hanno espresso la loro contrarietà alla presenza militare e al suo ruolo nei conflitti globali.
Durante l’evento sono stati eseguiti canti per la pace e momenti di riflessione in solidarietà con le donne iraniane che stanno protestando contro regimi autoritari. Una delle esibizioni di maggiore impatto è stata una rilettura del Monologo di Lisistrata, rivisitato dai celebri autori Franca Rame e Dario Fo, simbolo di ribellione femminile contro la guerra e il patriarcato.
Perché questa protesta
Le attiviste hanno elencato una serie di motivazioni alla base della protesta. Sigonella, secondo le partecipanti, non può essere vista come una semplice base logistica, ma è profondamente inserita nelle dinamiche belliche globali: operazioni di intelligence, sorveglianza e supporto a missioni internazionali partono regolarmente da qui, collegando la Sicilia a teatri di guerra in Europa, Medio Oriente e oltre.
Tra le richieste principali:
– La smilitarizzazione della Sicilia e la restituzione del territorio alla sua vocazione civile, culturale e pacifica;
– La conversione della base di Sigonella in struttura aeronautica civileper uso educativo e commerciale;
– La fine delle influenze militari nelle scuole e nella vita quotidiana dei giovani, percepite come propaganda e presenza invadente.
Secondo le organizzatrici, la presenza militare – inclusa quella di droni e velivoli in missioni di intelligence – rende il territorio siciliano sempre più esposto a possibili ripercussioni dovute ai conflitti internazionali, con un impatto sociale, istituzionale e culturale che va ben oltre il semplice ruolo operativo della base.
Ricordi storici e prospettive future “Verde Vigna” di Comiso.
Nel corso della manifestazione non sono mancati riferimenti storici alle battaglie pacifiste nel nostro Paese, come le mobilitazioni contro l’installazione dei missili Cruise nella base NATO di Comiso negli anni ’80, che portarono alla creazione di progetti per centri di vita nonviolenta e alla diffusione di una cultura disarmista nell’isola.
Conclusione in musica
La manifestazione si è conclusa in modo pacifico e partecipato sulle note della celebre canzone Blowin’ in the Wind di Bob Dylan, intonata da tutte le presenti come messaggio di speranza e invito alla riflessione sulle ingiustizie, le guerre e il valore della pace. […]
(Pressenza, 19 gennaio 2026)
C’è qualcosa di poetico nel varcare la soglia di una libreria a Milano. Da Brera a Garibaldi, da Duomo a Ticinese, abbiamo scovato gli indirizzi più belli (anche nascosti) dove acquistare un libro in città
Varcare una piccola porta e trovarsi, d’improvviso, in un luogo che trascende il tempo e lo spazio. Le preoccupazioni si alleggeriscono e anche la testa sembra abbandonare quelle costruzioni infondate che regolavano la vita all’esterno. Non c’è paura, e neppure adrenalina, solo ritmi lenti. La libreria è uno spazio magico, quasi poetico, in cui le idee danzano leggere, per poi raggiungere il cuore di chi le ha maturate. Tra scaffali stracolmi di libri, angoli e volumi speciali, l’uomo ritrova la sua dimensione autentica. È come se su quella porta – a caratteri cubitali – ci fosse scritto “Lasciati andare”. Scegliere la copertina su cui lo sguardo si posa, perdersi tra le brevi righe della trama, o magari della vita dell’autore – ci sarà una correlazione? A Milano, poi, ci sono alcuni indirizzi nascosti – ai più sconosciuti – in cui la scelta del libro diventa esperienza sensoriale. Interni eleganti in cui trovare antiche, prime, edizioni, ma anche spazi più moderni, lì a ricordarci che il tempo passa, ma la bellezza della letteratura no. C’è la Libreria del mare, per chi desidera perdersi (o ritrovarsi) nella profondità dell’acqua, quella delle donne o dello spettacolo. Perché entrare in libreria è come prendere la rincorsa, saltare, e afferrare la vita, entrandoci in sintonia. Esiste sensazione migliore?
Le 10 librerie più belle di Milano, da Brera a Garibaldi, da Duomo a Ticinese
Abbiamo selezionato dieci librerie nel cuore di Milano che vale davvero la pena conoscere. Indirizzi nascosti per chi cerca un libro, leggerezza, o anche solo uno sguardo complice – «Quello l’ho letto, mi ha cambiato la vita». Ecco la selezione di Vogue Italia.
Libreria Bocca dal 1775
Il primo luogo che vi suggeriamo si trova nel cuore di Milano, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II. La Libreria Bocca è una delle librerie più antiche d’Italia, con origini che risalgono al 1775 e una storia di prestigio editoriale unico. L’atmosfera è elegante e intima, con scaffali e oggetti che raccontano secoli di cultura, quasi come un piccolo museo del libro. È considerata autentica per la sua indipendenza, gestione familiare e selezione curata di titoli, lontana dalla standardizzazione delle grandi catene. Qui si trovano soprattutto monografie d’arte, cataloghi di mostre, libri dedicati a pittura, scultura, architettura e design. I suoi spazi sono ricchi di opere d’arte, profumi di carta e un’atmosfera che invita a esplorare con calma ogni titolo.
Libreria del Mare
Varcando la porta, si respira ancora il fascino di un’antica bottega, una di quelle d’altri tempi. La Libreria del Mare (ex salumeria negli anni Settanta) è oggi situata al civico 28 di via Broletto, ed è dedicata alla cultura marinaresca e ai libri sul mare. L’atmosfera è accogliente e suggestiva: scaffali colmi di testi, vecchi arredi e richiami visivi al mondo nautico creano un’esperienza che evoca il profumo del mare anche nel bel mezzo della città. Qui si vendono oltre 10.000 libri e pubblicazioni su navigazione, cartografia nautica, costruzione di barche, pesca, biologia marina e sport acquatici, ma anche volumi in inglese e francese. Oltre ai libri tecnici e storici, la libreria propone guide, racconti di viaggio, romanzi a tema marino e portolani nautici. Un piccolo pezzo di mare nel cuore di Milano.
Libreria Verso – libri, incontri, bar
Per chi cerca un’esperienza culturale diversa, e poliedrica, Verso – libri, incontri, bar è l’indirizzo giusto. Situata nel quartiere Ticinese, presenta un’atmosfera accogliente e dinamica: non solo libreria, ma anche bar con tavolini, divani e poltrone – l’angolo perfetto per leggere, chiacchierare o semplicemente fermarsi a prendere un caffè o un drink. La selezione di libri comprende narrativa italiana e straniera, classici e contemporanei, fumetti, graphic novel e volumi illustrati, oltre a musica, cinema e un’ampia sezione per l’infanzia. Lo spazio si dedica anche all’organizzazione di presentazioni, letture, corsi e cicli di incontri tematici, rendendo l’esperienza viva e formativa.
Libreria delle Donne
Punto di riferimento del femminismo milanese e italiano fin dal 1975, la Libreria delle Donne è nata per dare visibilità alle scrittrici (e pensatrici) donne quando ancora erano marginalizzate nell’editoria tradizionale. Situata in via Pietro Calvi 29, si presenta come uno spazio di relazione culturale e politica dove si discute, si legge e si costruiscono idee insieme. La selezione di libri è vasta: offre migliaia di titoli di saggistica, narrativa, poesia, studi di genere e testi politici scritti da donne, inclusi volumi rari e fuori catalogo.
Libreria dello Spettacolo
Per gli appassionati delle arti performative – dal teatro alla danza, passando per musica e circo – questo è l’indirizzo da segnare in agenda. Il fascino è quello di una libreria d’altri tempi, con l’insegna che condivide emozioni al primo (fugace) sguardo. Situata in zona Cadorna, al civico 11 di Via Terraggio, la Libreria dello Spettacolo è gestita da quasi quarant’anni da Maria Cristina Spigaglia, che ha raccolto un tesoro di volumi, copioni, sceneggiature, manifesti e cimeli rari. I primi pezzi le arrivarono dagli antiquari, poi, man mano che si sparse la voce, le vedove degli attori iniziarono a contattarla. Alcuni pezzi sono in vendita, altri possono essere solo consultati. Qui il tempo sembra essersi fermato, tra scaffali colmi di testi d’epoca e memorabilia che evocano il mondo dello spettacolo in tutta la sua magia.
Libri senza data
Sempre nel quartiere Ticinese, si trova un altro indirizzo davvero speciale: Libri Senza Data. Si tratta di una libreria antiquaria specializzata in volumi rari, edizioni originali e libri fuori commercio, un vero tesoro per i collezionisti. La selezione comprende prime edizioni, testi delle avanguardie artistiche, autografi, riviste storiche e titoli difficili da trovare altrove, anche per argomenti di nicchia. In questo spazio intimo è possibile anche richiedere consulenze o ricerche personalizzate, per individuare il proprio libro speciale.
Scatola Lilla
Per chi cerca una piccola libreria, intima e curata, Scatola Lilla è il luogo perfetto. Nata dalla passione di Cristina Di Canio per i libri, si trova in Porta Romana. L’ambiente è accogliente e colorato, caratterizzato dalle pareti lilla che danno il nome alla libreria e da scaffali colmi di volumi scelti con cura, creando un’atmosfera familiare e calorosa. La Scatola Lilla organizza anche eventi culturali, gruppi di lettura e presentazioni, diventando un piccolo centro culturale di quartiere.
Tempo Ritrovato Libri
Più che un negozio di libri, è uno spazio di dialogo culturale. Tempo Ritrovato Libri, in corso Giuseppe Garibaldi 17, presenta scaffali in legno, pareti tranquille e un ambiente che invita a fermarsi, sfogliare e conversare con chi lavora lì, tra un sorriso e uno sguardo complice. È considerata una delle librerie più autentiche di Milano per la selezione accurata di titoli e per il fatto di valorizzare piccole case editrici indipendenti. La proposta comprende soprattutto narrativa e saggistica, con particolare attenzione alla letteratura contemporanea, alla critica culturale e alle opere di editori non mainstream.
(Vogue Italia, 19 gennaio 2026)
Sono arrivate da varie parti della Sicilia per ribadire il proprio “No” alla guerra e alla violenza. E lo hanno fatto con un presidio-manifestazione davanti alla base di Sigonella, di cui chiedono da tempo la smilitarizzazione. Fanno parte della rete italiana “10 100 1000 piazze di donne per la pace” che si è costituita nel giugno scorso per opporsi al genocidio dei palestinesi, alla guerra e alla repressione dei popoli e delle libertà femminili. Queste donne ora scendono in strada di nuovo, in occasione del trentacinquesimo anniversario della Guerra del Golfo che allora suscitò sgomento e sorpresa, mentre oggi le guerre scoppiano ovunque nel mondo come se questo fosse ritenuto normale.
E, invece, queste donne – e gli uomini che stanno al loro fianco – gridano che la guerra non deve essere considerata come un orizzonte percorribile, come una delle possibilità, perché le guerre e le strutture militari generano dolore e morte e questo è sempre inaccettabile. «Noi donne – dice Anna Di Salvo della Ragna-Tela – pratichiamo la politica della vicinanza e della prossimità, ma la base di Sigonella, collegata al Muos e al porto militare di Augusta, è una pessima vicina di casa. La sua presenza fa sentire la nostra isola e il nostro territorio minacciati. Questa nostra terra, che per i doni che ha ricevuto è vocata alla bellezza e alla produttività, è stata votata al dolore, alla guerra e alla devastazione. Da qui partono i droni e i bombardieri per i fronti di guerra e questa base ha avuto un ruolo attivo anche nel genocidio del popolo palestinese».
Per questo le donne di La Città Felice, Ragna-Tela, Udi, Cgil, Fare stormo, Il cerchio delle donne, Centro antiviolenza Elvira Colosi, Penelope, Femministorie e Donne di classe, insieme agli attivisti di Catanesi solidali con il popolo palestinese, Anpi, Rifondazione, Comitato Antico Corso, Circolo Olga Benario, Sunia e Cobas scuola, Koine, Potere al popolo, No Muos, Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra anticapitalista gridano che Sigonella va smilitarizzata. «Perché è un avamposto di guerra e di morte nel nostro territorio; perché è una base americana e italiana da cui ogni giorno partono sofisticate armi che uccidono bambini/e, donne e uomini, distruggono città e territori e alimentano la sete di potere e sangue degli ottusi governanti del mondo; perché l’aggressione di Trump al Venezuela e l’espansionismo americano vanno fermati; e perché patriarcato, guerre e violenze maschili sono per noi un’unica narrazione». Per questo queste donne si oppongono al militarismo che «è una cultura bieca affine al bullismo», una cultura che «normalizza lo stupro di guerra, soprattutto dei popoli vinti, per cui si fa scempio del corpo delle donne come si fa scempio dei territori e dei popoli come in Palestina, Sudan e Iran». Contro questa cultura ribadiscono la loro attenzione all’ambiente, alla pace, alle regole pacifiche di convivenza e alla composizione dei conflitti senza ricorso alla violenza. Per questo si oppongono al paradigma che considera la guerra come naturale, e dunque al ripristino della leva obbligatoria e alla promozione della carriera militare nelle scuole. «Vogliamo disarmare le parole per disarmare le menti», ripetono mentre srotolano i loro striscioni che gridano «Fuori la guerra dalla storia» e «Donne vita libertà» in omaggio alle donne iraniane massacrate da un regime violento e misogino.
(La Sicilia, 19 gennaio 2026)
C’è una storia della lotta delle donne iraniane contro il regime degli ayatollah che viene da lontano e che oggi rischia di essere travolta dalla rivolta in corso in Iran, a cui anche le donne stanno partecipando e morendo sotto la feroce repressione. Mi riferisco al fatto che l’ondata di protesta pacifica, scoppiata il 27 dicembre scorso dal Bazar di Teheran per il crollo della valuta locale e la crisi economica e dilagata rapidamente in tutto il Paese, a un certo punto si è trasformata in violenza e caos. Alcuni manifestanti nella capitale hanno dato alle fiamme auto, palazzi governativi, banche, moschee, autobus, e c’è chi – israeliani e statunitensi – soffia sul fuoco e minaccia interventi militari in nome della libertà dal tiranno, come hanno fatto, con esiti catastrofici, in Iraq, in Libano, in Siria e in Afghanistan “per la libertà delle donne”. In difesa del regime e della patria, contro le minacce dei nemici interni ed esterni, gli ayatollah hanno chiamato in piazza migliaia di iraniani, agitando così il fantasma di una guerra civile. Minacce e violenze che hanno reso più feroce la repressione nelle piazze con migliaia di morti, feriti, carcerazioni con condanne a morte. Vittime tantissime/i giovani che si sono uniti alle proteste. Rubina Aminian è una di loro. Giovane studentessa curda, si era unita alle proteste dopo essere uscita dall’università a Teheran. Le hanno sparato alla nuca, di spalle, a distanza ravvicinata. Ai suoi genitori hanno negato il funerale, dopo aver trovato davanti all’università il suo corpo dentro un sacco nero, accanto a centinaia di corpi di altre/i giovani. «Non siamo ingenui – dice Arezu F. del movimento “Donna, Vita, Libertà” (il manifesto, 13/01/2026) –. Il regime non crolla in pochi giorni. Il nocciolo duro del potere regge ancora e mantiene intatto il proprio apparato repressivo, insieme a una forza economica riservata a pochi. La strada è lunga. Un intervento militare non servirebbe a nulla, né a cambiare il sistema né a difendere i manifestanti. Occorre pazienza: lavorare per lunghi scioperi nei settori chiave, portare i militari dalla parte della popolazione ed evitare di trascinare il Paese verso un futuro di conflitti dagli esiti imprevedibili». La strada è lunga ma sono le donne iraniane, insieme agli uomini, che la devono percorrere fino in fondo, memori del tradimento subito dalle loro madri da Khomeini, “il Messia”, dopo la rivoluzione del 1979. Cacciato lo scià, la rivoluzione, di cui le donne furono protagoniste, prometteva democrazia e libertà. Le donne ben presto si resero conto che, con la salita al potere dei militanti islamici, avevano portato al governo un regime che imponeva loro la sottomissione, in nome di Dio e del Corano. La ribellione fu immediata. Per l’8 marzo di quell’anno, centomila donne scesero in piazza per protestare contro l’obbligo dell’hijab e altre restrizioni islamiche. Molte manifestanti furono aggredite e ferite da gruppi di fanatici e paramilitari, sotto lo sguardo impassibile delle forze di sicurezza. Da allora la rivolta contro l’obbligo del velo non si è più fermata, inventando, di volta in volta, nuove pratiche di resistenza e di ribellione fino al 2022 quando la morte di Mahsa Amini, la giovane studentessa curda uccisa dalla “polizia morale” per aver indossato il velo in modo non conforme, determinò una svolta. Nacque il movimento Donna, Vita, Libertà il cui grido risuonò in tutte le piazze del mondo. A Teheran le donne nelle piazze sfidarono il regime, si tolsero il velo, si tagliarono ciocche di capelli in segno di protesta, la repressione fu feroce ma non fermò la protesta sostenuta dalle donne in tutto il mondo. Un sostegno mai venuto meno. Oggi, la piazza di Teheran non è più la piazza delle donne e forse è tempo per loro di andare via da lì – cosa che sta già accadendo – per vanificare il tentativo di Trump e Netanyahu che stanno cercando di appropriarsi della loro lotta per fini che nulla hanno a che fare con la loro libertà.
(L’Altravoce il Quotidiano, rubrica “Io Donna”, 18 gennaio 2026)

Maria Grazia Campari, nata il 30 agosto 1940 a Bologna e morta il 7 gennaio 2026, è stata avvocata civilista, specializzata in diritto del lavoro; per le donne svolgeva anche attività di diritto di famiglia, assistendole in separazioni, divorzi e affidamento di figlie e figli.
Ha fatto parte del gruppo giuriste del Tribunale di Milano, città in cui ha vissuto ed esercitato la sua professione, e ha collaborato con varie riviste e libri collettanei. Per la Libreria delle donne ha scritto con Lia Cigarini l’importante testo “Fonte e principi di un nuovo diritto” nel “Sottosopra oro” Un filo di felicità del 1989.
In seguito alle sue esperienze di pratica del processo e di assistenza alle vertenze delle lavoratrici (come la vertenza alle “conchiglie” dell’Alfa Romeo di cui racconta nella testimonianza qui sotto), in relazione con Luisa Cavaliere, Elettra Deiana e altre fonda il 23 novembre 1993 l’Osservatorio sul Lavoro delle Donne, associazione che nasce dalla constatazione dello scarto esistente tra la volontà femminile di protagonismo sociale e la sua realizzazione e dalla convinzione che tale scarto possa essere superato attraverso una pratica politica che produca autonomia delle donne. Attraverso la creazione e l’esercizio di pratiche di giustizia femminile si propone di promuovere l’acquisizione di libertà materiale e simbolica delle donne nel mondo del lavoro. L’associazione è stata attiva fino al 2004.
Socia della Libera Università delle Donne (LUD) di Milano, dopo il ritiro dalla professione si è trasferita a Firenze, dove ha fatto parte dell’associazione Rosa Luxemburg.
È stata intervistata e ha portato la sua significativa esperienza nel libro Mia madre femminista. Voci da una rivoluzione che continua di Marina Santini e Luciana Tavernini (Il Poligrafo, 2015), e qui la ripubblichiamo.
Crepe nel diritto: l’Osservatorio sul Lavoro delle Donne
Maria Grazia Campari
Alla fine degli anni Novanta, a Milano, alcune femministe diedero vita all’Osservatorio sul Lavoro delle Donne, un’associazione formata da giuriste, sindacaliste, lavoratrici.
Negli incontri, con le modalità dell’autocoscienza e mettendo in gioco il nostro sapere professionale, cercammo di svelare come la giustizia fosse organizzata in modo sessista e di individuare azioni e riflessioni per operare un cambiamento.
Inventammo una pratica del processo che si costruiva attraverso una relazione fra donne (cliente/avvocata/consulente scientifica), nel riconoscimento di autorevolezza e nella circolazione di sapere, per sostenere nel giudizio una pretesa sociale femminile, spunto per regole nuove, segnate (questa è la novità) dai soggetti dei due sessi.
Il diritto si presenta come un Giano bifronte: garantisce l’ordine vigente capitalistico-patriarcale, ma ha in sé un principio di trasformazione poiché afferma anche diritti umani, diritti di ogni persona di qualunque sesso o razza. Di qui la scommessa: le crepe garantiste dell’ordinamento potevano essere usate come fattore di modifica dei valori dati, utilizzando le pronunce delle corti di giustizia sui casi della vita. È la creazione del diritto vivente di origine giurisprudenziale e significative sperimentazioni si sono prodotte nell’ambito del diritto del lavoro. Ottenemmo dei successi quando realizzammo una diversa modalità di stare in relazione tra donne, anche nei conflitti sindacali.
Ricordo, ad esempio, il caso che portò alla modificazione dell’organizzazione del lavoro in un importante settore (le “conchiglie”) nel reparto fonderia dell’Alfa Romeo di Arese, in cui alcune operaie erano state inserite a seguito di assunzione in base alla legge di parità (L. 903/1977).
Molte di loro considerarono le mansioni e il reparto nocivi in modo insopportabile, malgrado fossero sempre stati sopportati (ovviamente malvolentieri) dai colleghi maschi e iniziarono un’agitazione e un processo di contestazione. Fu effettuato un sopralluogo da parte di esperti aziendali e sindacali, alla presenza dei legali delle parti.
La visione del reparto e delle “conchiglie” fu per me impressionante come quella di un girone infernale: si trattava di maneggiare manualmente bracci metallici che obbligavano a posizionarsi in prossimità dei forni in cui bruciava, senza apparente schermatura, un fuoco vivo. Pensai che chiunque, non solo le neoassunte, avrebbe dovuto scappare da quel luogo pericoloso.
Iniziò una vertenza sostenuta dal sindacato di zona e soprattutto da un delegato della CGIL staccato dalla produzione ed esperto del lavoro in fonderia. Dopo mesi di conflitti e di trattative, si trovò un accordo fra le parti che condusse alla robotizzazione del reparto: invece di insinuarsi in prossimità dei fuochi, si azionavano robot manovrando appositi comandi a distanza.
In questo caso il conflitto aperto dalla manodopera femminile, adeguatamente sostenuta dall’organizzazione complessiva dei lavoratori, aveva determinato un esito positivo per tutti.
Però questa pratica non si è diffusa a sufficienza per produrre le modificazioni che pure stavano a cuore a molte. Ciò è dovuto al fatto che apporti autonomi delle donne in conflitti sindacali, in cui erano coinvolte, non erano considerati un rafforzamento, ma un dato inquietante dagli esponenti maschili della forza lavoro. Va registrata anche un’insufficiente determinazione delle donne dell’Osservatorio rispetto al progetto che si erano date, io fra loro.
Si operò, se non una complicità inconsapevole, certo una sottovalutazione del fatto che l’alternativa fra quanto le donne ritengono desiderabile per sé e quanto gli uomini hanno stabilito per tutte e tutti, rende inevitabile un conflitto fra i sessi per l’attribuzione delle risorse e per l’autogoverno della propria vita.
(www.libreriadelledonne.it, 17 gennaio 2026)
Ogni romanzo è un sopravvissuto. A un editor goffo, a un editore stupido o stronzo o modaiolo, a una miseria del tempo in cui viene pubblicato, a una maledetta sfortuna e, prima di ogni cosa, al genere di chi lo ha scritto. La domanda che è sempre affascinante e ragionevole porci, quando leggiamo una scrittrice, è: lo avrebbe scritto così, se non fosse stata una donna? Fatto salvo che la differenza sessuale conta, assegna uno sguardo e un sentire (chi scrive si colloca con agio nel femminismo della differenza), e quindi la prima risposta è sempre no, c’è poi la più complicata questione di quello che a una scrittrice viene detto, consigliato, talvolta imposto di scrivere proprio perché è una donna. Le storie dei rifiuti editoriali dei capolavori di grandi scrittrici spesso costituiscono romanzo a sé, sebbene siano meno note e tracciate rispetto alle storie dei rifiuti editoriali subiti dai colleghi: quando si parla del fenomeno, e lo si fa nella sciagurata chiave «Coraggio, non desistere, anche Stephen King è stato messo alla porta», si rimanda quasi soltanto ai no assestati agli autori. Il rifiuto editoriale archetipico è sempre Il Gattopardo, mai Via col Vento.
Delle scrittrici, tuttavia, sono più intriganti le storie delle correzioni, i consigli che hanno dovuto ascoltare, gli snaturamenti delle loro opere. Alle scrittrici è successo di più che agli uomini, e in un modo preciso: dovevano dar conto di essere donne, e a lungo ci sono state cose che le donne potevano scrivere e cose che, invece, no, perché avrebbe nuociuto alla loro reputazione, perché avrebbe scandalizzato, perché avrebbe pervertito (aha!) adolescenze, etiche, ruoli. Se in molte hanno usato uno pseudonimo anche quando essere una donna è diventato, ai fini della pubblicazione, un bonus, è anche per non doversi sentir dire a quale categoria corrispondere: fino agli anni Settanta per pubblicare era tanto meglio essere (e/o scrivere da) morigerata borghese, santa, pettegola, guerrafondaia (Sibilla Aleramo non avrebbe probabilmente mai pubblicato se, ai suoi esordi, non fosse stata – non avesse scritto da – accesa interventista); ultimamente conviene aver subito quello che si racconta, soffrire di un qualche disturbo, avere un qualche cronico travaglio. È divertente che le più libere da questo giogo siano ora le autrici di romance, che non proprio a caso usano solo pseudonimi (Erin Doom, Felicia Kingsley, Stefania S.), visto che il romance è un genere al quale le autrici sono state relegate per decenni ritenendo che solo di quello potessero occuparsi e che quindi essere una scrittrice significasse fare romanzi rosa (era per smarcarsi da questo orribile sinolo che Morante ordinava di chiamarla scrittore). Per difficile che sia da immaginare, vista la mole di pubblicazioni, i rifiuti e le correzioni, anche autoindotte, a fini di performance, capitano ancora, e si intuiscono alla semplice lettura. Molta letteratura femminile contemporanea risente ancora del bisogno, tutto editoriale, di inscrivere una scrittrice nelle storie che racconta, e di decidere per quali storie di donne c’è o ci sarebbe mercato. Quanto sarebbe utile un esaustivo volume che raccontasse tutte le volte che una romanziera, dal 1726 al 2026 si è sentita dire «questa storia ti rappresenta?». Alarico Tassè, nome dietro cui è rimasta ostinatamente celata
l’autrice di alcuni dei racconti più precisi e spietati del ’900 italiano, Il topo Chuchundra (nel 1963 per Feltrinelli e nel 2017 per Elliot, grazie all’eroica Giulia Caminito), si astenne dallo svelare chi fosse e pure dallo scrivere altro per non doversi sedere a discutere con un editore. Per non dover dire «mi veda, sono brava», come fece per tutta la vita Dolores Prato, che esordì a ottantotto anni con il capolavoro Giù la piazza non c’è nessuno, falcidiato da un corposo taglio imposto da Natalia Ginzburg. Prato, che per decenni chiese e a volte supplicò, ma non cambiò mai una virgola, cedette solo con Ginzburg, perché era Ginzburg. […]
(La Stampa – TuttoLibri, 17 gennaio 2026)
«Tutti gli uomini, salvo poche eccezioni, e di qualunque classe sociale, considerano come un fenomeno naturale il loro privilegio di sesso e lo difendono con una tenacia meravigliosa, chiamando in aiuto Dio, Chiesa, scienza, etica e leggi vigenti che non sono altro che la sanzione legale della prepotenza di una classe e di un sesso dominante».
Le parole che avete appena sentito sono tratte da un discorso intitolato Il monopolio dell’uomo, che nel 1890 Anna Kulishoff fece al circolo filologico milanese, prima relatrice donna. A lei, a una figura centrale ma troppo spesso trascurata della storia politica e intellettuale italiana tra 8 e 900, è dedicato Con gli occhi di Anna, un podcast di Sara Poma, già autrice di altri lavori su alcune figure femminili rimaste ai margini del racconto pubblico.
Medica, socialista e femminista, Kulishoff ha legato in modo inscindibile la questione sociale e quella femminile. Nata nell’impero russo verso la metà dell’Ottocento, si formò tra Russia e Svizzera per poi scegliere l’Italia come luogo di impegno politico e professionale. Tra le prime donne laureate in medicina in Italia fu conosciuta come la dottora dei poveri per il lavoro svolto gratuitamente nei quartieri popolari di Milano.
Protagonista del socialismo riformista a fianco del suo compagno Filippo Turati, Kulishoff animò riviste e dibattiti e si batté per la tutela del lavoro femminile e per il diritto di voto alle donne, spesso anche contro le resistenze del suo stesso partito. A cent’anni dalla sua morte, molte delle questioni che pose restano aperte e continuano a interrogare il presente. Parliamo di Con gli occhi di Anna con la sua autrice, Sara Poma, curatrice di contenuti audio per Chora Media.
Allora, questo è uno di quei casi felici e fortunati in cui una ricorrenza, quindi un lavoro commissionato per questa ricorrenza, cioè il centenario dalla morte di Anna Kulishoff, mi ha permesso di scoprire una storia stupefacente.
Come tante altre persone, io conoscevo il nome di Anna Kulishoff, sapevo che era stata una femminista ante litteram che era legata al nome di Turati e di Andrea Costa, ma ignoravo completamente – nonostante viva nella sua città in cui ha vissuto, ha pensato, ha fatto cose importantissime – ignoravo le cose gigantesche che ha fatto e quanto sensazionale sia stata la sua vita. Quindi il podcast è nato così, come un progetto da inserire nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla morte di Anna Kulishoff e per me è stato veramente un viaggio di scoperta importantissimo di una figura che, nonostante sia vissuta moltissimo tempo fa, ancora trovo attualissima e contemporanea.
In passato hai già raccontato alcune figure femminili forti che hanno vissuto ai margini della storia ufficiale, penso per esempio a Carla, una ragazza del Novecento, in cui racconti la storia di tua nonna basandoti sui suoi diari, oppure a Prima, in cui ricostruisci la vita della prima persona che si è dichiarata pubblicamente omosessuale in Italia nel ’72, o anche a Figlie, in cui racconti una storia personale legata alla dittatura argentina. In quale modo questo podcast su Anna Kulishoff dialoga con questi lavori precedenti e in quale modo invece se ne discosta?
Naturalmente non lo potevo sapere quando ho iniziato, ma in qualche modo la storia di Anna Kulishoff, il suo pensiero, è un po’ una matrice per tutto ciò che è la storia delle donne del Novecento. Le cose che lei ha pensato, ha cercato di mettere in pratica, in qualche modo hanno sicuramente influito nella vita delle donne che sono venute dopo di lei.
Citavi il primo podcast che io ho realizzato, ancora quando Chora non esisteva, e il mondo dei podcast era molto diverso da quello di oggi. Questo podcast che si chiama Carla, una ragazza del Novecento sulla vita di mia nonna, che è stata un’infermiera e ha trovato la sua emancipazione, liberazione attraverso proprio il suo lavoro di infermiera. Se lo riguardo oggi nella prospettiva di quello che Anna Kulishoff ha fatto per il lavoro femminile, per i diritti delle donne, vedo che sicuramente c’è un legame, così come anche per quanto riguarda Mariasilvia Spolato in Prima e per la storia di Figlie, che ha al centro la vita di un’architetta desaparecida durante la dittatura argentina.
Quelle sono persone, donne, che in modo diverso si sono battute e ne hanno pagato le conseguenze cercando di immaginare un mondo più giusto e più equo, cosa che ha fatto anche Anna. Quindi mi sembra, volendo tirare dei fili, devo dire che quei fili sicuramente riconducono alla storia di Anna, solo che quando ho lavorato a queste altre storie di fatto non lo sapevo. È stato proprio un viaggio di scoperta anche per me, quest’ultimo podcast.
Parli di scoperta, dal podcast emerge una figura molto complessa che tiene insieme femminismo, socialismo, la professione medica, anche una vita privata decisamente anticonformista. Preparandoti a questo podcast, cosa ti ha sorpreso di più e che cosa hai trovato più difficile da raccontare?
La cosa più sorprendente nel mio viaggio alla scoperta di questa figura è stato proprio il tema legato al suo essere socialista, proprio a questa parola, “socialismo”, una parola che a noi in Italia oggi riporta alla mente tutta una serie di cose che in qualche modo, per varie ragioni abbiamo deciso di dimenticare, di silenziare, ma l’essere socialista di Anna contiene tantissime cose. In primo luogo il suo pensiero femminista, la sua tensione verso le persone ai margini, le persone più bisognose, le persone verso cui ogni suo pensiero, ogni sua azione tendeva per cercare di immaginare una vita migliore.
E se dovessi dire, la cosa che mi porto a casa dopo aver esplorato questa storia è quanto questa parola “socialista” forse ce la dobbiamo riprendere in qualche modo. Forse va rivendicata in un mondo come quello di oggi. Guardiamo con tanta curiosità, attenzione quello che farà Mamdani a New York, quando vediamo e ci stupiamo tutte le parole anche molto pratiche e molto concrete che hanno un impatto sulla vita quotidiana delle persone sono legate al mondo socialista che guardiamo oltreoceano.
Io ho pensato che tutto viene da quella matrice, da quel pensiero di Anna Kulishoff e delle persone che come lei in quel momento lottavano per immaginare un mondo diverso, un mondo che poi si è scontrato con l’avvento del fascismo ma che rimane ancora estremamente vitale e a cui mi sono sentita di guardare con molta speranza. Questa è una storia che a rimetterla insieme in ogni suo pezzo, al di là dell’epilogo, che sicuramente è stato un epilogo tragico e ingiusto anche per quella che è stata la vita di Anna che si va a schiantare con l’avvento di Mussolini, però penso che sia qualcosa a cui riguardare oggi per nutrirci di speranza in un momento in cui sicuramente ne abbiamo tanto bisogno.
E quali sono gli aspetti del suo pensiero e delle sue battaglie che ti sembrano ancora oggi attuali?
Sicuramente tutto ciò che ha a che fare con l’impatto concreto sulla vita delle persone. La sua era una politica molto concreta che si rivolgeva soprattutto alle donne per tentare di migliorare la condizione femminile che all’epoca era una condizione disastrosa e terribile, perciò questo elemento di concretezza, di impatto reale, fisico sulla vita delle persone.
Lei oltretutto ha provato a portare avanti anche delle cose di cui stiamo discutendo ancora ora, per esempio il gap salariale: ne parlava più di cento anni fa e oggi si dice che ci vorranno centotrent’anni perché donne e uomini abbiano lo stesso salario; siamo ancora a questo punto però ci sono delle istanze che lei ha immaginato, portato avanti e cercato di rendere molto pratiche già alla fine dell’Ottocento.
Questa per me è stata una cosa veramente incredibile come tutto il suo lavoro di medica: lei per prima insieme alla società civile milanese che si formava in quegli anni ha capito che la medicina deve avere una funzione sociale, quindi in qualche modo anche lei si è inventata quello che oggi sono i consultori.
Certo lo faceva in modo clandestino e “punk” perché ricordo che le donne non potevano studiare, in alcuni casi. Lei è stata una delle prime donne a laurearsi in medicina e a voler praticare la professione di medica anche se non era possibile farlo e lei è riuscita a mettere in piedi questi luoghi dove le persone che avevano bisogno e non potevano permettersi le cure andavano e venivano ascoltate.
Prima di tutto questi sono i due elementi: la parte relativa alla cura delle persone e la parte relativa all’impatto veramente concreto nella vita delle persone sono le cose che più mi hanno colpito del suo pensiero e che trovo siano ancora estremamente attuali.
Nel tuo racconto fai entrare anche il tuo sguardo e il tuo processo di ricerca. Cosa significa per te raccontare la storia in questo modo e cosa speri che resti a chi ascolta?
Allora, a me piace moltissimo portare chi ascolta insieme a me in questo processo di scoperta perché credo che sia un modo per aumentare l’empatia verso la storia che sto raccontando, seguirmi genuinamente in questo processo di scoperta.
Io davvero partivo dal sapere veramente pochissimo di questa donna, mi sembra un patto di comunione e fiducia nei confronti di chi mi ascolta e credo che in qualche modo lo svelamento della storia così risulti più potente.
Quindi mi piace moltissimo quando racconto questo tipo di storie inserire anche tante parti di registrazioni in cui si sente lo sfogliare delle carte negli archivi si sentono i citofoni che vengono suonati o le porte che si aprono perché penso che diventi come dire un viaggio non solo per me ma anche fatto insieme a chi ha voglia di seguire questa storia insieme a me.
Ed è diciamo ormai una cosa che è più forte di me; non riesco a sedermi in uno studio e raccontare una storia leggendo un testo semplicemente.
Ci devono essere sempre queste parti che sono per me vitali per rendere questa storia più vera e più vicina e quindi anche in questo podcast ho voluto fare in questo modo.
(Il Mondo Cultura [podcast di Internazionale per abbonati], 17 gennaio 2026)
La sede dell’Anw jigi art si trova lontano dal trambusto del centro di Bamako, nascosta in un quartiere tranquillo. L’associazione è guidata da Assitan Tangara, rappresentante di una nuova generazione di artisti socialmente impegnati, ben inseriti nelle loro comunità, che fin da piccoli hanno nutrito una passione per il palcoscenico.
Per raggiungere l’Anw jigi art a Djalakorodji, un sobborgo nella periferia settentrionale della capitale maliana, percorro strade caotiche e sconnesse, ma grazie all’aiuto delle persone del posto riesco a orientarmi. L’ingresso è segnalato da qualche manifesto colorato e pneumatici riciclati. Lì, in una casa dall’aspetto modesto trasformata in centro culturale, incontro Assitan Tangara, attrice dall’eleganza sobria, fondatrice dell’associazione e da poco anche presidente della federazione Funu funu (‘vortici’, nella lingua bambara), una collaborazione tra l’Anw jigi art e altri gruppi di creativi maliani. È vestita normalmente, con un semplice boubou, cosa che la distingue dagli artisti maliani che ho incontrato finora, spesso definiti da uno stile originale, con gioielli artigianali e preziosi tessuti locali.
«Se vuoi guadagnarti la loro fiducia, devi somigliargli», mi confida con un sorriso Tangara, riferendosi al suo pubblico di donne comuni. Un’introduzione sincera e concreta, che riflette lo spirito del suo lavoro: lei usa il teatro per sensibilizzare, educare e amplificare le voci più trascurate. Fin da subito l’attrice ha capito che una carriera nel mondo dell’arte l’avrebbe portata ad affrontare il giudizio degli spettatori e a dover superare molti ostacoli. Quella resilienza conquistata con fatica oggi la guida come una bussola: «Considero sempre le difficoltà delle lezioni da imparare. Si deve restare fedeli alle proprie convinzioni e avere un obiettivo chiaro».
Confida nell’arte come strumento di dialogo, come ponte per unire generazioni e gruppi sociali diversi. «Perché possa esserci un vero scambio, le persone devono essere disposte a incontrarsi, a esprimere la loro verità. Il Mali di oggi ne ha un disperato bisogno».
Le brillano gli occhi per l’emozione quando parla della sua commedia, Sinankouya, che racconta la tradizione di prendersi in giro tra parenti, anche fra gruppi etnici diversi, in cui la risata e il confronto aiutano a capirsi meglio.
Fin dall’inizio l’Anw jigi art si è dedicata alla creazione di uno spazio in cui le donne possono parlare liberamente, rivendicare il loro posto nella società e stimolare il cambiamento.
Nei gruppi di dibattito con le donne della comunità si trattano argomenti considerati tabù: menopausa, mestruazioni, divorzio o violenza di genere. Senza giudicare o imporre il proprio punto di vista, gli scrittori e gli attori le ascoltano con attenzione, raccogliendo frammenti di vita che poi trasformano in testi teatrali.
Un esempio è il progetto Moussoya gundo (‘Segreti di donne’), in cui Tangara e gli attori della sua compagnia mettono in discussione i dettami religiosi e le barriere socioeconomiche. Lo spettacolo ha creato uno spazio di dialogo tra donne provenienti da contesti diversi, nel corso del quale sono stati accesi i riflettori su quei vincoli religiosi e sociali che le costringono a essere sottomesse.
Ispirati dalla realtà
Tangara vuole che il suo teatro sia radicato nella realtà e ispirato alle esperienze delle persone più vulnerabili: «Andiamo da loro, ascoltiamo le loro storie e, a partire da quelle, cominciamo a scrivere».
I suoi spettacoli non vanno in scena solo nei teatri tradizionali, ma prendono vita nelle strade, nei mercati, nei cortili e perfino a bordo dei sotrama, i sovraffollati minibus di Bamako. Questa scelta è significativa: lei vuole parlare negli spazi dove le persone portano avanti le loro lotte quotidiane. E questo ha fatto sì che, nel tempo, il lavoro dell’Anw jigi art sia diventato una forma di attivismo culturale.
A volte rompere il silenzio può creare tensioni all’interno delle famiglie. Dopo aver assistito a rappresentazioni sul tema della violenza domestica, alcune donne trovano il coraggio di parlare e di denunciare. Non tutti gli uomini accolgono con favore questo cambiamento, perché stravolge norme consolidate, dettate dalla fede musulmana e da tradizioni radicate. Ma, nonostante le resistenze, Tangara e la sua compagnia non mollano.
Non tutti i temi possono essere affrontati facilmente negli spazi pubblici. L’artista ricorda un momento raggelante su un sotrama quando ha cominciato a parlare di stupro. «Al primo accenno è stato come se sul minibus non ci fosse più nessuno, anche se era strapieno. Prima avevamo parlato d’altro e le persone erano sembrate coinvolte e collaborative. Ma, nominato lo stupro, nessuno ha osato aprire bocca».
Tangara spiega che il Mali sta attraversando un periodo di crisi, con molte sfide da superare. «Come artista dovresti porti dei limiti quando tratti certi argomenti? Certo che no! C’è sempre un modo per affrontare le cose, bisogna solo scegliere il posto giusto. Dopo quel giorno nel sotrama abbiamo cambiato strategia».
Per rompere il silenzio che circonda il tema dello stupro, Tangara si è rivolta a un altro spazio di ascolto, alternativo e privilegiato: le tontine. Questi gruppi femminili esistono in quasi tutti i quartieri, posti di lavoro, famiglie o mercati, e servono a creare delle forme di risparmio collettivo, aiutando le donne a sostenersi a vicenda dal punto di vista economico. Allo stesso tempo offrono occasioni per parlare liberamente.
La nuova strategia di Tangara è stata sostenuta da un’emittente radio che è diventata partner dell’iniziativa per sapere perché nelle tontine si affrontasse un argomento tabù. Questo ha contribuito ad amplificare il progetto e a portare il tema dello stupro fuori dei circoli delle tontine e dei sotrama.
Anche se Tangara non si definisce un’attivista, il suo lavoro a sostegno dei diritti delle donne parla da sé. Solo la decisione di stabilirsi in un quartiere che non offriva nulla dal punto di vista culturale riflette la sua lotta e il suo impegno. Grazie a lei, l’Anw jigi art è diventata uno spazio di espressione per i giovani e un rifugio per le donne. I suoi spettacoli in bambara arrivano al cuore della comunità, permettendo alle voci dimenticate di essere ascoltate e alle ferite invisibili di guarire.
Dolci e macchine da cucire
Alla periferia di Bamako incontro una donna che sta ispezionando attentamente i dolci che ha preparato quella mattina stessa per gli ordini della giornata. Si muove con disinvoltura, come se lo facesse da una vita. Aminata, che ha circa trent’anni, è coinvolta nell’Anw jigi art fin dalla fondazione nel 2012. Oltre al teatro, l’associazione sostiene economicamente le ragazze che vogliono imparare un mestiere. Il sogno di Aminata è sempre stato diventare una pasticciera e, con quest’aiuto, le è bastato procurarsi la carta d’identità. Tutto il resto è stato fornito dall’associazione.
Oggi, con un diploma in mano, ha avviato una piccola attività di catering e ha assunto altre cinque donne che, a loro volta, sostengono le loro famiglie. «Prima non riuscivo a provvedere a me stessa. Ora sono indipendente», afferma con orgoglio. Ha anche cominciato a coltivare peperoncini in un piccolo appezzamento di terreno di sua proprietà e a trasformare i prodotti locali per venderli.
Il sostegno che ha ricevuto è andato ben oltre l’indipendenza finanziaria: frequentando l’Anw jigi art, la sua idea della famiglia, dell’istruzione e del ruolo delle donne è molto cambiata. «Prima, quando rimproveravo i miei figli, alzavo la voce. Ora non lo faccio più: mi prendo il tempo di parlare con loro e ascoltarli».
Aminata racconta come alcune rappresentazioni teatrali le abbiano aperto gli occhi, aiutandola a capire che non dovrebbero esserci discriminazioni di genere: «Prima mia figlia si occupava di tutte le faccende domestiche mentre i fratelli giocavano. Ora tutti condividono le incombenze, anche se alcuni vicini mi criticano per questo».
Aminata fa parte di una nuova generazione di donne che stanno rompendo con la tradizione e rifiutano di essere confinate al ruolo di casalinghe: «Un uomo da solo non può mantenere una famiglia. Ogni donna deve dare il suo contributo».
Poco lontano, in una casa silenziosa, un’altra donna, Fatoumata, spinge il pedale della sua macchina da cucire. Si avvicina un’importante festa religiosa e lei ha molti ordini in sospeso da consegnare. Anche la sua vita è cambiata. Madre di tre figli, trascorreva giornate monotone desiderando di lanciare un’attività che le garantisse un reddito. Poi, un giorno, la sorella di Assitan Tangara l’ha messa in contatto con l’associazione. Oggi è al terzo anno di formazione in sartoria e riesce a mantenersi. Confeziona abiti per i suoi familiari, guadagna un po’ di soldi e contribuisce alle spese domestiche. «Non dipendo più da mio marito per le piccole necessità della vita quotidiana. E lui è molto orgoglioso di me», dice sorridendo.
«Ho sempre creduto di dovermi limitare alla cura della casa e all’educazione dei figli. Ma ora so che posso fare di più», afferma con soddisfazione parlando del suo lavoro, che incuriosisce i suoi figli. «Quando mi vedono alla macchina da cucire, si avvicinano e vogliono copiare quello che faccio. Sono felice che anche mia figlia voglia imparare. Mi rassicura sapere che ha già capito di potersi costruire una professione e di non doversi limitare a fare solo ciò che ci si aspetta da lei».
L’associazione non si concentra soltanto sulle donne, ma anche sui bambini, che fin da piccoli si avvicinano all’arte attraverso la narrazione, il teatro, la scrittura e la scenografia.
Tangara ricorda un momento durante un workshop, quando un bambino di dieci anni, superando la timidezza, ha improvvisato una scena sui litigi in famiglia. «Perché i genitori ci sgridano sempre invece di spiegarci le cose?», ha chiesto davanti agli altri.
Quel giorno, con il suo coraggio ha rotto il silenzio, proprio come quando una bambina della stessa età ha inviato a Tangara un testo su sua madre, venditrice di ciambelle. «Mia madre è una regina per me: è coraggiosa come una leonessa», ha scritto con orgoglio la bambina.
In questo quartiere emarginato la pratica teatrale ha subìto una profonda trasformazione ed è diventata motivo di vanto. Grazie ai social media e all’incoraggiamento degli anziani, i giovani osano proclamare apertamente: «Siamo artisti».
Verità necessarie
Ritorno a Djalakorodji in un giorno di festa. Donne, giovani, rappresentanti delle istituzioni culturali, artiste e giornalisti si riuniscono nella sede dell’Anw jigi art sotto lo sguardo curioso dei bambini appollaiati sui tetti di lamiera, affascinati dalla magia del teatro.
Oggi sono in programma tre spettacoli per la cerimonia di chiusura del progetto Doni blon, noto anche come il “grande vestibolo della conoscenza”. La giornata segna il culmine di mesi di formazione per ragazzi e ragazze provenienti dalle scuole d’arte dei quartieri poveri, uniti da un unico obiettivo: raccontare la storia del Mali in un modo nuovo.
Nato dall’esigenza di crescere una nuova generazione di autrici e autori maliani, il programma ha visto la partecipazione di insegnanti del paese o di altre parti dell’Africa occidentale. È Moussa, un giovane regista, ad attirare la mia attenzione. Con un atteggiamento calmo, un tono misurato, ma parole che colpiscono nel profondo, presenta al pubblico due opere: una sulle devastazioni causate dalle sostanze stupefacenti tra i giovani, l’altra sulle ferite invisibili del divorzio. «Quando due persone divorziano, pensano solo a se stesse. Ma sono bambini e bambine a soffrire». È per loro che Moussa ha preso in mano la penna. Per trovare ispirazione, è andato per strada. «Ci immergiamo nei quartieri. Osserviamo. Le ragazze e i ragazzi navigano sui social media come se non avessero uno scopo, come se fossero tagliati fuori dal mondo… Alcuni pensano che sia figo. Ma cosa ne ricavano alla fine?».
Per Moussa il palcoscenico è il mondo intorno. Il suo lavoro non ha niente a che fare con la finzione. Per lui il teatro non è solo intrattenimento, ma uno spazio artistico per sensibilizzare e far riflettere: «Il teatro ti costringe a farti delle domande. Sono sulla strada giusta? Cosa devo cambiare?».
Come molti altri artisti dell’Anw jigi art, Moussa ha scelto un teatro di prossimità, immerso nella vita quotidiana. Per lui qualsiasi argomento può essere affrontato, purché lo si faccia con onestà e senza giri di parole. «Se abbiamo paura di toccare certi temi, allora abbiamo già fallito. La nostra missione avrà perso il suo significato», spiega.
La lotta che porta avanti non è solo culturale, ma anche sociale e politica. Tuttavia, come Tangara, anche lui rifiuta l’etichetta di attivista. «Sono un regista che dice verità necessarie, nei luoghi in cui devono essere dette».
Assitan Tangara trasforma i quartieri svantaggiati in una fonte d’ispirazione collaborando con artisti come Moussa. Il loro lavoro riflette la realtà sociale e crea uno spazio di espressione per gli invisibili, le cui voci raramente vengono ascoltate. Visti nel loro insieme, gli spettacoli dell’Anw jigi art fanno molto di più che fornire una speranza ai giovani, per quanto preziosa. Trasformano l’arte in dialogo, libertà ed emancipazione.
(Internazionale, 16 gennaio 2026)
Rileggere oggi due articoli di James W. Prescott (Body Pleasure and the Origins of Violence, 1975, e The Origins of Human Love and Violence, 1996) significa confrontarsi con una critica radicale a uno dei luoghi comuni più persistenti del pensiero occidentale: l’idea che la violenza sia inscritta nella natura umana.
La tesi di Prescott è netta: la violenza non è innata, ma nasce dalla mancanza di contatto, tenerezza e prossimità affettiva nei primi anni di vita. In altri termini, è il prodotto di un corpo che non è stato sufficientemente accolto. L’approccio dello psicologo dell’evoluzione colloca dunque l’origine della violenza sul piano corporeo e relazionale, prima ancora che su quello culturale o simbolico. È una proposta sorprendente, soprattutto perché formulata da un uomo, e che può essere ulteriormente arricchita dal pensiero della differenza sessuale, il quale introduce un elemento decisivo e spesso rimosso: il ruolo delle madri nella costruzione dell’essere umano.
Prescott mostra come il corpo sia, in primo luogo, un’eredità materna e come la qualità del contatto fisico nei primi mesi e anni di vita incida profondamente sulla futura capacità di relazione. Un bambino o una bambina toccati con dolcezza, ascoltati e accolti crescono con l’esperienza corporea che la prossimità è buona e che l’altro non è una minaccia. Al contrario, la carenza di contatto comunica al corpo che l’intimità è rischiosa, che la relazione espone, che la distanza protegge. Una tesi già innovatrice negli anni Settanta, che oggi dialoga con una consapevolezza più matura del ruolo materno come prima fonte di umanizzazione.
La madre è infatti la prima mediatrice del mondo: la prima pelle, la prima voce, la prima misura del desiderio e del limite. Non per una concezione essenzialista della biologia, ma per una realtà concreta e storica: nelle nostre società le madri continuano a sostenere la gran parte del lavoro di cura, spesso in solitudine. Sono loro, nella pratica quotidiana, a introdurre i figli e le figlie alla relazione con l’altro. Prescott lo suggerisce implicitamente; il pensiero della differenza sessuale lo esplicita: la relazione materna costituisce la prima grammatica del legame, il primo simbolo della differenza tra sé e l’altro.
Nei suoi lavori, Prescott rileva come gli uomini crescano spesso con una povertà affettiva e tattile strutturale, che li rende più vulnerabili alla frustrazione e più inclini a compensare la mancanza di relazione attraverso il dominio, il controllo e la forza. Tuttavia, è proprio qui che emergono i limiti del suo impianto teorico. In alcuni passaggi, infatti, l’autore scivola verso una colpevolizzazione implicita delle madri, senza interrogarsi a fondo sulla responsabilità maschile e paterna nella costruzione di questa deprivazione relazionale. È un punto in cui pesa l’orizzonte patriarcale da cui Prescott non riesce completamente a emanciparsi.
Il contributo più fecondo della sua ricerca resta però l’idea che la violenza derivi da un fallimento della relazione, non da un eccesso di aggressività naturale. Incrociando dati antropologici, psicologici e neuroscientifici, Prescott mostra come le società che negano il contatto corporeo ai bambini siano anche quelle caratterizzate da alti livelli di violenza interpersonale, guerra, gerarchie rigide e uso sistematico della punizione.
La violenza maschile contro le donne può allora essere letta come l’esito estremo, ma non inevitabile, di questa mancanza di relazione. È il segno di un’incapacità maschile di reggere l’alterità senza viverla come minaccia, di un’educazione che insegna a temere l’intimità e a trasformare la vulnerabilità in potere.
Questa lettura non assolve in alcun modo gli uomini autori di violenza. Ma, una volta chiarita questa premessa imprescindibile, l’intuizione di Prescott rimane preziosa: la prevenzione della violenza non può esaurirsi nelle politiche penali o nei dispositivi di protezione delle vittime. Deve cominciare molto prima, nella vita primaria, nei piccoli corpi, nella qualità delle relazioni quotidiane.
Non è accettabile, come accade in Prescott, attribuire alle madri una responsabilità che è invece collettiva e strutturale. Occorre piuttosto affermare con forza la responsabilità maschile e paterna nella cura dei neonati e degli infanti, e riconoscere alle madri un’autorità reale, politica e concreta, che passi attraverso i tempi del lavoro, i servizi di sostegno alla cura, il riconoscimento sociale della funzione materna, la fine della solitudine educativa.
Prescott ci ricorda che la pace è anche un sapere del corpo. Le madri questo sapere lo praticano da sempre, ma la cultura dominante non ha ancora imparato ad ascoltarlo. Se vogliamo una società almeno meno violenta, dobbiamo ripartire da qui: dalla differenza sessuale, dal corpo e dalla madre come prima e radicale fonte di relazione.
(www.libreriadelledonne.it, 15 gennaio 2026)
Crescendo a Gaza, ho imparato che per essere un uomo dovevo trattenere le lacrime, nascondere i tremiti e soffocare il dolore. Ma come potevo trattenere tutto questo quando tutto intorno a me era crollato?
Sono diventato uomo sotto i bombardamenti, in un mondo che raramente considera le vite di persone come me meritevoli di protezione o persino di cordoglio. Il genocidio israeliano in corso a Gaza non solo ha rubato la vita ai nostri familiari e vicini, ma ha anche sistematicamente smantellato e rimodellato il nostro senso di identità, comunità e personalità.
Fin da piccolo ho imparato che come uomo avrei dovuto proteggere, provvedere e rimanere saldo in qualsiasi circostanza. Ma fin dall’inizio ho capito che questo compito sarebbe stato completamente diverso per me rispetto a molti altri ragazzi in tutto il mondo.
Avevo nove anni la prima volta che sono sopravvissuto a un attacco aereo. Stavo andando a scuola quando una bomba ha squarciato la strada su cui camminavo con i miei compagni di classe. Quando la cenere e la polvere si sono diradate, sono corso a casa superando i miei compagni di classe, alcuni dei quali erano già morti, altri urlavano, privi di arti.
Quando finalmente sono arrivato a casa, tutta la mia famiglia stava piangendo. Ricordo distintamente di aver guardato mia madre tremante e di aver detto qualcosa di troppo grande per un bambino: «Mamma, sono un uomo. Nessuno dovrebbe piangere per me». Con una certezza che solo un bambino è in grado di avere, ho aggiunto: «So come sfuggire alla morte».
Da quel momento, sono sopravvissuto a più di dieci attacchi. Ma ora, all’età di ventisei anni, e dopo quasi due anni di questo genocidio, mi sono reso conto che lo stoicismo e la fermezza richiesti agli uomini palestinesi sono quasi impossibili.
Come posso essere un “protettore” quando i jet da combattimento riducono la mia casa in macerie, i droni in volo ci privano del sonno e lo sfollamento forzato diventa l’unica garanzia? Come posso “provvedere” quando il blocco israeliano durato diciotto anni ha decimato la nostra economia, il suo assedio intensificato continua a farci morire di fame e avvicinarsi a un camion degli aiuti significa rischiare la morte?
Ho perso mio fratello Nour in questo caos. Era un agente di polizia dedito alla sicurezza dei civili. È scomparso durante il bombardamento israeliano di Khan Younis. La mia famiglia ancora non sa cosa gli sia successo.
Nella cultura gazawi, il nostro senso di virilità è legato alla responsabilità verso la famiglia. L’assenza di Nour non solo ci ha spezzato il cuore, ma ha anche frantumato l’immagine che avevo di me stesso: il fratello maggiore, la guida, il protettore. Ma come uomo, responsabile di sfamare i miei dieci fratelli, non ho avuto il tempo nemmeno di iniziare a elaborare quel dolore.
Un giorno, mentre mi allontanavo dalla nostra tenda, la mia sorella più piccola mi ha chiesto dove sia Nour. Non posso mentirle di nuovo, ma non posso nemmeno distruggere la piccola speranza che ha costruito. Raccolgo pezzi di legno e metallo rotto, fingendo che servano per il fuoco o per ricostruire, quando in realtà sto solo tenendo le mani occupate per evitare che il mio cuore esploda.
Ogni notte seppellisco Nour nei miei pensieri e ogni mattina lo riporto in vita nei miei ricordi. Quando non ci sono bombardamenti, mi siedo in riva al mare, ai confini di Gaza, dove l’acqua è libera anche se noi non lo siamo, e mi lascio andare al pianto senza emettere alcun suono.
È così che elaboro il genocidio: in silenzio, di nascosto, a pezzi. Non posso urlare davanti a mia madre. Non posso crollare davanti a mio padre. Sono il loro figlio e ai loro occhi sono ancora il loro scudo, anche se dentro di me mi sento distrutto.
Ma non sono solo. Il danno emotivo subito dagli uomini palestinesi è incalcolabile. Un rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione del 2022 sugli uomini nelle zone di conflitto ha messo in guardia dal “doppio trauma”: il dolore fisico e psicologico aggravato dalle aspettative sociali che esigono silenzio, stoicismo e soppressione emotiva.
A Gaza, dove l’assistenza sanitaria mentale è quasi inesistente e lo stigma rimane elevato, gli uomini interiorizzano tutto. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità precedenti alla guerra indicavano solo 0,2 psichiatri ogni 100.000 persone. Il poco sostegno alla salute mentale che avevamo un tempo è sepolto sotto le macerie.
Eppure, nonostante le circostanze inimmaginabili, continuo a testimoniare la tenerezza degli uomini che sostengono la sopravvivenza delle loro famiglie.
«Ho tenuto mia figlia in braccio tutta la notte dopo che la pioggia ha distrutto la nostra tenda», mi ha raccontato Mahmoud, un padre che ho intervistato in un campo vicino a Rafah. «Dovrei essere il suo scudo, ma ero bagnato fradicio e impotente». La sua voce si è incrinata.
Quell’incrinatura era sfida, non debolezza. Lasciando che la sua voce tremasse, lasciando che qualcuno fosse testimone del suo dolore, stava rifiutando l’aspettativa che gli uomini palestinesi debbano essere sempre stoici. Stiamo iniziando a rivelare le nostre crepe gli uni agli altri.
Ibrahim Abu Naji, padre di quattro ragazzi, ha condiviso qualcosa che mi ha colpito nel profondo: «Essere un uomo a Gaza in questo momento significa scegliere di rimanere affamati piuttosto che partecipare alla corsa per il cibo che arriva sui camion degli aiuti».
Si riferiva alle scene che si sono verificate in tutta Gaza negli ultimi mesi, dove, a causa dell’assedio paralizzante di Israele, folle affamate di palestinesi si precipitano disperatamente verso i camion che trasportano cibo per afferrare tutto ciò che possono. Israele ha successivamente sfruttato queste scene di caos per giustificare la chiusura di tutte le operazioni di aiuto internazionale a Gaza, prima di istituire un proprio meccanismo di distribuzione degli aiuti che funge da veicolo per la pulizia etnica.
Prima del 7 ottobre, Abu Naji lavorava nell’edilizia in Israele, ma dall’inizio della guerra ha perso ogni fonte di reddito. «La mia fame diventa una forma di protesta», mi ha detto. «Non li aiuterò a distruggere quel poco di dignità che ci è rimasta».
In arabo, la parola che descrive più da vicino la virilità non è la traduzione letterale, rujula, ma karama, ovvero “dignità”. Nonostante la deliberata disumanizzazione del nostro popolo e la svirilizzazione dei nostri uomini, Gaza sta dando vita a un nuovo tipo di mascolinità: non basata sul militarismo, ma sulla chiarezza morale e sulla dignità, anche nella fame. Nonostante i continui bombardamenti, ricostruiamo le nostre tende e le nostre vite più e più volte.
Nelle mie interviste con altri uomini sfollati, sono emersi nuovi modelli di virilità. «Essere un uomo significa mantenere i miei figli calmi quando sono terrorizzati dal cielo», mi ha detto Abu Omar, trentasette anni. Un altro ha spiegato: «Pensavo di dover essere sempre forte. Ma ora mi lascio andare alle lacrime e lascio che mio figlio mi veda piangere».
Lasciando che i propri figli vedano il loro dolore, la loro paura e la loro debolezza, i padri dimostrano la loro vera forza. Le nostre lacrime non sono un segno di debolezza, ma un atto di ribellione in un mondo che cerca di schiacciare la nostra umanità. Le nostre emozioni e la nostra riluttanza a diventare insensibili a questo dolore sono una forma di resistenza.
Questi momenti rivelano qualcosa che raramente si vede nei servizi giornalistici internazionali: dietro le immagini dei militanti o delle vittime ricoperte di macerie ci sono uomini intrappolati tra il genocidio e il peso di dover sostenere una concezione ereditaria della mascolinità. I media globali spesso riducono gli uomini palestinesi a stereotipi – minacce o statistiche – privandoci della nostra complessità e umanità.
Eppure, tra le rovine, sta prendendo forma qualcos’altro.
Oggi a Gaza sta emergendo una mascolinità diversa, che abbraccia la vulnerabilità, la cura e la tenerezza. Gli uomini cucinano pasti in rifugi affollati, confortano i bambini, piangono apertamente mentre stringono i corpi senza vita dei loro nipoti e raccontano storie di dolore.
Stiamo iniziando a dare un nome ai nostri traumi ad alta voce. E questa trasformazione non è apolitica, è un atto di sfida.
Nonostante il nostro dolore, gli uomini continuano a portare il peso di correre dei rischi, attraversando i bombardamenti per procurarsi acqua o cibo, perché è troppo pericoloso per le donne o i bambini farlo. Ma ora, essere un uomo non significa solo essere forti, significa essere presenti. Essere l’uomo che piange e continua a rischiare la vita per procurarsi i beni di prima necessità, che porta sia l’acqua che il dolore.
Questa è la nuova mascolinità che stiamo costruendo qui. Una mascolinità che non riguarda solo la sopravvivenza, ma anche il rimanere umani. Uomini che piangono in pubblico, che cambiano i pannolini nelle tende, che condividono il dolore con estranei: questi uomini stanno forgiando un nuovo tipo di mascolinità, che rifiuta il dominio e abbraccia la cura.
Ricostruire le nostre identità distrutte richiederà generazioni. Ma rivendicare ciò che significa essere un uomo – gentile, spezzato, in via di guarigione e ancora in piedi – è un inizio.
Gli uomini palestinesi meritano di essere visti non come militanti o ombre, ma come persone complete con cuori fragili e fardelli impossibili. Porre fine all’occupazione non significa solo restituire la terra, ma anche restituire la dignità. Ciò significa ricostruire le case, riparare ciò che si è spezzato dentro di noi e reimmaginare come presentarci a noi stessi e agli altri.
Gaza, 30 giugno 2025
Abdallah Aljazzar è un palestinese gazawi. Attualmente sta studiando per un master alla Maynooth University in Irlanda, dove è coordinatore del programma per gli studenti palestinesi provenienti da Gaza.
(+972 magazine, 30 giugno 2025)
Dialogo con un’analista iraniana, anonima per motivi di sicurezza: «La composizione sociale in termini di classe, etnia e generazione è più eterogenea rispetto a Donna Vita Libertà per la natura intersezionale delle istanze rivendicate. I monarchici stanno operando una sofisticata manipolazione, ma nel paese non hanno consenso»
Di quanto sta avvenendo in Iran abbiamo parlato con una analista e scienziata politica iraniana, residente all’estero, che per motivi di sicurezza chiede di restare anonima.
Che notizie le giungono, nonostante il blocco di internet?
Il blackout informativo senza precedenti imposto dall’8 gennaio ha reso quasi impossibile reperire informazioni attendibili. Nonostante ciò, i social media sono riusciti a diffondere video e immagini delle proteste, anche se verificarne l’attendibilità è arduo. Da stamattina [ieri, ndr] alcuni iraniani sono riusciti a effettuare brevi telefonate all’estero: uno spiraglio di speranza che le comunicazioni potrebbero riprendere. Le notizie che mi sono giunte confermano ciò che sospettiamo: un contatto ha definito la repressione un vero e proprio “genocidio”. Le immagini delle famiglie assiepate negli obitori per riconoscere i propri cari hanno fatto il giro del mondo. L’atmosfera di Teheran mi è descritta come pesantemente militarizzata e securizzata, le persone che devono lavorare continuano una parvenza di normalità, ma le strade sono ogni giorno ingorgate dal traffico di chi non vuole ritrovarsi fuori al calar del sole. Mi è giunta anche voce di un calo apparente dell’intensità delle manifestazioni, giustificata dalla brutalità della repressione. Ma si tratta di informazioni inevitabilmente parziali.
L’attuale mobilitazione giunge ad appena tre anni dallo scoppio di Donna Vita Libertà e dopo vent’anni di proteste cicliche. Quanto le mobilitazioni precedenti hanno influito?
È difficile operare una distinzione netta tra motivazioni e istanze economiche e politiche, e non sono convinta che sia corretto farlo; riuscire a comprare il pane o permettersi un affitto è una questione estremamente politica. La società iraniana si trova in un ampio ciclo di mobilitazioni strutturali, non dobbiamo dimenticare quelle del 2017 e del 2019. Se diversi anni fa esitavo a definire le diverse proteste come strutturalmente antiregime, dal 2022 non sembra esserci dubbio: la caduta della Repubblica islamica è ormai un nodo centrale. Mi rattrista sentire da più fonti che gli slogan legati a Donna Vita Libertà abbiano subito una marginalizzazione: le proteste successive alla morte di Jina Mahsa Amini erano fortemente segnate da istanze femministe e progressiste, hanno contribuito alla nascita di un nuovo immaginario politico e sociale, la cui eredità oggi è meno evidente. Occorre interrogarsi su quali elementi le stanno oscurando.
La mobilitazione è mossa da speranza di cambiamento? O al contrario, dalla perdita delle illusioni?
Se per speranza di cambiamento intendiamo la fiducia nel riformismo interno, questa si è estremamente indebolita negli ultimi anni. La situazione economica disastrosa è sicuramente fonte di profonda disillusione e rabbia. Non vedo per ora quegli immaginari e slanci creativi che avevano distinto mobilitazioni precedenti.
Chi sono le persone nelle piazze? Si parla di background politici diversi, età diverse, classi sociali diverse.
Questo nuovo ciclo di proteste ha preso il via da soggettività spesso marginalizzate nelle rappresentazioni internazionali, ossia i lavoratori del bazar e i piccoli commercianti. C’è stata poi un’espansione della composizione sociale in termini di classe, generazione ed etnia, più eterogenea rispetto al 2022. Alcune province e popolazioni tradizionalmente poco presenti, come curdi e azeri, si sono mobilitate, a dimostrazione della natura intersezionale delle manifestazioni e delle istanze rivendicate. È un elemento sorprendente solo per chi conosce l’Iran esclusivamente attraverso le lenti della borghesia urbana: queste minoranze sono oggetto di repressione e sorveglianza da decenni e hanno subito in modo drammatico l’ulteriore involuzione autoritaria degli ultimi anni.
E poi c’è il ruolo delle opposizioni all’estero, per lo più quelle monarchiche, che guardano con favore a un eventuale intervento Usa. Che consenso hanno tra la popolazione?
Mai come ora il ruolo e il potere delle opposizioni all’estero sono stati così dibattuti. La famiglia Pahlavi sta investendo enormemente in una propaganda che la legittimi come unica alternativa democratica. Reza Pahlavi si è ripetutamente proposto come figura di riferimento per un periodo di transizione post-Repubblica islamica. Un’artista iraniana ha definito quella dei Pahlavi una «sofisticata manipolazione mediatica»: secondo diverse fonti, circolano video modificati con l’intelligenza artificiale per gonfiare il supporto monarchico interno. In molti esprimiamo forti perplessità per via dei suoi stretti legami con la destra repubblicana statunitense e Israele, evidenti nel suo supporto dei raid israeliani dello scorso giugno. Come molti analisti iraniani hanno commentato, il sostegno a questa opposizione è più forte e rumoroso soprattutto nella diaspora, residente in maggioranza negli Stati uniti, e trova meno risonanza nelle piazze iraniane.
(il manifesto, 14 gennaio 2026)
Un attimo prima di essere uccisa a Minneapolis, non tradiva né paura, né soggezione ed è questa indifferenza un affronto intollerabile per l’agente dell’Ice. E per Trump
«Gli uomini temono che le donne ridano di loro. Le donne temono che gli uomini le uccidano», scriveva Margaret Atwood in Second Words. Sono queste le parole più calzanti per descrivere l’omicidio di Renee Nicole Good da parte di un agente dell’Ice.
È stato il video filmato dal telefono dell’agente Jonathan Ross a restituire con chiarezza la sequenza degli eventi. Mostra, da un lato, Renee Good, donna bianca con cittadinanza statunitense che operava come osservatrice legale per monitorare i raid dell’Ice. Dall’altro, gli agenti dell’agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione. Il video riprende Good all’interno della sua auto, intenta in una conversazione leggera con la moglie Becca, mentre il cane siede nel sedile posteriore e i peluche del figlio sono in quello anteriore. «Guida, amore, guida», le sussurra la moglie mentre chiude la portiera dell’auto e Renee Good si rivolge all’agente sorridendo, «Amico, non ce l’ho con te». Qui, da fuoricampo, la voce di un agente le intima di scendere dall’auto.
«Fuori dall’auto. Fuori dall’auto. Fuori dalla cazzo di auto». Poi, il rumore di tre colpi di pistola. L’inesorabile schianto dell’auto di Good quando questa perde conoscenza. Le parole di Ross «Fottuta stronza» chiudono una scena in cui si alternano l’ironia delicata delle donne e la violenza degli agenti.
Negli ultimi giorni, questo video ha suscitato sconcerto e cordoglio in tutto il mondo. Ice out for Good (‘Ice fuori per sempre’, ‘Ice fuori per Renee Good’), ben riassume il sentimento prevalente nelle piazze, unite dalla richiesta di espellere l’Ice dalle città. Negli ultimi mesi, l’Ice ha ricevuto dall’amministrazione Trump finanziamenti superiori a quello di interi eserciti. Ha fatto raid e rastrellamenti su larga scala, oltre a settantamila arresti, la maggior parte dei quali persone incensurate. In questo quadro, una sola domanda non trova risposta adeguata: perché?
Kate Manne, filosofa politica e autrice di Down Girl. The Logic of Misoginy l’ha detto nel modo più chiaro. «È un caso di misoginia e di fascismo in azione», che emerge «con una chiarezza nauseante, prevedibile e tuttavia moralmente sconvolgente». In questo quadro, il tono disinvolto di Good è vissuto dall’agente come un oltraggio. «La rabbia che le donne suscitano quando mettono in discussione figure maschili di autorità», scrive Manne, «è un esempio archetipico di una dinamica di genere che ignoriamo a nostro rischio e pericolo». In questo quadro, la misoginia non va intesa banalmente come ostilità nei confronti delle donne. È la punizione che spetta a chi disconosce l’ordine patriarcale.
Subito dopo i fatti, Donald Trump ha definito Good come una «terrorista interna», che «guidava in modo turbolento», «ostacolava e opponeva resistenza», sino a costringere l’agente a sparare per legittima difesa. L’evidente discrasia tra le parole di Trump e i fatti è stata descritta come simbolo della post-verità, il modo con cui l’amministrazione Trump distorce la realtà per proteggere la propria legittimità politica. Le parole di Trump, tuttavia, potrebbero descrivere a un tempo i fatti in modo distorto e il suo sguardo in modo fedele. Potrebbero essere, in altre parole, false ai nostri occhi e vere ai suoi.
A partire dal testo classico di Richard Hofstadter Lo stile paranoide nella politica americana, la letteratura ha mostrato come la personalità autoritaria tenda a confondere le cause e gli effetti, i carnefici con le vittime, sino a sentirsi al centro di uno stato d’assedio con il compito di salvare la civiltà. In questo quadro, lo stato d’assedio descrive il timore che la gloria imperiale soccomba alle forze ataviche che la minacciano.
Prima ancora di essere falsa, la proiezione paranoica è una spettacolare messa in scena del mondo fantasmagorico della personalità autoritaria, ossessionata dalla paura che tutte le forze che le sono state subordinate si rivolteranno.
In questo quadro, non sorprende che l’omicidio di Renee Nicole Good sia stato interpretato, da alcuni, come un femminicidio perché il suo scherno è stato percepito come un oltraggio. Lo scopo della misoginia è usare premi e punizioni per educare le donne a essere deferenti nei confronti dell’autorità. Good non tradiva sottomissione, né paura, né soggezione, ed è proprio questa indifferenza a costituire un affronto intollerabile. Le donne e le persone migranti pagano ogni giorno il prezzo di un disciplinamento mai richiesto. Ed è tragico che questo diventi scandaloso solo quando diventa letale.
(il manifesto, 14 gennaio 2026)
In libreria “Safaa e la tenda”, Fandango editore, gennaio 2026
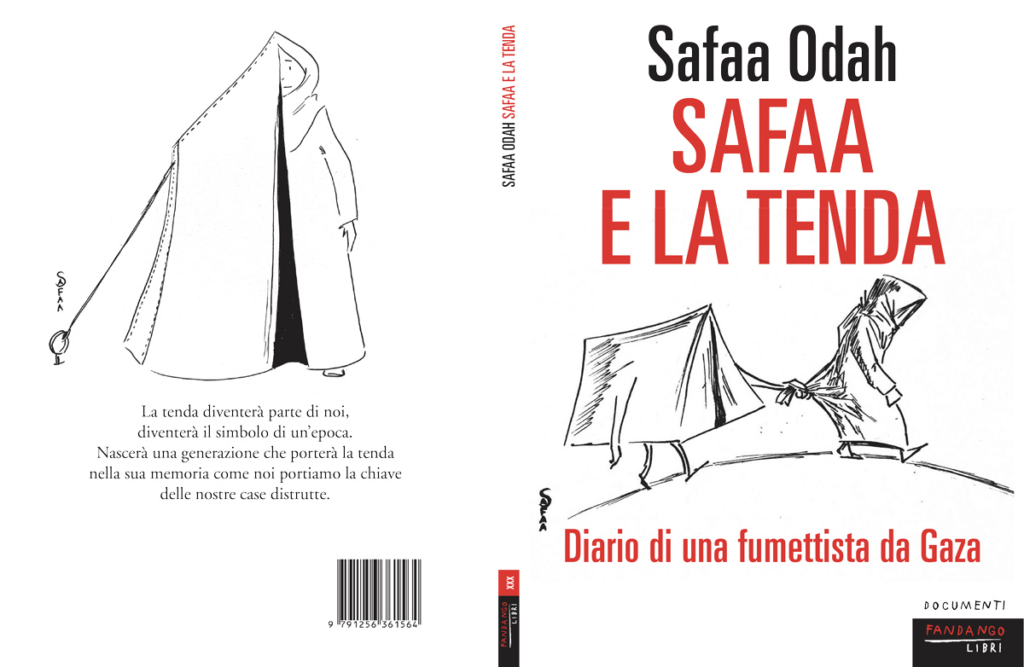
Dopo il 7 ottobre 2023, la fumettista di Gaza Safaa Odah è stata sfollata più volte, ma dal campo profughi di Al-Mawasi continua a disegnare, usando le pareti della tenda quando la carta finisce. «La tenda diventerà parte di noi, diventerà il simbolo di un’epoca. Nascerà una generazione che porterà la tenda nella sua memoria come noi portiamo la chiave delle nostre case distrutte», scrive sotto un disegno. Safaa racconta due anni di genocidio attraverso immagini straordinarie dal tratto essenziale, cogliendo il dolore e la resistenza del popolo palestinese nei dettagli della vita quotidiana, e intrecciando emozioni diverse, sguardo femminista, senso dell’umorismo, forza della controinformazione. Con un tratto morbido ritrae l’inferno di Gaza per metterne in luce l’aspetto semplicemente umano, capace di parlare a tutte e tutti noi. «Una telecamera da sola non riesce a catturare abbastanza bene quello che sta succedendo, mentre il disegno può aiutare a mostrarlo», dichiara. Fandango Libri raccoglie le opere realizzate da Safaa Odah tra ottobre 2023 e dicembre 2025, insieme a una postfazione di Pat Carra con intervista all’autrice.
Nata nel 1984 a Rafah nella Striscia di Gaza, Safaa Odah è una fumettista e artista dell’animazione, con un master in psicologia. Nel 2025 ha ricevuto lo Special Award di LICAF (Lakes International Comic Art Festival) per Safaa and the Tent 2023/2024, di cui il libro italiano è l’edizione estesa 2023/2025. Ha un grande seguito sulle sue pagine social e pubblica su giornali arabi, tra cui Al-Araby Al-Jadeed,e in Italia sulla rivista Erbacce, nella rubrica “Una tenda in Palestina”.
(Erbacce, 12 gennaio 2026)

Questo è l’elogio incondizionato di una sindaca socialista. Una razza politica scomparsa, di cui lei è stata rappresentazione esemplare. Si chiamava Francesca Arnaboldi [deceduta il 3 gennaio 2026, Ndr]. Insegnante, originaria della civiltà delle cascine lombarde, giunse a Buccinasco quando ancora era un paese di poche migliaia di abitanti alle porte di Milano. Fece politica da giovane con il Partito Socialista con cui venne eletta sindaca nel 1983. Allora i sindaci donne erano quasi anomalie. In quel ruolo fece molte cose buone, perché infine il riformismo non è sempre stata una parola vuota. I famosi orti di Buccinasco, l’integrazione dei nomadi, una biblioteca d’avanguardia, l’attenzione agli anziani, uno sviluppo armonico del territorio in un comune che cresceva vorticosamente. Villette, case popolari, servizi sociali, verde. E tuttavia io non la conobbi in quegli anni per le cose buone che stava facendo. Ma perché un giorno – era la seconda metà degli anni ’80 – mi chiamò lei, chiedendomi di andare a Buccinasco. Parlammo a tu per tu in piedi, se ricordo bene. Ricordo con certezza una signora di cui mi colpirono l’eleganza dei modi e la cultura politica. Venne quasi subito al dunque. A Buccinasco succedono cose strane, che non mi piacciono, disse. In paese c’è la mafia ed è anche influente. Qui hanno paura. Devo essere sincero: restai un po’ perplesso. Ero stato da poco travolto dai delitti eccellenti palermitani, dalla mafia che da Palermo andava all’assalto dello Stato. E ora questa donna mi parlava di mafia accanto a Milano, città che giudicavo il mio rifugio, ancora abissalmente lontano da certi scenari. Anzi, proprio a Buccinasco ero stato invitato per cerimonie o dibattiti pubblicamente promossi per ricordare mio padre. Certo, anche io denunciavo allora una presenza dei clan nella vita milanese. Ma erano quelli siciliani. Lei parlava dei calabresi, e non come degli infiltrati, ma proprio come se le contendessero la guida del paese. Me ne andai temendo di non avere capito bene, e anche il sospetto che la sindaca avesse esagerato per poca conoscenza delle cose. Invece le cose le conosceva benissimo. E me le insegnò. A Buccinasco dagli anni ’70 si erano insediati i clan di Platì, tanto da fare ribattezzare in pochi anni il comune “la Platì del Nord”. Papalia, Barbaro, Sergi, ecc: tutti cognomi che si sarebbero sposati a un’epoca in cui quei comuni dell’hinterland sud milanese sarebbero stati teatro di sequestri di persona e di narcotraffico galoppante, e anche di un po’ di omicidi. I clan di Platì volevano prendere le redini dell’economia locale partendo dall’edilizia. Lei si opponeva, senza proclami e senza scorte. Finché un giorno uno dei Papalia (sic!) le annunciò in pubblico che non aveva più la maggioranza in consiglio comunale. Fu così. Poche sere dopo il consiglio votò contro di lei e per il piano regolatore di Papalia. Dovette dare le dimissioni. Continuò a partecipare alla vita di Buccinasco dando una mano dall’esterno a chi – di volta in volta – volesse portare un po’ d’aria nuova contro l’egemonia dei “calabresi” che subirono i primi colpi giudiziari agli inizi del decennio successivo. Insomma, Francesca Arnaboldi non fece finta di non vedere, non chiese «Ma che cosa posso fare, mica sono un poliziotto», non cercò un punto di compromesso, non andò a pranzo né incontrò per interposta persona. Cercò anzi di far sapere agli increduli. E mi domando che cosa sarebbe mai oggi la Lombardia se tutti i sindaci susseguitisi nei decenni avessero fatto come lei. Purtroppo così non è stato. Peccato, davvero peccato che il saluto che il Comune le ha tributato non faccia cenno di tutto questo, di ciò che l’ha resa fulgidamente diversa nella storia del Nord così bisognoso di difensori e così facilmente colonizzato. Sia reso onore invece – proprio per questo – a Francesca Arnaboldi, la sindaca socialista del tempo che fu.
(Il Fatto Quotidiano, 12 gennaio 2026)
«Non mi rallegro per i dati sull’occupazione e nemmeno il governo dovrebbe»: Marcella Corsi, ordinaria di Economia politica presso l’università La Sapienza di Roma, tra le fondatrici della rivista inGenere.it e presidente della International association for feminist economics (Iaffe), analizza i dati sull’economia italiana a partire dalla conferenza stampa di inizio anno della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Nel racconto della presidente del consiglio, l’Italia è economicamente stabile, con gli indicatori in ripresa, la crisi di settori importanti colpa dell’Ue.
Questa descrizione corrisponde alla situazione del Paese?
Una premessa: viviamo una crisi multipla con effetti devastanti sul piano occupazionale. La crisi del 2008 aveva colpito soprattutto l’occupazione maschile, perché nasceva nel settore abitativo e nei mutui. Le donne spesso sono diventate le uniche a portare un reddito in famiglia con lavori a bassa qualifica, malpagati, fragili dal punto di vista contrattuale. La crisi pandemica del 2019 ha stroncato l’occupazione proprio in quei settori in cui erano concentrate le donne. Ora ci troviamo di fronte a uno scarso recupero dell’occupazione maschile e a una lenta ripresa in settori ad alta concentrazione femminile, come il commercio o l’abbigliamento, perché la pandemia ha messo in crisi soprattutto i consumi. Quindi a una crisi sistemica legata alla carenza di investimenti si è aggiunta quella legata alla carenza di consumi. Una situazione di grande difficoltà che non riguarda solo l’Italia ma tutto il resto del mondo, salvo rarissime eccezioni, come la Cina, che però si è concentrata solo sugli investimenti.
Come se ne esce?
Con delle riforme strutturali importanti. Per esempio, restituendo allo Stato un ruolo fondamentale di protezione del lavoro. Se il settore privato non riesce a creare occupazione e soprattutto non riesce a creare lavoro di qualità, protetto e con salari decenti, dovrebbe essere lo Stato a intervenire in modo rigoroso. Un grande economista del passato, Hyman Minsky, parlava dello stato come employer of last resort [‘datore di lavoro in ultima risorsa’, Ndr]. Le sue teorie sono valide anche oggi, a mio modo di vedere.
Il governo Meloni è su questa strada?
Ovviamente no. Temo che non abbia neanche utilizzato al meglio i fondi del Pnrr. È presto per fare un bilancio perché gli effetti del piano finiranno nel 2026 e poi bisognerà aspettare almeno uno o due anni per la valutazione di impatto. Ma da quello che si vede non sembra che ci sia stata una spinta propulsiva così importante; la spesa straordinaria sembra avere favorito più la resilienza che la ripresa.
La presidente del consiglio non ha mai fatto riferimento alla povertà durante la conferenza stampa.
L’impoverimento delle famiglie italiane è reale, è un po’ l’effetto complessivo di quei fenomeni che citavamo sopra. Ce lo indicano Caritas, Istat, Oxfam: chi non lo vuole vedere lo fa per motivi politici, non perché i dati non siano chiari.
Meloni esulta perché il numero dei disoccupati secondo l’Istat sarebbe sceso al minimo storico e sarebbero cresciute le donne con un impiego.
Quei dati sono veri ma spesso citati male. L’occupazione femminile in Italia resta sempre più bassa della media Ue, i tassi di inattività non migliorano, quindi direi che ci si premia senza motivo. A crescere sono i lavori di bassa qualità, tipicamente femminilizzati, cioè che riguardano non solo le donne ma soggetti vulnerabili come i migranti e i giovani. Si tratta di una segregazione
occupazionale in determinati settori a bassi salari e caratterizzati da precarietà. Questa situazione non mi rallegra affatto e non credo che il governo dovrebbe rallegrarsene.
Quali sono i nodi da sciogliere?
L’assenza di investimenti strutturali da un lato, e la mancanza dell’impulso dello Stato nella creazione di welfare e di occupazione di qualità. Annaspiamo nel tentativo di rimanere a galla e non vedo migliorie all’orizzonte.
A cosa è dovuto il suo pessimismo?
Metto in fila: una manovra tra le più basse della nostra storia. Se è vero che abbiamo avuto un qualche segnale di allentamento sul piano della sostenibilità del disavanzo e del debito, questo è funzionale principalmente alla crescita della spesa militare, una spesa che non crea sviluppo, non garantisce una ripresa generalizzata dell’occupazione perché coinvolge solo alcune realtà regionali e determinate manifatture. Tutto questo mentre si impoveriscono ulteriormente i servizi essenziali, come l’istruzione, la sanità, la ricerca e, a livello internazionale, aumentano le guerre.
Non esiste un’alternativa?
C’è bisogno di adottare un paradigma economico differente: noi economiste femministe parliamo di “rivoluzione della cura” intesa in primis come “preoccuparsi per il mondo”, ovvero un modo diverso di concepire le relazioni tra gli agenti economici, alternativo al mercato e in grado di garantire il benessere per tutti e tutte. Sembra utopistico ma diverse pratiche in giro per il mondo hanno dimostrato che così non è.
(il manifesto, 12 gennaio 2026)
È difficile scrivere su Simone Weil. Molto è stato scritto su di lei in varie lingue, ma forse più intrigante è il fatto che Simone Weil ha spesso indotto a gettare il cuore oltre l’ostacolo, a farsi ispirare nella propria attività di pensiero e di scrittura dal suo irripetibile modo di essere. Ciò è accaduto a scrittrici come Ingeborg Bachmann, Elsa Morante, Cristina Campo, per citare solo alcuni nomi. Viene da pensare che scrivere su Simone Weil dovrebbe assomigliare a ciò che lei affermava a proposito della filosofia: «cosa esclusivamente in atto e pratica. Per questo è tanto difficile scrivere al riguardo, difficile così come un trattato di tennis o di corsa a piedi, ma in misura superiore» (Quaderni IV, p. 396, Adelphi 1993).
La raccolta di saggi curata da Isabella Adinolfi, Necessità e Bene Intorno al pensiero di Simone Weil (il melangolo, pp. 350, euro 28,00), è dedicata a Giancarlo Gaeta, uno dei principali studiosi italiani dell’opera di Simone Weil al quale dobbiamo la traduzione dei Quaderni e un’instancabile riflessione sul suo pensiero. Nel saggio dello stesso Gaeta che apre il volume, Il testamento politico di Simone Weil, troviamo la conferma del fatto che scrivere su di lei non può essere che «cosa in atto e in pratica». Gaeta racconta di aver riletto alcune pagine di La prima radice, l’ultima opera di Simone Weil pubblicata postuma nel 1949 da Albert Camus, su suggerimento di un amico pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina. E commenta: «Sono rimasto anch’io preso dalla lettura di quelle pagine e me ne è venuta l’impressione di non aver mai letto davvero l’opera di cui sono parte». Quel come se non avessi mai letto davvero pagine che sicuramente gli erano note ha la forza di una scossa.
Gaeta ha più volte ribadito il rifiuto di un’attualizzazione del pensiero di Simone Weil e allude a qualcosa di molto diverso, alla «vera attualità, quella cioè che racchiude in sé tutte le attualità», come l’ha chiamata Ingeborg Bachmann nel suo saggio radiofonico del ’55 (La sventura e l’amore di Dio. Il cammino di Simone Weil, in Il dicibile e l’indicibile, Adelphi 1998, p. 116). La sua nuova lettura di un testo «rimasto politicamente lettera morta» parla dello «scarto» dell’ultimo pensiero politico weiliano, del suo «scorgere nella tragica vicenda in corso ciò che ben pochi furono disposti a vedere». E definisce la consapevolezza di Simone Weil rimasta estranea ai suoi diretti interlocutori con le parole di Patrice Rolland: «Il fallimento della civiltà europea reso manifesto dalla ripetizione di due guerre mondiali richiede un giudizio ‘religioso’ o ‘spirituale’». Gaeta suggerisce di leggere quello scritto, che si presenta come un «flusso ininterrotto di scrittura», come una «sinfonia mahleriana: una sequenza di temi e motivi che si sommano e s’intrecciano, cosicché sta all’orecchio di ciascun lettore cogliere i passaggi, gli stacchi, le riprese». E conclude che bisogna accettarne l’«incompiutezza», l’«arresto brusco che non acquieta in una conclusione e dice comunque a qual punto l’esistenza dell’autrice vi fosse implicata». Aggiungerei «a qual punto» l’esistenza di ciascuno di noi dovrebbe esserne implicata.
La scossa sperimentata da Gaeta ha una notevole forza di propagazione nella raccolta di saggi curata da Isabella Adinolfi. Il volume si chiude con un saggio di Maria Concetta Sala, studiosa, traduttrice e curatrice di testi weiliani, dedicato al «farsi orecchio», alla pratica di ascolto delle «voci dell’esperienza» di Svetlana Aleksievič. In appendice si può anche leggere la sceneggiatura del film di Serena Nono, Sventura. L’inferno di Jaffier (2019), sequel di Venezia salva (2011-’12). La regista è anche pittrice e sulla copertina del libro c’è un suo ritratto di Simone Weil (2001).
Adinolfi, profonda conoscitrice di Simone Weil, ha scelto di intitolare il libro Necessità e Bene, termini che indicano i due bracci della Croce (immagine chiave dell’universo weiliano) che si incontrano in un punto, quello di ogni fragile e sventurato essere umano. Nel saggio introduttivo spiega la sua scelta come il frutto della ricerca di un fulcro, di una chiave di lettura in grado di cogliere il movimento di un pensiero che si articola su una molteplicità di piani e di prospettive e si alimenta di una pratica di traduzione di Omero, Sofocle, Eschilo, di amore per la poesia, di letture di Platone, del Vangelo, della Bhagavadgītā. La relazione tra Necessità (la «spietata regolarità dell’ordine del mondo») e Bene (l’amore di Dio) attraversa l’intero pensiero weiliano e si collega al «grande enigma» della sventura umana nella forma, a un tempo, di contraddizione insolubile, e di «fragile passaggio» a un altro ordine, quello della Bellezza, della Verità e della Giustizia. Si tratta di un tema che contiene il pathos e l’esattezza di Simone Weil, il suo essere stata una pensatrice poetica e insieme una mente che si è spinta coraggiosamente al confine con la trascendenza, che in lei è diventata esperienza vissuta dell’esigenza assoluta di giustizia, dell’aspirazione alla purezza e alla bellezza.
I saggi raccolti nel volume approfondiscono i temi principali del pensiero weiliano, dal pensiero politico alla concezione della poesia, della religione, della giustizia, del diritto, dell’insegnamento, dell’attenzione e della compassione. Viene inoltre esplorato il rapporto con i pensatori (Descartes, Pascal, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche) con i quali Simone Weil si è confrontata. In alcuni, in particolare in quelli più specialistici, il tema del rapporto tra Necessità e Bene resta in controluce. La sua luce esplode tuttavia improvvisa, quasi inaspettata, in un profilo dell’attività weiliana apparentemente marginale e poco noto, quello della produzione poetica (otto poesie, la pièce Venezia salva).
Nel saggio Andare mediante le parole al silenzio. Poesia e poesie in Simone Weil Domenico Canciani riporta l’affermazione di Simone Pétrement, autrice di una ormai classica biografia, che Simone Weil fosse disposta a «sacrificare la sua opera per le poche poesie che aveva scritto». Canciani ha ricostruito le fonti e in particolare la relazione delle poesie con gli scritti filosofici, con il lavoro di traduzione e la riflessione sul linguaggio e nel suo contributo offre una lettura della poesia Il mare, composta nel 1932. Consiglierei ai lettori e alle lettrici del libro di partire di qui, da questa poesia, che è una preghiera, per non perdere nella complessità del pensiero weiliano l’essenza, vorrei dire la scommessa, insita nel rapporto tra Necessità e Bene. Ne cito alcuni versi nella traduzione di Domenico Canciani: «Oscillanti e fisse le onde del fondale, / Ove a tempo debito ogni goccia discende e risale, / Per la legge sovrana restano giù in basso. / La bilancia dai segreti bracci d’acqua trasparente, / Pesa se stessa, la spuma e il ferro, / Giusta, non vista, verso ogni barca errante. / Sullo scafo un filo blu traccia un rapporto. / Senza errore, nella sua linea apparente. / Vasto mare, abbi pietà degli sventurati mortali, / Stretti sulle tue rive, persi nel tuo deserto. / A chi s’inabissa parla prima che soccomba. / Scendi nella sua anima, nostro fratello mare, / purificala nelle tue acque di giustizia».
(il manifesto – Alias, 11 gennaio 2026)

Regista, artista, attivista, Bani Khoshnoudi vive a Parigi. In Iran non è più potuta tornare dopo il suo film, The Silent Majority Speaks (2010) sulle rivolte del 2009 contro l’elezione di Ahmadinejad presidente. Nelle sue storie e nei suoi archivi che raccolgono le immagini delle lotte di iraniane e iraniani, continua a costruire una memoria della resistenza contro il regime.
Che eredità ha preso questa nuova protesta dal movimento Donna, vita, libertà? E in che modo ogni ondata di rivolta cambia la società iraniana?
C’è stata un’evoluzione a poco a poco nel modo di scendere in strada e di manifestare che è legata a trasformazioni importanti della società iraniana e del modo di pensare collettivo. Donna, vita, libertà in questo senso ha segnato un passaggio molto profondo, per la prima volta ha coinvolto tutto il Paese, non solo le città. E ha rotto il muro della paura: le manifestazioni sono andate avanti per otto mesi, la gente non aveva più paura del regime, di chiederne la fine, di gridare i nomi dei figli e delle figlie uccise o imprigionate.
Soprattutto è stato il movimento di una nuova generazione di ragazze, di donne che erano nelle prime file, di persone giovani, ventenni o poco più che hanno cambiato il paradigma rivoluzionario. Insieme ai curdi che sono stati protagonisti di azioni dirette spesso armate. Alla fine della rivolta la resistenza di Donna, vita, libertà non si è fermata: ci sono stati scioperi indetti dal sindacato dei trasportatori, che è molto forte, manifestazioni degli studenti, l’intera società è rimasta vigile e coinvolta. E questa è una differenza fondamentale che ci porta a oggi.
Abbiamo avuto altri momenti di protesta ma mai di tale unione e forza anche se credo che ogni volta si creassero delle fratture nella collettività. Il primo momento in cui si è vista tanta gente insieme in strada è stato nel 2009, poi nel 2019, anche allora la protesta era iniziata dalla crisi economica dovuta all’aumento dei prezzi della benzina. Il regime aveva tagliato internet come adesso per due settimane facendo un massacro, e poco prima gli Usa in Iraq avevano ucciso Soleimani. Oggi contro questa ennesimo crollo dell’economia le iraniane e gli iraniani si sono riuniti di nuovo, sono scesi in strada, e ci sono stati già centinaia e centina di uccisi. Eppure nelle immagini si vedono persone con bambini, anziani, è un caos organizzato. A differenza di quanto dicono le potenze straniere siamo già andati molto avanti, non c’è bisogno di alcun aiuto.
A questo proposito Trump ha minacciato di colpire l’Iran per “sostenere” le lotte dei manifestanti. Cosa ne pensi?
Le iraniane e gli iraniani non vogliono interventi internazionali, americani o inglesi, abbiamo una lunga storia su questo nel XX secolo, penso al colpo di stato nel 1953 [contro Mohammad Mossadeq, eletto democraticamente, che riportò lo scià Reza Pahlavi, ndr] e così la rivoluzione, pure se nata all’interno è stata in certe fasi indirizzata. Siamo molto critici verso l’interessamento di alcuni paesi, e gli interessi di un colonialismo economico e politico che ci sono dietro. Oggi una delle cose più inquietanti è la figura del figlio dello scià, Reza Pahlavi, che vive negli Stati uniti e si sta autoproponendo come garante politico nella transizione dei poteri. Non è amato in Iran e non è mai stato particolarmente attivo, ma sta cercando di far passare l’idea che l’obbiettivo di questa rivoluzione è rimettere al potere la monarchia. I suoi interlocutori sono Netanyahu e Trump che appunto minaccia di far cadere le bombe sull’Iran. Reza Pahlavi non ha alcuna legittimità di parlare in nome del popolo iraniano, tanto più che già suo padre era stato messo lì dagli americani e dagli inglesi, ma cominciano a circolare in rete video delle proteste in cui il sonoro è stato cambiato per sostituirlo con slogan a favore della monarchia. Sono manipolazioni che rendono però l’idea dei pericoli futuri possibili. Perché questa rivoluzione è nata ancora una volta dalla strada, dai mercati, i bazar, da una forza popolare; invece si sta cercando di inquinarla per portare il Paese di nuovo verso una soluzione autoritaria. La società civile in Iran è molto strutturata ma si vuole dimostrare il contrario. Ci sono molte possibili democrazie in Iran, Israele e gli Usa però non vogliono permettere che trovino la propria strada.
Khamenei ha promesso la pena di morte per tutti i manifestanti.
Sono capaci di tutto perché sanno che devono cadere. Però credo che nessuna azione violenta spegnerà la rivolta. E anche se ci sarà un vuoto di potere potrà servire a riflettere, dall’interno possiamo controllarlo. Mentre le bombe americane o israeliane o gli attacchi pilotati no, sono solo contro di noi.
(il manifesto, 11 gennaio 2026)
A un certo punto della lunga, stupenda, massacrante conversazione che Carla Lonzi e Pietro Consagra hanno per sottoporre la loro relazione alla prova dell’autocoscienza, lui le dice: «Sento che dal femminismo ho guadagnato. Come uomo, ho avuto la sensazione che quello che ci guadagna dal femminismo è più l’uomo che la donna». Lei gli dà ragione, e aggiunge però che quel guadagno rafforza solo in parte gli uomini: «Quando il padrone è stato cosciente del suo profitto, si è indebolito: ha dovuto cominciare a trattare con chi era cosciente di dargli un profitto». È il 1980, Lonzi è la più importante teorica del femminismo radicale italiano e morirà due anni dopo, cinquantunenne, anche se ancora non lo sa; Consagra è uno scultore di fama, stanno insieme da sedici anni e decidono di mettersi alla prova: si chiudono in una stanza, con un registratore acceso, e discutono per quattro giorni dell’incomprensione di fondo, insanabile, che mina la loro relazione e il loro dialogo, e che trova ragione nel fatto che lei è una donna e lui un uomo. Lui non è in grado di riconoscerla davvero, anche se la ama e le sta accanto. Il loro legame è inevitabilmente impari: non è uno accanto all’altra che potranno battersi per il femminismo. Vai pure, il libro che è la trascrizione di quelle conversazioni, è stato da poco ripubblicato da La Tartaruga e non è invecchiato neanche di un giorno.
Consagra aveva ragione: del femminismo beneficiano innanzitutto gli uomini, essendo vittime di patriarcato quanto le donne. Ed è vero persino ora, mentre il femminismo e le sue pluralità sembrano non certo sconfitte, ma avversate, in linea con il momento di rigetto di tutti i traguardi progressisti degli ultimi anni, e con la contrazione dei diritti e delle diversità.
È difficile prevedere se siamo alla vigilia di uno dei molti inabissamenti di cui è piena la storia dell’affermazione della differenza delle donne: i segnali che arrivano dalla società civile sono diversi, spesso contraddittori, la rivalutazione della vita familiare tradizionale, l’ossessione procreativa di tutti i governi occidentali, la limitazione dei diritti riproduttivi, le difficoltà di conciliazione di vita e lavoro convivono con una diffusione della coscienza di genere e del problema della violenza patriarcale, così come con assetti relazionali sempre meno iniqui.
I medesimi opposti stanno in piedi tanto nel piano privato quanto in quello pubblico, tanto in quello politico quanto in quello culturale. A beneficiare del femminismo, in ambito culturale e specificamente letterario, sembrano essere ultimamente e sempre di più gli scrittori. Si tratta di una predazione, di una appropriazione culturale?
Una quasi certezza è che il femminismo ha migliorato gli uomini (non tutti) e ha migliorato gli scrittori (non tutti) ma resta da capire se questo cambiamento finito bene, visto il modo in cui è avvenuto, ha incluso o meno le donne, se è avvenuto o sta avvenendo, per surreale e paradossale che possa sembrare, a loro discapito.
Esistono due macrocategorie: scrittori che registrano il cambio di sguardo sulla virilità che le battaglie femministe hanno non solo richiesto e talvolta imposto, ma pure elaborato, e quindi cambiano il racconto del maschile (e per utopistico che possa sembrare, quello che cambia e succede nei libri, prima o poi cambia e succede nel mondo); scrittori che si fanno testimoni della battaglia femminista.
Quando Andrea Bajani ha vinto il premio Strega e ha detto «Anche gli uomini devono combattere il patriarcato», oltre al plauso c’è stato il biasimo: è parsa una dichiarazione facilona, opportunista, in fondo figlia di un momento in cui, come che vada il mondo, dirsi accanto alle donne, oltre che qualificante, è redditizio. La letteratura non è mai stata meno immune alle meccaniche produttive capitalistiche, pertanto non ha anticorpi per non ammalarsi della brandizzazione del femminismo. Non che non esistano scrittrici che hanno, più di una volta, piegato il femminismo a fini commerciali.
Se ci sono i maschi performativi, cioè quelli di buone letture, buoni consigli, ottime credenziali etiche, ma biechi intenti, esistono anche gli scrittori e gli intellettuali performativi, e ne dà una descrizione esilarante Tony Tulathimutte in Rifiuto (e/o, traduzione di Vincenzo Latronico) e questo è un esempio glorioso di come la propagazione femminista abbia vivificato il dibattito intellettuale: quando il teatro e la letteratura ne fanno una buona parodia, una emancipazione è il più delle volte vicina a compiersi.
C’è stato e c’è molto entusiasmo per Nella carne di David Szalay, che ha vinto il Booker Prize del 2025 (lo abbiamo scritto già su questo giornale, tra i bilanci dell’anno appena passato: tutti i grandi premi letterari, nazionali e non, l’anno appena passato sono andati a uomini, che hanno fatto rubamazzo, e chi lo sa quanto sono consapevoli che parte del merito è anche del femminismo, lo stesso femminismo che è, insieme, lotta contro di loro e lotta per loro).
Szalay racconta le alterne fortune di un ungherese che gira per l’Europa: lo vediamo uccidere il marito della sua amante quando è adolescente, finire in riformatorio, fare il soldato in Iraq, drogarsi, perdersi, salvare la vita a un uomo, fare l’autista di un ricco affarista e diventare l’amante di sua moglie. Lo vediamo cercare se stesso. Lo vediamo soffrire dei casi della vita e della condizione maschile. Lo vediamo rispondere a monosillabi, essere impenetrabile per annichilimento da “sacrificabilità maschile”, concetto caro ai movimenti della manosfera, lo vediamo, grazie all’abilità dello scrittore ma pure allo sguardo e alle contezze che il femminismo ci ha dato in questi anni, essere vittima di ruoli, stereotipi, sovrastrutture. Lo vediamo reagire o per rabbia o per rassegnazione: raramente, forse mai, per amore di sé e della vita. Qualcuno ha calcolato che István, questo il nome del protagonista, dice «ok», in tutto il romanzo, cinquecento volte. E tutte le volte è sia asservito che assertivo: più che di un romanzo sulla mascolinità tossica, come è stato scritto diffusamente, sembra che Nella carne sia un romanzo sul cambiamento ambiguo e bifronte della mascolinità, il suo soggiacere e il suo ribellarsi. Tuttavia, in queste quattocento pagine non tutte magnifiche, non c’è molto di più, sull’intimità maschile, di quello che Martin Amis, ne L’informazione, uno dei più grandiosi libri sui maschi e sull’amicizia (era il 1995), ha scritto in tre righe di incipit: «Le città di notte contengono uomini che piangono nel sonno, poi dicono niente. Non è niente. Solo un sogno triste». Quello che avrebbe potuto esserci, di più, e non c’è, in Nella carne, sono le donne: la relazione con loro, il tentativo di dialogo e l’esplorazione delle sue possibilità, lo stesso che fece Carla Lonzi in Vai Pure. E questo è il limite di quasi tutti i libri sul maschile usciti negli ultimi anni, tranne forse La voce del padrone (add) di Francesco Pacifico, spassoso reportage di un uomo dalla sua vita privata condivisa con una compagna femminista. La tanto dichiarata crisi della virilità, quindi, per ora, ha portato a un racconto nuovo del maschile, ma non della relazione del maschile con il femminile. Per ora, il femminismo giova agli scrittori perché dà loro argomenti certi, bandelle accattivanti, ispirazioni, in fondo facili, per romanzi affollati da uomini che compiono interessanti liberazioni solitarie, che resistono, che si ricompongono, che si sgretolano, ma che lo fanno per sé.
(La Stampa, 9 gennaio 2026)