da La Stampa
Critica e curatrice, traccia un ritratto concettuale e visivo della comunità dell’arte degli ultimi decenni
Mi sono fatta «le ossa nelle discussioni sulla differenza sessuale nelle lunghe serate al Cicip e Ciciap, alla libreria delle donne di Milano, nella collaborazione al corso di Ida Farè alla Facoltà di Architettura di Milano, dove presento giovani artiste come Luisa Lambri, maestre e maestri come Marisa Merz, Luciano Fabro e Spalletti. Intanto l’amore con Giorgio e il suo libro su gnostici, streghe, baccanti (Occidente misterioso) mi fanno toccare con mano che il femminismo è necessario anche agli uomini».
Slalom. Arte contemporanea scritti e letture 1990-2024 (Mimesis) è un mosaico che restituisce un vivace ritratto concettuale, politico e visivo della comunità dell’arte degli ultimi decenni. È una specie di arazzo che lega tra loro persone, opere, micro e macro-eventi. Le parole riattivano il fluire dell’esperienza intellettuale e affettiva della critica e storica dell’arte medievale Francesca Pasini, cofondatrice della rivista Grattacielo – Occhi di donna sul mondo (1980), collaboratrice della rivista Alfabeta2 e curatrice, tra l’altro, del progetto “La quarta vetrina” alla Libreria delle Donne di Milano, iniziato da Corrado Levi nel 2001.
Minimale e universale, la sua scrittura fa emergere ricordi che ci portano lontano, in una dimensione domestica: ad esempio nella casa dei nonni paterni a La Fossa (Fagarè della Battaglia), con la signora Rita Liverani maestra privata, la nonna Maria che aveva studiato con orgoglio al collegio di Graz e il nonno Gigi che «leggeva a voce alta il giornale e mi faceva ascoltare la radio».
Lo Slalom di Pasini parte dal personale e si fa pubblico, raccoglie e attualizza articoli, saggi e presentazioni di mostre di un trentennio su figure molto diverse tra loro: dai notissimi Maurizio Cattelan, Carol Rama, William Kentridge, ai più giovani Marzia Migliora, Elisabetta Di Maggio, Maria Morganti, Sergio Racanati. Dentro le loro opere scorre la vita e si percepisce l’eco di progetti polifonici e di discussioni post o pre-vernissage.
Sono percorsi sia introspettivi sia collettivi che decodificano e disvelano le singole ricerche. «Quando ho visto nell’arte dei soggetti con cui parlare e discutere – scrive l’autrice – e non solo degli oggetti da ammirare e studiare, ho capito che i quadri, i libri, i film sono strati della mia biografia, come gli amori, gli affetti familiari, le amicizie, gli incontri quotidiani. Così ho deciso di fare degli slalom, tra i testi che ho scritto e quelli che mi suggeriscono gli eventi mentre scrivo. Sono andata spesso “fuori pista” non per aggiornarli, ma per trattarli come una persona a cui raccontare cosa penso». E al lettore suggerisce di farsi il proprio slalom personale stando di qui e di là. «Sottolineo libri e giornali perché mi piace parlare – scrive – l’ho capito con l’oralità teorica delle donne (autocoscienza e discussioni collettive) e con Radio Popolare di Milano dove ho imparato a far vedere a chi ascoltava le mostre che avevo visto io».
Il libro racconta come sono nate le idee delle mostre da lei curate e come si sono sviluppate. Peccato di novità alla Galleria Emi Fontana (1993) è stata ispirata dalla regola nemini licere insolita ponere immagine del Concilio di Trento che afferma: «Commettono “peccato di novità” gli artisti che disubbidendo all’iconografia stimolano il fantasticare della mente invece che la divozione». L’autrice ci rende partecipi della processualità generatrice dei suoi percorsi mentali e affettivi. Sullo sfondo c’è sempre Giorgio, il suo amore. La relazione con Giorgio Galli, prolifico intellettuale dalle intuizioni geniali, scomparso cinque anni fa, ha rappresentato per lei un brillantissimo confronto quotidiano sin da quando, poco dopo averlo conosciuto, gli invia un proprio testo. «Temendo di essermi lasciata troppo andare dall’intreccio arte/Heidegger/muro di Berlino, ho telefonato al politologo Giorgio Galli, chiedendogli se poteva leggere quello che avevo scritto e darmi un giudizio sincero. […] Il 2 febbraio 1990 ci vediamo, condivide quello che ho scritto. Galeotto fu il libro. Non ci siamo pi lasciati».
Questo anomalo “fuori pista” letterario è un incrocio fra il diario, l’autobiografia e il saggio, con inciampi, riflessioni, pensieri e ritorni a ricciolo sugli argomenti che stanno a cuore all’autrice. Il pregio è di avere redatto una sorta di antologia del contemporaneo che raduna le opere di numerose artiste e artisti, altrimenti disperse in innumerevoli cataloghi. Il confronto con la letteratura, la scienza e la storia, è serrato e continuo ed è focalizzato su dettagli che diventano argomento universale. Un giorno, di fronte all’Ultima Cena di Paolo Veronese, Pasini nota un bicchiere vuoto uguale a quelli con i quali brindava con Giorgio ad ogni suo compleanno. Quando però torna di fronte all’opera non lo trova più. Lo cerca ossessivamente e pensa «se me lo fossi sognato?». Con la tenacia della ricercatrice analizza più volte l’immagine al computer e lo ritrova. Quel bicchiere vuoto, misterioso, tenuto da un Moro vicino alla testa di Gesù è per lei un “peccato di novità”.
da Il Corriere della Sera
Le statistiche mostrano una significativa riduzione dei femminicidi in Spagna. Con una capillare e costosa rete di attenzione ai «reati sentinella». Introdurre un reato invece non costa niente
Il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio e lo punisce con l’ergastolo. La nuova legge porterà ad una diminuzione dei femminicidi? No. Da anni in Italia si susseguono leggi volte a contrastare la violenza di genere, senza significativi miglioramenti. Il nuovo reato non cambierà le cose. Il problema non è solo italiano, ma ha una estensione mondiale.
Vi è un solo Stato nel quale le statistiche mostrano una significativa riduzione dei femminicidi: la Spagna.Da un report pubblicato dal ministero per l’Uguaglianza spagnolo emerge che i femminicidi dal 2003 al 2024 sono diminuiti del 30%. Come si è ottenuto questo risultato? Nel 2004 è stata approvata una legge organica sulla violenza di genere. Per contrastare i femminicidi, grandissima attenzione è dedicata alle forme meno gravi di aggressività verso le donne. Il femminicidio è infatti spesso preceduto da una serie di comportamenti «sentinella», in sé poco gravi, ma chiari sintomi dell’attitudine del futuro femminicida. Le pene previste sono lievi, ma catalogare questi comportamenti come reato consente alla polizia specializzata di mettere sotto controllo il responsabile, al quale quindi viene impedito di agire indisturbato.
È stato istituito un numero telefonico sempre operativo al quale le donne possono informalmente rivolgersi per segnalare comportamenti o semplici paure. Un grande numero di operatori specializzati raccoglie queste segnalazioni: qualche volta interviene, qualche volta si limita ad osservare con discrezione. Quando i reati «sentinella» vengono commessi, l’osservazione e l’intervento si traducono in forme pressanti di controllo e protezione.
Tutto ciò costa molto denaro. In Spagna, al ministero per l’Uguaglianza è stato assegnato un budget di 600 milioni di euro l’anno, in costante aumento. Dalla nuova legge italiana, invece, non potranno derivare maggiori oneri per le finanze pubbliche. Sono previsti solo tre capitoli di spesa per un totale di 636.000 euro l’anno. Affrontare un problema costa, prevedere un nuovo reato non costa nulla ma non risolve il problema.
da il manifesto
Al Festival della Valle d’Itria per la prima volta in Italia “Owen Wingrave”, tratto da un racconto di Henry James
Le opere di Benjamin Britten pongono domande sull’identità maschile: cosa vuol dire essere uomini, come lo si diventa, a che prezzo. Mentre i protagonisti fanno i conti con se stessi, la musica smaschera le tecniche che li rendono sottomessi, e suggerisce strategie di resistenza. Per farlo, crea contrasti tra linguaggio tradizionale e moderno, imbastendo temi conduttori e un raffinato montaggio sonoro, asso nella manica di un compositore che a vent’anni si era fatto le ossa lavorando per il cinema documentario.
Succede anche in Owen Wingrave, da un racconto di fantasmi di Henry James: l’opera che il Festival della Valle d’Itria propone per la prima volta in Italia domani, a più di mezzo secolo dalla creazione. Obiettore di coscienza durante la Seconda guerra mondiale, Britten la scrive negli anni del Vietnam e dell’invasione della Cecoslovacchia, identificandosi col pacifismo del protagonista. Questi, avviato alla carriera militare, di nascosto legge Shelley e non ci sta a «preparare la mente e il corpo per la distruzione», tanto da abbandonare gli studi, disconoscendo così i valori perseguiti dalla famiglia di cui è ultimo rampollo.
La sua mascolinità dissidente si rispecchia nella storia del giovane antenato colpito a morte dal padre per sospetta pavidità, racconto evocato nella scabra ballata medievale del secondo atto; solo un sacrificio placherà i due spiriti, padre e figlio, la cui presenza Owen avverte nell’antica dimora dei Wingrave, Paramore.
Come spesso accade nel teatro di Britten, Paramore è un luogo che si anima di vita propria e produce musica ispida, spigolosa e urticante, a iniziare da una strana marcia che detta il tono militaresco alla partitura. Simbolo di virilità guerrafondaia, la fanfara è caratterizzata da accenti sghembi, orchestrazione eccentrica (glockenspiel, xilofono, pianoforte, arpa, violoncelli pizzicati) e ritmo irregolare. Manca qualcosa: se è una marcia, c’è qualcuno che zoppica.
D’altronde a Paramore il tempo è fluido, i morti si confondono coi vivi, il passato col presente. A parte sir Philip, anziano generale a riposo, in casa non ci sono uomini, tutti morti in battaglia. Rimangono le donne, custodi della memoria dei defunti, insieme al vegliardo che ormai non canta più, nemmeno lui, da vero uomo. Questa voce di tenore che non si comporta da tenore è uno dei tratti più graffianti usciti dalla penna di Britten, che la spinge al polimorfismo, alla coloratura virtuosistica, a glissandi e vocalizzi come se sir Philip fosse la vera Primadonna dell’opera e la virilità in congedo producesse il suo rovescio, un belcanto malfermo e traballante. Accade quando egli va sulle furie perché teme che la ribellione di Owen nasconda altro: il pacifismo non sarà mica défaillance di genere e sessuale? Dubbio che si insinua anche nel racconto di James, quando il ragazzo riferisce le accuse del nonno: «Mi ha chiamato… mi ha chiamato…», ma non riesce a pronunciare quella parola.
La mascolinità normativa, rappresentata dai temi musicali scheletrici degli antenati, i cui ritratti incombono accigliati dalle pareti, è il vero fantasma dell’opera, che genera morte non solo per Owen. Giustamente la librettista Myfanwy Piper vedeva Wingrave come «a very personal coda» del War Requiem scritto pochi anni prima, di cui chiarisce il messaggio pacifista: il passato coloniale europeo ha portato solo tragedie, l’imperialismo soffoca le vite di tanti giovani uomini e di quelle donne, madri e compagne, che lo sostengono convinte.
“Family” e “war”, virilità e bellicismo si nutrono a vicenda; ma se da un lato il compositore denuncia le responsabilità della famiglia in quella che negli stessi anni Mario Mieli definiva “educastrazione”, dall’altro affida al protagonista parole dure, per esprimere il rifiuto di ogni esercito di stato: «considero un crimine impugnare la vostra spada in difesa del vostro paese e un crimine da parte del governo il fatto di ordinarlo». Il discorso che chiude il primo atto è preparato dall’episodio più delirante dell’opera, in cui la vena di Britten, fino a quel punto un po’ sulla difensiva, prende il volo verso la dimensione dell’assurdo come in un finale rossiniano: sulla parola “scruples” (scrupoli), incautamente pronunciata a difesa del ragazzo, i familiari si lanciano compatti in una serie di sillabati e vocalizzi di scherno.
Le parole di Owen – e di Britten – hanno dunque una valenza politica che non si può disconoscere col pretesto che l’opera riguardi più che altro un conflitto psicologico dovuto alla mancanza del padre o alle incertezze della virilità acerba. Combattere per la patria è un crimine, i governi che lo ordinano sono criminali, la patria è impostura: affermazioni scomode ancora oggi in ogni nazione il cui governo giustifichi immani spese militari.
Owen afferma che sarebbe sufficiente dire di no: basta una parola, se a dirla sono in tanti. «One little word: no! No! No! No!»: è la scena più anarchica e provocatoria mai scritta dal compositore.
da Avvenire
Il filosofo Assael: «Sarebbe uno strumento di pressione su Israele. Ha ragione Zuppi, ora tutti devono fermarsi. Hamas? Ha solo la guerra come strumento di sopravvivenza politica»
Tutti parlano di un piano per arrivare al cessate il fuoco, ma la verità è che nessuno sa da dove cominciare. E questo conflitto tra la necessità di una nuova tregua armata tra Israele e Hamas e il bisogno di giustizia per i popoli dopo il disastro umanitario che è sotto gli occhi di tutti, lacera anche le coscienze di chi, come Davide Assael, filosofo italiano di origine ebraica, dice che «il primo passo da fare è innanzitutto non assecondare le logiche di guerra che si sviluppano quotidianamente nello scenario di Gaza e che, via via, hanno portato a sentimenti di antisemitismo, antigiudaismo, islamofobia, cristianofobia. Non posso che condividere al cento per cento – aggiunge Assael – l’appello lanciato nei giorni scorsi dal cardinale Matteo Zuppi e dal presidente della comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, che invita tutti a fermarsi. Non c’è altra soluzione».
L’annuncio del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia di Macron cambia le carte in tavola?
Da ebreo sono favorevole a questo pronunciamento, perché penso possa essere uno strumento di pressione diplomatica indispensabile per portare lo Stato di Israele al negoziato. E sono favorevole non da oggi, ma da quando Abu Mazen ha posto la questione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Intendiamoci: non è un passaggio decisivo, ma può aiutare a fare chiarezza. Soprattutto perché entrambe le parti, ora come ora, si trovano in un vicolo cieco.
Perché?
Perché dopo il cessate il fuoco terminato a marzo, che non ha affrontato nessuno dei problemi sul campo, tutte le contraddizioni già emerse sono esplose. Prendete Hamas: ha solo la guerra come arma di sopravvivenza politica e, nel lungo periodo, non può trattare nemmeno in nome e per conto del mondo arabo. Dirò di più: chi può farsi carico dei palestinesi se, fuori dai confini della Palestina, nessuno davvero li vuole? Guardate all’Egitto, al Libano, alla Giordania per capire cosa sto dicendo… Quanto poi a Israele, è evidente la responsabilità storica che si è assunto Netanyahu: non aver sfruttato lo scenario a suo favore, concretizzatosi con gli accordi di Abramo e l’alleanza con il mondo sunnita.
A Gaza adesso non si intravedono spiragli, sembra esserci solo devastazione e distruzione…
Io non sono così atrocemente pessimista. È tutto vero, per carità: la guerra doveva finire da tempo, Israele non ha un piano per uscire dal pantano in cui si è cacciata, le dichiarazioni di alcuni ministri di Tel Aviv sembrano evocare il genocidio. Però gli aiuti alimentari stanno arrivando in ogni caso: via terra, via mare e via aria. Il piano umanitario c’è e, se il cibo non arriva, la responsabilità è anche di Hamas.
Affamare un popolo come arma di guerra non è un crimine?
Le parole di Papa Leone XIV sul tema sono state illuminanti. Ripeto: molti ebrei provano vergogna per come il governo israeliano sta conducendo il conflitto nella Striscia. Chi delle due parti pensa solo all’eliminazione completa dell’altra è fuori dalla storia. Poi è giusto dire che la comunità internazionale e l’opinione pubblica devono prendere atto che siamo esposti a una guerra che è anche di propaganda e che è difficile orientarsi in questo caos mediatico. Ma non c’è dubbio che a Gaza attualmente regni il caos, con bande armate, spesso finanziate da Israele stesso, che vogliono prendersi un pezzo di territorio che l’esercito non ha mai controllato.
Perché Netanyahu sembra essere così irremovibile nella sua strategia?
Perché è consapevole che la sua sorte è legata alla continuazione del conflitto. Il problema è che la sua leadership ha assunto tratti paranoici, giustificati anche dal conflitto evidente che egli stesso ha aperto con altri corpi dello Stato. Quando si tornerà ad elezioni, e non accadrà molto tardi, il confronto sarà una specie di referendum sul suo operato e sulle tante ombre che hanno portato al 7 ottobre.
da Domani
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla riscoperta delle opere di grandi autrici italiane del Novecento. Un aspetto che però viene trascurato è il rapporto strettissimo che c’era tra la loro arte e l’attivismo
Quest’anno il tema del Salone internazionale del libro di Torino è stato “Le parole tra noi leggere”, omonimo titolo del più famoso tra i libri di Lalla Romano, vincitore del Premio Strega del 1969. A pochi giorni dalla fine della fiera libraria, a fine maggio, è stato presentato al Teatro Franco Parenti [di Milano, Ndr] un docufilm di Marco Manzoni in ricordo di Gina Lagorio, romanziera, autrice di saggi, testi teatrali, interventi politici, della quale ricorre il ventesimo anniversario dalla morte.
Lo scorso dicembre la casa editrice Bilder Atlas ha pubblicato Al cerchio delle tue mani, un imponente volume che raccoglie il materiale fotografico di Bibi Tomasi, tra le fondatrici della Libreria delle donne di Milano, negli anni in cui il movimento femminista della città godeva di maggiore fermento, e cioè a partire dal 1974 fino al 1979. E come dimenticare i recenti richiami, da parte dei giornali e di altri organi informativi, a Fabrizia Ramondino e al suo L’isola riflessa, che ripercorre il periodo di confinamento a Ventotene di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e altri oppositori del regime fascista dopo le polemiche per le frasi di Giorgia Meloni sul manifesto che da quell’isola prende il nome? Sembra, insomma, che il tributo alle autrici del passato continui a imporsi all’interno del panorama culturale quasi fosse di pedaggio naturale, di omaggio fisiologico, obbligato.
Non è un caso che quella porzione del Novecento stenti a depositarsi. Almeno per qualche decennio, infatti, scrivere, produrre letteratura, ha significato nutrire sistematicamente un dibattito politico e sociale che all’epoca era inscindibile da qualunque presa di posizione sul mondo. Partecipare in modo attivo a una dimensione collettiva, contribuire a convalidarla rappresentava una sorta di attestato alla complessità delle proprie radici identitarie, voleva dire riconoscere che nella vita di ognuno di noi intervengono più dimensioni, anche e soprattutto in quella di chi scrive, e che esporsi, saper raccontare equivale a un impegno sancito nei confronti di tutti, e non può mai essere ridotto a un mero progetto individuale.
Una forma di libertà
Questa, per le donne che all’epoca tentavano di affermarsi in qualità di intellettuali e di pensatrici, era una forma di libertà. Perché, tra le altre cose, consentiva di formare intorno a sé una comunità, caleidoscopici movimenti in divenire che rendevano meno solitario il loro percorso e lo fissavano nel tempo una volta per tutte.
Guardando il documentario su Gina Lagorio, per il quale Marco Manzoni ha raccolto testimonianze di amici che la conoscevano e la frequentavano, subito traspare il sentimento di feconda condivisione di chi non distingueva la coscienza politica da quella poetica e lasciava anzi che i due linguaggi confluissero, entrassero l’uno nell’altro.
Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, il movimento internazionale nato nel 1986 e volto a pratiche agricole e gastronomiche sostenibili, ricorda il piacere, anzi, la gioia che entrambi provavano incontrando l’odore della cioccolata e del vino delle Langhe. Lella Ravasi Bellocchio, psicoanalista, ripercorre i ritrovi domenicali organizzati da Gina Lagorio nella sua casa milanese, durante i quali si leggeva un canto tratto dal Purgatorio dantesco e poi ci si attardava a commentarlo, a dibatterlo, un appuntamento a cui partecipavano, tra gli altri, i poeti Lello Baldini e Franco Loi. Vivian Lamarque menziona lo sdegno di un’estate, quando vede decine di uccellini costretti in gabbia alle fiere, e le lettere che Gina subito si affretta a recapitare a enti e ad associazioni allo scopo di liberarli. Nando Dalla Chiesa evoca l’assemblea di denuncia della criminalità organizzata e delle derive affaristiche legate alle tangenti dove per la prima volta si incontrano, lei seduta in prima fila, e la lunga collaborazione che segue sulle pagine della rivista Società Civile.
Femminismo e palazzi
Era quella una fase in cui prendere posizione non si limitava semplicemente a pronunciarsi in merito a questioni più stringenti di altre. Consisteva in una militanza attiva, sul campo. La stessa Lalla Romano aderisce al Partito Comunista, viene eletta in qualità di consigliera comunale e poco dopo si dimette.
Gina Lagorio, dal 1987 al 1992, è parlamentare nel gruppo della Sinistra indipendente, un onore e un onere che veniva concesso a chi aveva avuto un ruolo consistente durante la resistenza partigiana, tant’è che in mezzo ai banchi parlamentari siede anche Natalia Ginzburg, simile in tutto e per tutto «a un totem azteco», scrive Lagorio in Parlavamo del futuro (Melampo, 2011). La politica settaria, partitica, condotta dall’alto esaspera, confonde. Se non si cede all’impulso di ritirarsene, se ne registrano le perverse lungaggini, la labirintica oscurità, l’intricatissimo dedalo di corridoi, carte, discorsi che infine rapprendono l’azione, la immobilizzano, ne esauriscono lo slancio, il potenziale. È così che «il palazzo», sagacemente ribattezzato da Pasolini, torna a ergersi alla stregua di un luogo inarrivabile, fumoso, non diverso da altri luoghi di esercizio del potere che l’avevano preceduto. Destinato, progressivamente, a esautorare anche le modalità sperimentali della politica “fuori” dal palazzo: lo sapeva bene Bibi Tomasi, la cui esistenza è stata scandita dalla dimensione comunitaria, dal Movimento di liberazione della donna (Mld) al collettivo di via Cherubini dove convergeva anche il celebre Rivolta femminile di Carla Lonzi, fino all’incontro con Luisa Muraro, Lia Cigarini, Giordana Masotto con le quali darà vita alla Libreria delle donne di via Dogana.
Metodi avventurosi
La lettura corale di testi, la pratica dell’autocoscienza, ossia il tentativo di risalire, attraverso il dialogo, alle esperienze fondative della propria condizione di donne, i ritiri collettivi in Sardegna, le fotografie. Un percorso volto interamente alla messa in discussione della realtà, e non in virtù di una pura ricerca personale, solipsistica. Quanto più un modo avventuroso, anticonformista, di intervenire sull’ordine costituito. Che contribuiva poi a caricare di senso, di significato, di materiale la propria produzione letteraria.
Sono gli stessi anni in cui Fabrizia Ramondino fonda l’Associazione Risveglio Napoli (Arn), una scuola serale di preparazione alla licenza media nonché asilo gratuito per i bambini del circondario. Poi partecipa alla Rivoluzione dei garofani portoghese. Organizza una serie d’interviste e d’inchieste sui disoccupati dei rioni campani. Frequenta un centro di salute mentale femminile che le ispirerà il suo famoso Passaggio a Trieste. Trascorre un periodo in Algeria insieme al regista Mario Martone, in un campo profughi dei Sahrawi.
A proposito di Mario Martone: Fuori, l’ultimo lungometraggio del cineasta presentato al Festival di Cannes, ci riporta alla mente anche la figura di Goliarda Sapienza e il suo periodo di detenzione scontato nel carcere di Rebibbia dopo un furto in casa di un’amica. Un gesto compiuto per ragioni pratiche, ma soprattutto politiche: un temporaneo ribaltamento della sua prospettiva abituale, l’ingresso in un mondo a lei sconosciuto sul quale, si rende presto conto, grava il pregiudizio culturale della classe borghese. Ed è quasi una dichiarazione d’intenti la frase con cui si chiude L’università di Rebibbia, il romanzo del 1983 che riassume i suoi giorni di reclusione: «Imitando Roberta seduta sul letto, le gambe ripiegate a mo’ di scrittoio, una cartella sopra, la testa china… anch’io prendo carta e penna. È necessario».
da il manifesto
Stefania Galegati ha vinto la 13a edizione dell’Italian Council. Tra Indonesia, Tanzania e Italia, un network di residenze, incontri e workshop
Isola delle Femmine è il nome di un comune siciliano, vicino Palermo, confinante con Capaci e comprendente un isolotto, ma anche il titolo di un progetto d’arte contemporanea da quando nel 2017 un gruppo di artiste decise di farne il fulcro di un’operazione visionaria. In concomitanza con la messa in vendita dell’isolotto venne lanciata, infatti, un’attività di crowdfunding allo scopo di acquistare l’isola – di proprietà privata e dal 1997 riserva naturale – «per lasciarla in pace» e farne il punto di avvio di un’opera omnia attraverso la quale indagare temi sociali, ecologici ed economici nonché esplorare questioni più intime legate alle rappresentazioni oniriche e alle attuali forme di desiderio. A oggi ancora l’isola non è stata materialmente comprata, tuttavia il suo potenziale simbolico ha generato modalità di possesso gratuite e funzionali alla costruzione di immaginari.
Proprio con il progetto «Isola delle Femmine», l’artista Stefania Galegati ha vinto la 13a edizione dell’Italian Council, che le permetterà di viaggiare alla ricerca di un arcipelago da esplorare e mettere in relazione con questo lembo di terra nel cuore del Mediterraneo.
Il suo obiettivo è quello di ripensare l’idea di isola attraverso un network internazionale fatto di residenze, incontri e workshop tra Indonesia, Tanzania e Italia. Si inizia dunque quest’estate da Jakarta in collaborazione con Gudskul, un collettivo a carattere educativo-pedagogico di cui fa parte anche il gruppo dei curatori di Documenta 15, i Ruangrupa.
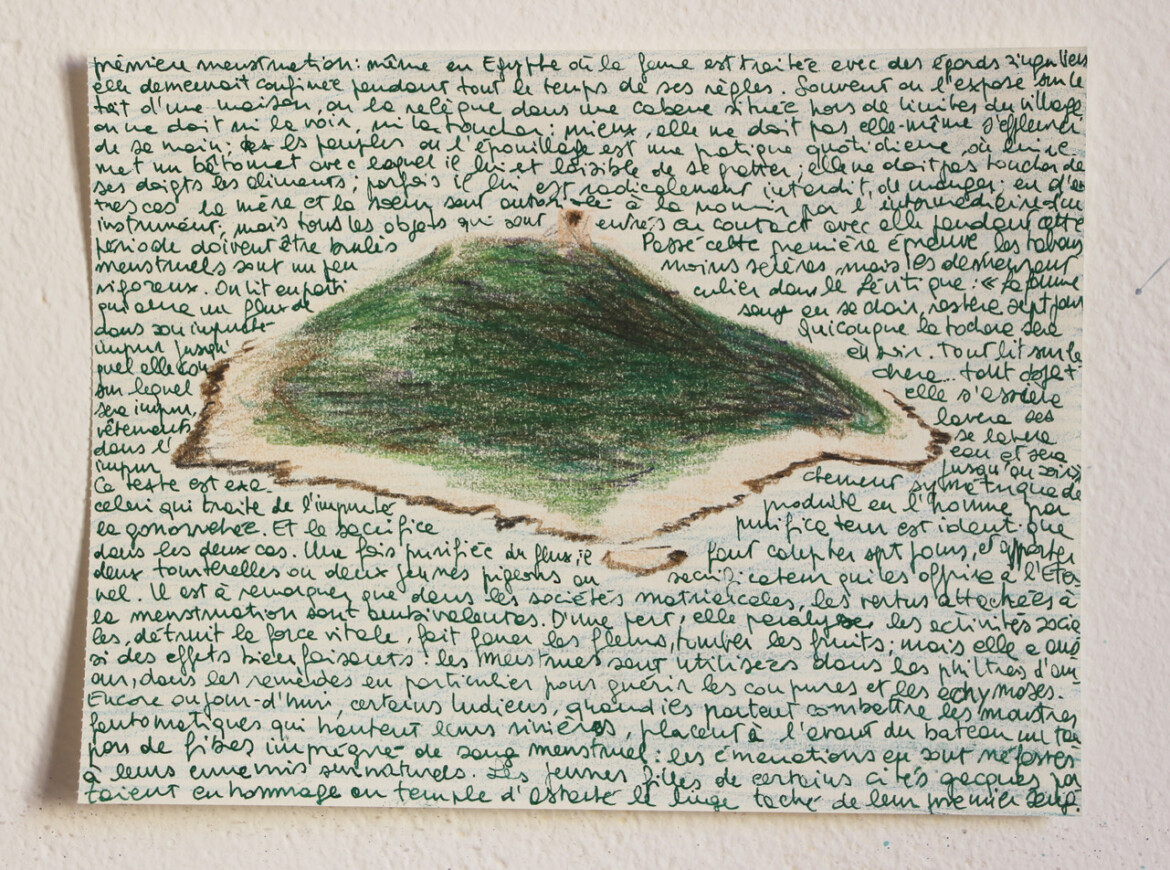
Qui Stefania Galegati coordinerà una serie di laboratori dove a partire da letture sparse tratte – tra le altre – dal diario di Goliarda Sapienza, da libri di Paul Preciado e dal manifesto di Rivolta Femminile, si cercherà di re-immaginare il funzionamento delle istituzioni condivise, come le carceri, gli ospedali, e l’intero apparato afferente ai moderni dispositivi di controllo e sorveglianza. L’obiettivo è quello di scrivere un manifesto per l’isola, costruire quindi delle nuove forme di aggregazione, gettare le basi per una condivisione consapevole dell’esistenza.
Un obiettivo ambizioso certo, ma è l’arte di costruire immaginari il campo di azione di queste pratiche che vogliono trascendere il particolare per raggiungere degli universali che non si riducano a meri concetti ma che possano prendere corpo attraverso percorsi partecipati. In Indonesia dunque ci saranno tre tappe: la prima a Jakarta appunto, la seconda alla Jatiwangi Art Factory e la terza al Musyawarah Arsip (Muar) a Makassar.
Durante i due laboratoriiniziali le parole chiave che comporranno il manifesto verranno stampate prima su stendardi di stoffa colorata a serigrafia e poi, a Jatiwangi, impresse in piastrelle di terracotta; a questo si aggiungerà la produzione di un video con le partecipanti che leggeranno i manifesti. Il terzo workshop, a Makassar, invece sarà dedicato alla ricerca di una possibile sorella dell’Isola delle Femmine (Pulau Betina in indonesiano) nel cuore di quell’arcipelago, detto anche di Spermonde dai colonizzatori olandesi, dove ancora molte isole sono senza un nome. Il progetto proseguirà durante l’inverno in Tanzania presso il Nafasi Art Space, il più importante centro artistico di Dar es Salaam, e si concluderà in Italia in primavera, a Venezia presso la Fundación Tba21 (Fondazione Thyssen-Bornemisza) dove verrà organizzato un incontro di restituzione e poi a Palermo, presso l’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, con l’installazione dell’opera risultato di questa incredibile avventura.
da il manifesto
“Catch the Spirit”, curata da Drew Sawyer e Sondra Gilman al Brooklyn Museum di New York, fino al 3 agosto
Tre donne sotto gli alberi, ognuna con il proprio apparecchio fotografico. A scattare la fotografia in bianco e nero, nel 1952, è Alma Lavenson che si autoritrae con Imogen Cunningham e Consuelo Delesseps Kanaga. Un’amicizia di lunga data unisce queste grandi fotografe del secolo scorso che hanno lavorato con passione, lasciando un testamento visivo di grande forza nel raccontare il loro tempo. Alma Lavenson è autrice anche del ritratto seppiato degli anni Trenta, erede di un certo pittorialismo, in cui “Connie” (come veniva affettuosamente chiamata da amiche e amici) ha il palmo delle mani rivolto verso l’alto. Anche questa immagine è nella teca che contiene la Rolleiflex con alcuni rullini non sviluppati (proveniente dalla Saul Leiter Foundation) con cui inizia il percorso espositivo Consuelo Kanaga: Catch the Spirit, curata da Drew Sawyer e Sondra Gilman al Brooklyn Museum di New York (fino al 3 agosto).
La mostra fa parte delle celebrazioni per i 200 anni del museo newyorkese che nel 1993 aveva organizzato la prima retrospettiva dedicata al lavoro di Kanaga (di cui è conservata una vasta collezione dell’archivio con oltre duemila negativi e stampe), in collaborazione con la Fundación MAPFRE e il Museo d’Arte Moderna di San Francisco. Tra le pioniere della fotografia americana moderna, Consuelo Kanaga (Astoria, Oregon 1894-Yorktown Heights, New York 1978), secondogenita del giudice Amos Ream Kanaga e di Mathilda Carolina Hartwig, è nota per i suoi ritratti diretti, la grande capacità narrativa e soprattutto l’apporto al fotogiornalismo in una chiave fortemente empatica e partecipativa, non solo puramente documentaria. Kanaga inizia la carriera di fotoreporter nel 1915 collaborando ventenne con il San Francisco Chronicle: è nella Golden City che stringe amicizia e frequenta Imogen Cunningham, Dorothea Lange, Tina Modotti e Edward Weston con cui espone come membro non ufficiale del gruppo f/64.

Quando, poi, nel 1922 si trasferisce per la prima volta a New York per lavorare per il quotidiano The New York American conosce Alfred Stieglitz che la incoraggerà a indirizzare il suo personale approccio al fotogiornalismo sviluppando le potenzialità estetiche del mezzo fotografico: altra caratteristica innegabilmente legata al suo modo di cogliere il “reale”. Kanaga fotografa fiori (soprattutto camelie), oggetti e ambienti domestici, scorci urbani e persone, inclusa se stessa modello per sperimentazioni tecniche nell’uso della luce e della prospettiva. Tra i numerosi ritratti esposti – la mostra è suddivisa nelle sezioni “Fotogiornalismo e città”, “Ritratti”, “Americani all’estero”, “Fotografia e scena americana”, “Ritratti di artisti”, “Viaggi nel Sud degli Stati Uniti” e “Studi sulla natura” – sono presenti i volti di amiche e amici fotografi e artisti, tra loro Louise Dahl-Wolfe (insieme viaggiano nel ’27 e ’28 in Francia, Germania, Ungheria, Italia e Tunisia), Alfred Stieglitz a Lake George, W. Eugene Smith e la compagna Aileen Mioko, Mark Rothko, i pittori Morris Kantor e Milton Avery, lo scultore e designer Wharton Esherick, la fotografa giapponese Eiko Yamazawa (che a sua volta ritrae Kanaga nel 1955), Saul Leiter e l’attivista femminista Barbara Deming sostenitrice del cambiamento sociale non violento. Come sosteneva Consuelo Kanaga (la citazione è stata d’ispirazione per il titolo stesso della mostra Catch the Spirit) «Quando si fa una fotografia, è in gran parte un’immagine del proprio io. Questa è la cosa importante.
La maggior parte delle persone cerca di essere appariscente per catturare l’attenzione. Penso che il punto non sia catturare lo sguardo, ma lo spirito.» Con sensibilità, rispetto e coinvolgimento, la fotografa è una significativa portavoce delle discriminazioni razziali negli Stati Uniti, dalle grandi città alle campagne, dalla Florida al Tennessee, dalla Georgia alla California. «La povertà è un tema tenero e terribile, da affrontare in ginocchio» è un’altra sua frase che si riflette nei volti dei bianchi e dei neri, della vedova Watson con il figlio a New York (The Widow Watson, 1922-24) o della madre con i tre figli piccoli in Malnutrition (1928). Da vicino e senza pietismo Kanaga ha raccontato la condizione della popolazione afroamericana e dei lavoratori migranti, recandosi più volte anche a Taos, in New Mexico, dove l’amico Walter P. Lewisohn lavorava alla produzione dei film Navajo Indian Life (1956) e Navajo Night Dances (1957) in collaborazione con il National Council of American Indians. Tra le sue immagini più iconiche figura quella dei tre ragazzi neri di profilo, realizzata ai tempi in cui la fotografa collaborava con la Photo League, pubblicata sulla copertina del Sunday Worker (storico quotidiano comunista) il 1° maggio 1936 – We are the Youth! è il titolo del pezzo firmato da Adam Lapin – nonché She is a Tree of Life (1950), scelta da Edward Steichen per la monumentale esposizione fotografica The Family of Man al MoMA di New York nel 1955; successivamente pubblicata nella copertina della rivista cattolica Interracial Review gennaio 1964).
Ma tante altre rappresentano l’identità dei Neri e del New Negro Movement («Harlem Reinassance»): sembrano immagini antiche quelle delle donne nere del Sud vestite di bianco o colte al lavoro nei campi (come le descrive Toni Morrison in molti suoi romanzi), ma l’obiettivo della fotografa è diretto anche verso personaggi come il cantante e attore Kenneth Spencer, il poeta e intellettuale Langston Hughes, lo scultore Sargent Claude Johnson (la memoria della composizione formale della sua scultura Forever Free è percepibile in She is a Tree of Life) e William Edmonson che figlio di schiavi del Tennessee è stato il primo artista afroamericano a cui il MoMa, nel 1937, ha dedicato una mostra personale. Ritratti in cui l’autrice si concentra sui dettagli dello sguardo, sull’espressione del volto talvolta serissima e poi con un accenno di sorriso, come gli scatti in sequenza del ’36 a Angelo Herndon, sindacalista e membro afroamericano del Partito Comunista degli Stati Uniti (CPUSA) che quattro anni prima era stato condannato a vent’anni di lavori forzati con l’accusa di aver tentato di incitare all’insurrezione in Georgia, guidando una manifestazione di disoccupati afroamericani e bianchi per protestare contro i tagli alle razioni di soccorso.
In seguito era stato arrestato per possesso di letteratura comunista e accusato d’insurrezione. Il suo caso fu celebre tra gli ambienti della sinistra e dei diritti civili, grazie ai quali fu rilasciato prima di scontare l’intera pena, come è documentato nelle memorie legali e in altri documenti conservati presso lo Schomburg Center for Research in Black Culture in Harlem della New York Public Library. Che «la fotografia possa cambiare il mondo», quindi, per Consuelo Kanaga è molto più che una semplice affermazione.
da il manifesto
[…] Lo dicono da sempre i centri antiviolenza e i movimenti femministi che l’azione penale non è la risposta al problema culturale della violenza di genere maschile contro le donne. Lo dicono proprio a quelle forze politiche che si sono fatte promotrici nella creazione del nuovo reato di femminicidio, e l’ergastolo per chi lo commette, ma che quando si tratta di prevenzione, formazione, educazione, respingono le soluzioni.
«C’è tanta demagogia in questa operazione di facciata. Sappiamo che l’inasprimento delle pene non agisce come contrasto, la prevenzione lo fa. Vogliamo l’educazione già dalla prima infanzia, ma su questo il governo si oppone» commenta Cristina Carelli, presidente di D.i.Re., la rete nazionale antiviolenza che si compone di 89 organizzazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio. […]
Ci sono comunque dei risultati, sottolinea Carelli, come l’avere accolto l’obbligo dei centri antiviolenza come parte civile nei processi per femminicidio. «La definizione di femminicidio è importante, definire i fenomeni lo è, ma bisogna essere coerenti. Non crediamo all’approccio giustizialista, non è quello che interessa alle donne. Le donne non vogliono essere rivittimizzate, giudicate perché denunciano». Circa il 30% delle donne che si rivolge ai Cav poi decide di non denunciare, molte a posteriori si pentono di questa scelta. La formazione delle istituzioni è fondamentale, medici, magistrati, forze dell’ordine, servizi sociali: è necessario un intervento che garantisca un’adeguata preparazione su come riconoscere e valutare il rischio e fermare l’escalation che porta ai femminicidi, servendosi della conoscenza proprio di chi vede questa violenza tutti i giorni nei Cav. Una conoscenza che le donne si tramandando dagli anni Settanta, ma che è ignorata. Con il ddl diventa obbligatorio per i giudici seguire un corso sul tema, ma alla scuola di magistratura. […]
La mancanza di finanziamenti pubblici adeguati sta mettendo in ginocchio i centri antiviolenza e le case rifugio, l’80% è erogato dalle regioni, ma con piani che variano a seconda del territorio e mai continuativi, manca anche una raccolta dati poi su come vengono utilizzati. La rete D.i.Re assiste 23mila donne ogni anno. Il report annuale 2024 racconta di una realtà che si poggia esclusivamente sul lavoro delle volontarie, altamente specializzate, 3.739 attiviste in totale. Senza un sostegno stabile, molti di questi servizi rischiano di chiudere, soprattutto nelle zone di depressione in cui difficilmente trovano altri modi per finanziarsi. È quello che sta accadendo nel sud Italia dove diverse case rifugio non esistono più, lì dove la disoccupazione femminile è altissima.
Ad oggi non esiste un piano che passi dai centri antiviolenza per aiutare le donne a inserirsi nel mondo del lavoro e trovare una propria indipendenza economica, indispensabile per attuare il distacco dalla violenza. «Su questo il reddito di solidarietà può essere un aiuto, un palliativo, in un sistema di welfare debole e sottofinanziato», sottolinea Carelli. Fondamentale sarà il prossimo Piano nazionale antiviolenza, per ora i centri hanno avuto una prima bozza, identica al piano precedente. Denunciano di non essere stati interpellati nella stesura, se non per quattro incontri “passivi” in cui non si sono potute fare proposte.
da il manifesto
Un altro decreto spot approvato con il giubilo della destra e, per una volta, anche dal centrosinistra, seppure con toni diversi. Il Senato ieri ha votato all’unanimità il dl Femminicidio (che prevede l’ergastolo per chi uccide una donna), adesso il testo dovrà passare all’altro ramo del parlamento per l’approvazione definitiva.
Ma tanto basta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per dichiarare «particolare soddisfazione» per il via libera: «L’Italia è tra le prime nazioni a percorrere questa strada, siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile». Anche se a ben guardare non si tratta di un vero primato: diversi paesi del Sudamerica hanno una legislazione simile da tempo ma non ci sono stati effetti sulla deterrenza. Segue a ruota nell’esultanza Ignazio La Russa che parla di «risultato di grande valore che dimostra come su temi fondamentali le istituzioni sappiano andare oltre l’appartenenza politica».
Il testo approvato ieri è effettivamente il prodotto di una mediazione tra i gruppi in commissione. La bozza circolata a marzo, sulla scorta di presunte emergenze introdotte dalla cronaca, era stata ritenuta da diversi giuristi molto fumosa e problematica ed è stata quindi modificata nella parte iniziale, resa più stringente nell’indicare la fattispecie di reato. È stato quindi introdotto un passaggio sul rifiuto da parte della donna (o chi si sente tale) a «stabilire o mantenere una relazione affettiva» o a voler «subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali». L’articolo 577 bis da introdurre nel Codice penale, così come da formulazione, punisce con la massima pena chiunque provochi la morte di una donna, attraverso «atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna».
Previste anche aggravanti per i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo stalking e uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli orfani di femminicidio. «Auspico che ci sia una corretta e rigorosa applicazione delle nuove misure», ha commentato la leghista Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia, probabilmente per mestiere (è avvocata anche in casi di stupro) più consapevole dei colleghi del reale portato della legge, al di là dei proclami del governo.
A maggio scorso ben ottanta giuriste italiane avevano consegnato un appello al governo che smontava l’impostazione del dl, anche perché il codice penale in uso prevede già aggravanti per i delitti di genere, come dimostrano anche i casi di Filippo Turetta e Alessandro Impagniatiello, entrambi condannati all’ergastolo per l’assassinio di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano. «È un femminismo punitivo – aveva spiegato allora al manifesto Valeria Torre, docente di diritto penale all’Università di Foggia – non si può pensare che il diritto penale contrasti una cultura che è legittimata in quasi tutte le relazioni uomo-donna in una società basata sulla disuguaglianza di genere».
Anche l’Associazione nazionale magistrati aveva sottolineato le difficoltà insite nell’ «indeterminatezza del reato», mentre i centri antiviolenza manifestano preoccupazione sulle possibili conseguenze, per le vittime, di una cattiva interpretazione della legge da parte di operatori della giustizia non adeguatamente formati. «Non ci aspettiamo un calo dei femminicidi, perché – avevano dichiarato dalla rete Dire – non è con pene più severe che si afferma il diritto delle donne di vivere libera dalla violenza, cambiare rotta significa riconoscere investimenti economici adeguati a cambiare la cultura di un paese».
Il voto favorevole dell’opposizione non è esente da critiche: Pd, Avs e M5s hanno denunciato l’assenza di investimenti sulla prevenzione e la diffidenza del governo verso forme di educazione affettiva e sessuale. «Il confronto vero ha dato dei risultati – ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein, che qualche mese fa aveva lanciato un appello a Meloni per collaborare su questo aspetto – ora però bisogna rilanciare, perché l’introduzione del reato non sarà sufficiente ad affrontare il fenomeno, la repressione non basta, serve la prevenzione»
da RivistaStudio
A Milano è arrivata la tempesta. La città che non si ferma, tutto d’un colpo, si è fermata. Questa grande macchina – bella e sghemba, veloce e sfinita, un po’ diva e un po’ fabbrica – dopo anni in corsa a velocità siderale, ha oggi un’occasione rara: quella di rallentare, stare in silenzio e interrogarsi su ciò che è stato, cosa non ha funzionato. Invece di rimuovere, rilanciando. Partendo dall’errore per ricostruirsi, finalmente, a misura di chiunque la abiti. A misura di diversità.
Negli ultimi mesi la città è stata attraversata da una scossa silenziosa e profonda. Le inchieste giudiziarie – che toccano alcuni dei luoghi e dei poteri simbolici della trasformazione urbana e sociale degli ultimi anni – hanno trasformato in cratere la crepa che da anni, un po’ alla volta, si allargava nel racconto di città vincente. Senza entrare nel merito delle vicende, per le quali è doveroso attendere gli esiti dei procedimenti giudiziari con pieno esercizio di garantismo, resta però netta la sensazione di una discontinuità definitiva rispetto a un passato recente che sembrava trionfale. Sono questi i momenti migliori per ripartire dalle domande fondamentali: su quali dinamiche si è fondata Milano negli ultimi vent’anni? Cosa succede quando la retorica dell’efficienza, della crescita costante e dell’attrattività si scontra con le fragilità strutturali, con quelle umane e con le zone d’ombra mai del tutto chiarite? Più che un’accusa, però, serve oggi un cambio di sguardo e al di là di “chi ha fatto cosa”, oggi serve chiedersi: questa città cosa sta diventando?
I numeri della crisi
È Federico Fubini ad evidenziare, sulle pagine del Corriere della Sera, come a Milano si concentri il 40 percento delle vendite di immobili sopra il milione di euro. Tra il 2021 e il 2024, nelle zone più pregiate, i prezzi sono cresciuti fino al +57 percento, toccando i 27.000 €/mq (e 39.000 nel Quadrilatero). Questo boom è alimentato anche dal regime fiscale per i “neo-residenti”: una flat tax da 100 mila euro (oggi 200 mila) per chi ha redditi all’estero, introdotta a fine 2016 dai governi di centrosinistra guidati da Renzi e Gentiloni. Dal 2018 al 2023, la città ha attratto almeno 4.500 super-ricchi, due terzi dei quali si sono stabiliti a Milano, spesso comprando casa. Questo meccanismo ha avuto un impatto sul mercato del lusso e sui prezzi medi, saliti del 13 percento dal 2015. Intanto, 128mila rientrati con sgravi fiscali (esenzione del 70-50 percento sull’imponibile) investono nel mattone. Il risultato: un mercato drogato nel quale i super-ricchi che risparmiano sulle tasse comprano casa, mentre il ceto medio paga sempre di più – e spesso viene escluso.
Negli ultimi cinque anni, infatti, i canoni d’affitto sono esplosi: +22 percento tra il 2019 e il 2024, con punte del +38 percento in quartieri periferici. Il canone medio richiesto per una casa di 70 m² ha toccato quota 1.625 €/mese – contro i 1.330 € di cinque anni fa. E il prezzo medio al mq ha raggiunto i 5.532 €/m² nel giugno 2025, segnando un +1,4 percento annuo. Secondo la Caritas Ambrosiana, nel 2023 le richieste di aiuto sono aumentate del +25 percento e la povertà cresce anche tra chi lavora, evidenziando una diffusione del fenomeno dei “working poor”. Insegnanti, cameriere e camerieri, lavoratori a partita Iva negli studi professionali, tranvieri. I loro stipendi, invariati da tempo, si aggirano in media intorno ai 1.300 euro al mese.
Nel frattempo, la demografia di Milano dà segnali contraddittori. Perché, se è vero che dopo l’emorragia degli anni del Covid, in cui la città aveva perso circa 50mila residenti in un biennio, altrettanto vero è che negli ultimi anni la curva dei residenti ha ricominciato a salire stabilizzandosi attorno al milione e quattrocentomila. Tuttavia, sempre nell’ultimo biennio, il saldo tra i nuovi iscritti all’anagrafe e quanti lasciano la città sembra nuovamente negativo, a segnalare, una nuova onda di allontanamento da monitorare.
Quel che sembra evidente, guardando i costi della vita dopo le ondate di inflazione degli ultimi anni, è che la città espelle i più deboli, mentre cresce la propensione degli investitori (anche privati) a trasformare gli immobili in fonte di reddito; secondo Crif/Nomisma, il 63 percento dei locatori li percepisce come investimento, in molti casi a spese di chi cerca una casa per viverci. Del resto, a partire da Expo alle Olimpiadi in arrivo, tutto ha creato una narrazione di successo. E non si può negare che la città sia diventata anche molto più bella.
Ma, allo stesso tempo, si è alimentata quella dinamica performativa che produce valore per pochi rischiando di soddisfare interessi più privati che pubblici. Milano però non è solo vittima di una “crisi urbana”, soffre anche di un problema di rappresentanza. L’elettorato del centro storico – con redditi più alti e capitali culturali – vota molto di più della media cittadina: i dati sulle elezioni comunali 2021 parlano chiaro: solo il 47,7 percento di affluenza, ma con punte ben superiori nei municipi centrali. Di contro, le periferie mostrano un distacco crescente: bassissima affluenza e minore interesse. L’apatia diventa evidente: chi sta fuori dal centro percepisce la politica come distante, estranea. Risultato: le politiche urbane emergono sempre più orientate a soddisfare un elettorato centrale, benestante, mentre le periferie restano marginali. In una città vulnerabile, questa è una frattura politica grave quanto quella sociale o immobiliare. Perché il rischio è che il futuro della città lo decidano sempre e solo i salotti.
Ed è altrettanto vero che, in questi anni, il cuore pensante e amministrativo di Milano si sia progressivamente sottratto dal compito più difficile ma necessario: restituire alla città un racconto comprensibile dei processi in atto. A mancare, di fatto, è stata l’occasione di creare nella trasformazione della città un grande progetto collettivo e democratico. Ma se si vuole ripartire, è da lì che si può ricominciare.
Il Laboratorio dell’Errore
Milano, come tutte le città interessate da fenomeni globalizzanti e capitalistici, ha la tendenza a considerare i fallimenti come rimossi. Ma non si dovrebbe temere di mostrare la propria fragilità. Forse è arrivato il tempo di dotarsi di uno spazio dove interrogarsi sui propri cortocircuiti. Un vero e proprio “Laboratorio dell’Errore” dove non si nasconda quel che è andato storto ma pubblicamente lo si guardi, lo si compari caso per caso e lo si analizzi con visione, coraggio e concretezza. Senza retoriche. A servire è uno spazio libero, permanente, di confronto, capace di autocritica. Pronto ad aggregare i dati prodotti dalle ricerche delle università italiane, dei centri culturali e degli istituti di ricerca. Mettendoli a confronto. Per incentivare un processo condiviso tra amministratori, costruttori, realtà cooperative, politici, intellettuali, studenti, attivisti, portinai, scuole, lavoratori, lavoratrici, psicologi, adolescenti delle periferie, abitanti di diversa età e provenienza culturale sociale e geografica. Generando a ricaduta progetti concreti.
Uno spazio di sano conflitto, che superi i processi partecipativi calati dall’alto, dove le diversità siano risorsa per affiancare, ognuno nel proprio campo, questa amministrazione comunale, che ha deciso comunque di restare. Per provare ad andare oltre la lamentela e l’accusa talvolta mescolate all’atticismo militante.
Tante sarebbero le cose da suggerire, dalla costituzione di una commissione esterna e indipendente, capace di rimettere mano ai gangli inceppati della macchina urbanistica, sbloccando ciò che oggi rallenta la città – dai cantieri fermi alle case di chi ha investito i suoi risparmi – e restituendo metodo e visione a un sistema che rischia di implodere. Servirebbe pensare a politiche abitative strutturali, che non aggirino solo l’inflazione dei prezzi, ma reinvestano nel sociale abitativo. Sarebbe necessario un confronto con il sistema finanziario per capire come restituire valore, in progetti sociali, da quanto estratto in termini di profitto e di costruzione della città. Servirebbe interrogarsi su come arginare lo storytelling urbano che, come nel caso di Piazzale Loreto – annunciato, poi congelato – ha contribuito a gonfiare i costi dell’abitare. Lungo quella via Padova ancora popolare, delle ultime famiglie migranti e locali rimaste. Servirebbero politiche sperimentali, sugli affitti, capaci di dare maggiori incentivi nel lungo periodo ai proprietari di casa, ma con chiare regole sull’uso dell’immobile come investimento.
Avremmo bisogno di attivare laboratori civici territoriali per valorizzare le fragilità: zone multi-etniche, generazioni che rischiano l’esclusione, la povertà. Dovremmo interrogarci su come Milano possa tornare ad essere una città per chi ha meno, garantendo accesso a sport e cultura. Oggi, se sei povero, anche una piscina può essere inaccessibile. Servirebbe valorizzare quelle realtà periferiche, spesso strumentalizzate dal mercato immobiliare, che resistono, tra le poche a saper davvero ascoltare chi resta. E lo si dovrebbe fare mettendo finalmente in discussione le modalità così complicate con cui si è soliti finanziarle.
Servirebbe riconoscere la sofferenza dell’adolescenza di questa città, con progetti di ascolto, desiderio e formazione popolare che partano anche da chi abita la strada, per contrastare povertà educativa e malessere psicologico.
Salva Milano
Infine, Milano potrebbe essere sì un modello, ma se capace di attivare uno scambio continuo e di confronto sull’errore, con le altre città italiane che vivono le stesse complessità. Il richiamo all’assenza della politica nazionale può diventare così più forte, collettivo, costringendo a soluzioni che non siano un “Salva Milano” qualsiasi.
Ma questo è possibile solo se ognuno di si prende le proprie responsabilità, senza scaricarle sugli altri. Abitare, in fondo, non significa solo avere un tetto sopra la testa, o avere potere, ma significa anche sentirsi parte di un luogo, essere riconosciuti e contribuire attivamente a una comunità inventando, se si può, spazi giusti per chi dovrà venire dopo di noi.
E per farlo dovremmo tutti mettere in discussione la nostra professione e la nostra professionalità, riconoscendo i nostri privilegi, i centri di potere, l’amichettismo. Chiedendoci perché facciamo quello che facciamo. Chiedendoci se quello che pensiamo giusto per noi, lo sia anche per chi non ha diritto di parola. Chiedendoci se non sia il caso di iniziare ad ascoltare quelle voci e, facendo un passo indietro, portarle ai tavoli che contano. Non pensando solo di rappresentarle per metterci a posto la coscienza.
Una città forte è quella che non teme la complessità. E oggi Milano ha l’occasione di inaugurare una nuova fase: meno fondata sulla mitologia del fare e più attenta ai conflitti e ai reali bisogni. In fondo, ogni crisi è anche un momento di verità. E Milano, che di crisi e rinascite ha fatto la propria storia, potrebbe ancora una volta sorprenderci.
da la Repubblica
Nella selezione dei film che rappresentano il nostro paese alla Biennale Cinema ci sono otto opere, tutte di autori. Gli artisti stranieri, probabilmente, si vergogneranno per noi
Non mi lamenterò mai più degli eccessi della cultura woke. Non qui, non in Italia, non dopo aver letto la selezione dei film che rappresenteranno il nostro paese quest’anno alla Biennale Cinema: apertura, quattro film in concorso, tre serie tv. Otto opere del nostro italico ingegno, otto maschi. En plein. Cosa penseranno gli artisti stranieri che arriveranno a Venezia? Rideranno, probabilmente, si vergogneranno per noi. Ci tratteranno come i trogloditi che siamo.
In nessun altro paese al mondo qualcuno oserebbe proporre una selezione simile. Non per correttezza politica, ma per razionalità. Ma voi in Italia non ce le avete le donne? Le avete ammazzate tutte? Sono tutte senza talento? Sarebbe bello se qualcuno di questi artisti, in conferenza stampa, ne chiedesse conto.
Ma la colpa non è solo di chi ha scelto. La colpa è delle donne, che non fanno mai niente di buono. Niente all’altezza. L’arte non ha sesso e l’unico criterio è la qualità, diranno infatti per giustificarsi i selezionatori. Come dar loro torto? Specie al cinema, dove, come stiamo vedendo, è proprio la qualità il criterio con cui si produce e si sceglie. Sono due anni che praticamente non si fanno film in attesa di trovare un regista di specchiata fede meloniana, una sceneggiatura sulle foibe o la beffa di Buccari, un cast di attori mai passati in una trasmissione di Fabio Fazio.
Non mi lamenterò mai più degli eccessi della cultura woke perché in Italia la cultura woke non è mai arrivata, e sono bastati due anni perché l’indecente fosse tranquillamente possibile. Buona fortuna ai film selezionati, tutti e otto. Sono sicura che sono stati scelti col criterio della qualità. Ma anche la qualità, come i grattacieli di Milano, subisce i condizionamenti della politica. E la politica quest’anno ha deciso che le donne in Italia non esistono.
da Brescia Oggi
L’inaugurazione è stata fissata per il 25 luglio. Realizzata da Clelia Mori, sarà allestita negli spazi di Casa Trainini a Brescia
Arriva anche a Brescia la mostra “Genoeffa Cocconi Cervi, l’ottava vittima. Una Maria laica” dell’artista Clelia Mori, dedicata alla memoria di una donna che è stata madre dei sette fratelli Cervi, morta di dolore il 14 novembre 1944, poco meno di un anno dopo la tragica fine dei figli, fucilati dai fascisti tutti nello stesso attimo.
L’esposizione
La mostra sarà inaugurata il 25 luglio alle 12 a Casa Trainini (via Rampinelli 12 a Mompiano), su iniziativa di Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), Aned (Associazione Nazionale Ex-Deportati), Teatro Dioniso, Associazione Vittorio Trainini con interventi dell’autrice, di Lucio Pedroni, presidente di Anpi provinciale e Vanna Chiarabini. Il 25 luglio non è una data a caso: si commemora infatti la storica “Pastasciutta antifascista” organizzata dai fratelli Cervi a Gattatico nel 1943, in occasione della caduta del fascismo e dell’arresto di Mussolini. Dopo l’inaugurazione, alle 13.30, dunque pastasciuttata al ristorante “da Ciro”, vicino a casa Trainini a Mompiano: costo 10 euro e prenotazione chiamando i numeri 339/2433616 o 349/1354911.
«L’Anpi di Brescia è la prima istituzione politica in Italia che offre un prezioso dibattito pubblico sulla figura di Genoeffa Cocconi Cervi a ottant’anni dalla sua morte – commenta Mori – Esistono solo due opere artistiche interamente dedicate a lei e l’Anpi le presenta entrambe insieme nel giorno della pastasciutta dei Cervi. Questo vuol dire aprire una riflessione nuova e importante su una donna misconosciuta e su due diverse interpretazioni di lei come donna della Resistenza».
L’artista si riferisce alla sua mostra e al film di Marco Mazzieri dal titolo “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi” che sarà proposto il 25 luglio alle 18.30 al cinema Nuovo Eden alla presenza del regista.
«I due titoli raccontano già un’interpretazione differente di Genoeffa, e metterli a confronto nella stessa giornata è certamente una raffinata operazione culturale con l’intento di stimolare la riflessione politica attuale su Genoeffa, nella seconda guerra mondiale e in tempi di guerra come questi – continua Mori – Oggi Genoeffa potrebbe dire, con la sua cultura, che la guerra la vogliono gli uomini e non cade dal cielo come volere divino e che è ora che gli uomini si chiedano se sono capaci di fare altro per proteggere la vita, oltre che usarla nel peggiore dei modi, per il potere». Mori illustrerà la sua scelta artistica e il lavoro che ormai da anni porta avanti intorno a questa straordinaria figura della storia della Resistenza e del paese. Le opere esposte sono disegni su carta di grandi dimensioni, che hanno come soggetto protagonista, ripreso con stili e tecniche differenti a partire dal “non finito”, sempre Genoeffa Cocconi.
da il manifesto
Voltate le spalle alle seduzioni della lirica, Ingeborg Bachmann passa a inseguire la verità della prosa: lo documentano i testi fra il 1952 e il 1970, ora raccolti in “A occhi aperti”, da Adelphi
Nonostante la sua fama iniziale fosse legata alla poesia – dal debutto sul Mar Baltico nel 1952 fino al premio del Gruppo 47 l’anno successivo, convalidato di lì a poco dalla raccolta Il tempo dilazionato e replicato nel 1956 da Invocazione all’Orsa Maggiore – Ingeborg Bachmann già lungo gli anni Cinquanta era diventata sempre più diffidente verso le seduzioni della lirica. La svolta con la quale si dedicò alla prosa ricorda per certi versi l’evoluzione di Hofmannsthal dopo lo stallo di inizio secolo, suggellato nella Lettera a Lord Chandos.
Bachmann era mossa dalla sfiducia verso il presente, in deficit di strumenti conoscitivi. Fin da subito, in realtà, ovvero mentre si consumava sia la precoce conclusione dei suoi studi che l’esordio letterario, il suo saggismo aveva cadenzato la scrittura poetica e narrativa, traversandole come un filo continuo in un vero e proprio discorso parallelo, che accompagnava il passaggio dalla lirica alla prosa, in un orizzonte di mutuo riconoscimento.
Rende ora conto di questa tensione una raccolta di saggi, discorsi e scritti vari, composti tra il 1952 e il 1970 – Ingeborg Bachmann, A occhi aperti (a cura, con una nota ai testi e una compatta postfazione di Barbara Agnese, Adelphi pp. 275, e 16,00). Il volume, che si appoggia in gran parte all’edizione tedesca dei primi anni Ottanta pur ordinando i saggi secondo un criterio differente, distingue i testi pubblicati in vita da quelli apparsi postumi e dunque perlopiù incompiuti, appena sgrossati o frammentari, con gradazioni diverse dall’appunto allo schizzo alla bozza più ampia.
Logocentrismo insensato
La linea che percorre queste prese di parola, mettendo a nudo un unico angolo visuale, è la ricerca senza scorciatoie di una verità difficile da individuare «nella prigione buia del mondo» – come è detto nel famoso discorso L’uomo può affrontare la verità, pronunciato a Bonn nel 1959 – ma tanto più necessaria in un’epoca come il Novecento di cui Bachmann mostra a dito l’uso distorto del linguaggio.
La falsità battente nella comunicazione quotidiana, nel giornalismo e nella politica avvilisce la lingua a cliché, svuota i discorsi di ogni autenticità, degrada la parola a «chiacchiera», termine heideggeriano che corre attraverso le sue poesie e le sue prose. Al contrario, il saggio è luogo dell’utopia, terreno dove etica ed estetica si annodano indissolubili, cassa di risonanza di una scrittura in cerca di frasi vere, insieme anticorpo e antidoto per raccontare una società votata senza residuo alla violenza, che riproduce nel piccolo, forse meno roboanti ma identici nell’esito, i crimini del passato recente: dallo sprofondamento nel dodicennio bruno ai quotidiani, puntiformi, atti di fascismo.
La riflessione sul nesso tra etica e linguaggio precipita per la prima volta intorno alla lettura del Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein, coeva e coestensiva alla stesura della tesi di laurea su Heidegger, che ne fa saltare le basi ontologiche e costituisce, per la scrittura di Bachmann, insieme il punto di crisi e l’innesco, il passo decisivo che la conduce, attraverso l’analisi critica del linguaggio che ne innerva le pagine, a un confronto serrato con l’insensatezza del logocentrismo, con il cono d’ombra dell’indicibile, con la tenebra fertile del silenzio dove si collauda l’aggancio tra impegno etico, utopia e speranza.
Risale infatti agli anni Cinquanta, nei dintorni della prima raccolta poetica, la stesura dell’ampio testo Ludwig Wittgenstein. Un recente capitolo della filosofia contemporanea condotto ancora nei modi del saggio accademico, con cui Ingeborg Bachmann contribuisce,
nel dopoguerra, alla riscoperta del filosofo, fino a quel momento negletto ovunque tranne che in Inghilterra. Ma lo stesso scatto, insieme morale e conoscitivo, sta anche in altri scritti, meno legati all’incedere trattatistico e più pregni di letterarietà. E la stessa tensione in avanti connota il suo saggismo come forma aperta, per certi versi sperimentale, con un’inquadratura possibilista, un’ottica volutamente ravvicinata e parziale che contesta le serrate ideologiche, gli irrigidimenti totemici e totalizzanti (ma anche giocoforza totalitari), il definitivo cristallizzarsi di una verità a dogma indeformabile.
«Grazia di suono e fiato»
La critica di Bachmann alla metafisica, l’idea di una scrittura «affilata di conoscenza e amara di nostalgia» – espressa anche nelle famose quattro lezioni tenute all’Università di Francoforte nel semestre tra il 1959 e il 1960, autentico vademecum della sua poetologia passa anche in questa spigolatura saggistica attraverso il riscatto del dolore creaturale che spalanca gli occhi e diventa fecondo nella tensione «verso l’assoluto, l’impossibile, l’irraggiungibile». Verso una parola che è garanzia di verità, «grazia di suono e di fiato».
L’afflato conoscitivo che Bachmann ascrive alla letteratura – memore in questo senso della lezione di Musil, che sente compagno di strada insieme a Kafka, Hofmannsthal, Beckett e Faulkner – si ritrova intatto, solo variato e modulato secondo la prospettiva, sia che Bachmann scriva, ancora molto giovane, Infanzia a Cordova – memoir biografico dell’ebreo tedesco, di origine sefardita, Hans Sochaczewer, alias José Orabuena – sia che avvicini la lente al realismo nudo dei primi racconti di Heinrich Böll, quasi goffo a paragone delle arditezze intellettualistiche dei suoi contemporanei, ma proprio perciò – per lei – tanto più degno.
E si avverte anche, la tensione conoscitiva di Bachmann, quando tratta l’approdo alla mistica, o quando parla del rapporto intimo e sorgivo tra musica e scrittura, confermato extra textum dalla sua speciale amicizia – consolidata su suolo italiano, con il compositore Hans Werner Henze – o quando si volge al suo personale firmamento letterario, fermandosi sulle pagine di Kafka, Sylvia Plath, Thomas Bernhard, oltre che di Musil o ancora quando rende omaggio a Maria Callas, le cui colorature sovrumane fanno tutt’uno con la sua umanissima fragilità.
Sul Tevere trascurato
Famose le pagine scritte per la rivista “Akzente”, in cui Bachmann descrive una Roma eterea e concretissima, divisa tra sottosuolo e sole, distante anni luce dalle cartoline illustrate e intrisa di saggezza popolare e sciatteria, «dove il Tevere non è bello, ma trascurato nelle banchine cui nessuno mette mano». Nella struttura a refrain di questo scritto, che potrebbe facilmente indulgere a lirismi atmosferici o a bozzettismi da travelogue, Ingeborg Bachmann saggia la dolorosa, forse impossibile, coincidenza tra verità, vita e scrittura; o meglio, la sua continua, necessaria approssimazione. Poche righe prima, infatti, aveva asserito con movenza «io esisto soltanto quando scrivo, quando non scrivo non sono niente».
da il manifesto
Fioccano le nuove edizioni (e traduzioni) della grande Colette, i cui diritti editoriali hanno di recente raggiunto la soglia di libertà: settant’anni dalla morte dell’autrice
Pubblicato nel 1933, quando Colette era ormai nella pienezza dei suoi mezzi espressivi, La Gatta (Adelphi, pp. 134, euro 13,00) oltre a essere uno dei suoi romanzi più ammalianti è un gioiello di concisione e perfezione classica, come scrisse Edmond Jaloux, che lo salutò alla sua uscita come un capolavoro assoluto: è la storia di un ménage à trois minato dalla gelosia di una moglie che lotta per conquistare il pieno possesso di un marito irrimediabilmente fissato su un amore precedente. Sarebbe una storia banale, se non fosse che l’altra, la rivale per la quale la moglie è disposta ad arrivare fino al delitto passionale, è una gatta.
Con straordinaria finezza, Colette scava nella psicologia di questo triangolo insolito: la moglie è una vera garçonne, la ragazza emancipata degli anni Trenta del secolo scorso, e non a caso si chiama Camille, che in francese è un nome applicabile a entrambi i generi.
Lui è Alain, alienus, estraneo al mondo moderno, un giovane che il matrimonio ha scacciato dal giardino della casa natale, dove ha vissuto una magica adolescenza in comunione con Saha, la sua gatta certosina. Enigmatica sovrana di questa natura edenica, Saha è protagonista a pieno titolo del triangolo amoroso, rappresentando uno stato di purezza anteriore ad ogni linguaggio umano, che la penna di Colette sa tradurre attraverso una sapiente, quasi magica, capacità di evocare luci, suoni, colori e forme del giardino dell’infanzia.
I luoghi del racconto ribadiscono l’opposizione tra le due figure femminili: al giardino di Saha, umido rifugio accogliente come il grembo materno, si contrappone la Fetta di Torta, l’edificio triangolare amato da Camille, che esprime una fredda modernità, tutta spigoli e vetri scintillanti. È evidente lo spessore psicoanalitico di un testo che si avvale della gatta per mettere in scena la tensione regressiva verso una figura materna. Colette si compiacque molto della critica, che aveva avvicinato La Gatta ad alcune sue opere precedenti, come La nascita del giorno (1928) in cui evocava direttamente la propria madre, l’amatissima Sido (1929), confermando implicitamente come la simbiosi con il mondo vegetale e animale fosse profondamente radicata nella sua autobiografia.
Tema portante del suo immaginario, la comunione con la natura deve passare attraverso il linguaggio: alla maestria con cui la scrittrice sa ricreare il mondo delle piante, indicate con una precisione terminologica che ne sottolinea le suggestioni, si unisce una riflessione semiotica inclusiva del linguaggio animale. Le parole pronunciate nei dialoghi fra gli umani contano meno della prossemica che esprime la comunione fra Alain e la sua gattina, e i segni della loro intesa profonda provocano la gelosia distruttiva di Camille.
Nel libro l’autrice fornisce tutto un campionario di comportamenti felini, che Alain sa correttamente decifrare; ma Saha è capace di andare oltre: «l’intero volto felino puntava a un linguaggio universale, a una parola dimenticata dagli uomini». Proprio questa corporeità dell’espressione, tipica della scrittura di Colette, porterà a un tacitiano e folgorante finale.
«Comincio a credere che, insieme, un uomo e una donna possano fare impunemente tutto, tranne parlare»: l’affermazione è tanto più paradossale in quanto contenuta in un romanzo breve il cui titolo èDuo(a cura di Paolo Vettore con introduzione di Mariolina Bongiovanni Bertini, Marsilio, pp. 254, euro 16,00). Pubblicato nel 1934, racconta di una coppia in cui la scoperta del tradimento di lei causa una disarmonia irrimediabile, che nessuna parola potrà riaccordare, e che conduce a un finale stridente.
Inizialmente concepito per il teatro, è un testo di raffinata tessitura linguistica, oltre che psicologica, che sperimenta una ricca gamma di registri lessicali, ben restituiti nella traduzione (ristampa dell’edizione del 1994 nella collana I Fiori Blu, che presenta classici francesi con testo a fronte, corredato da una bibliografia aggiornata).
Nella stessa collana, che consente di apprezzare pienamente le ottime scelte traduttive, viene pubblicato, di Colette, Il tutuniè(a cura di Gabriella Bosco, Marsilio, pp. 168, euro 14,00), seguito ideale di Duo, dove al rapporto di coppia si sostituisce la rappresentazione di un’unione sororale fortissima eppure singolare: «quattro sorelle senza madre» (di cui una è la protagonista di Duo).
Ancora una volta basato su un’efficacia dialogica straordinaria, il libro è in questo caso connotato da una serie di neologismi che plasmano la relazione affettiva delle sorelle. Ne è un esempio lo stesso titolo del libro, in originale Le toutounier, inventato da Colette sulla base del termine toutou, che in francese designa puerilmente un cagnolino, e che serve alla scrittrice per nominare il vecchio divano, dove si accomodano le sorelle nella casa dell’infanzia.
da Il Tascabile
Chiedere un salario per Facebook significa rendere visibile il fatto che le nostre opinioni ed emozioni sono state distorte per una specifica funzione online, per poi esserci riproposte come un modello a cui tutte/i dovremmo conformarci se vogliamo essere accettati in questa società.
Traslando le rivendicazioni emerse negli anni Settanta da Wages for housework (in italiano Salario contro il lavoro domestico), la campagna portava alla luce le condizioni materiali di un mondo in apparenza totalmente astratto, quello della rete. Ma in che senso non siamo semplici utenti, ma siamo ormai soprattutto lavoratotrici/tori sfruttate/i per il profitto delle aziende tech?
Nel suo libro Il lato oscuro dei social network. Come la rete ci controlla e manipola (2025), Serena Mazzini ci spiega questo e altri meccanismi che si celano dietro agli scroll, ai click e ai post che produciamo quotidianamente. In questo suo primo saggio, che ha il pregio di essere estremamente comprensibile e scorrevole, Mazzini, la quale ha lavorato a lungo nell’ambito della comunicazione come strategist, racconta di aver analizzato i dati delle piattaforme quotidianamente, per servirsene per aiutare influencer a creare contenuti «affinché apparissero più sinceri, autentici e credibili». Diviso in capitoli che si soffermano su vari aspetti delle dinamiche social, il libro è la breve storia di come la rete è passata dall’essere un sogno di comunità e collaborazione globale, a diventare uno strumento di controllo, manipolazione e potere, portandoci a vivere e creare un mondo in cui tutto è sintetico e artificiale, mentre si impegna ad apparire autentico; che si tratti di prodotti, mete turistiche, hobby, i nostri rapporti o la nostra stessa identità.
Quando Internet ha cominciato a diffondersi nelle nostre case, quasi nessuna/o si sarebbe aspettata/o che cosa sarebbe diventato. Sebbene le dinamiche che adesso vediamo esplose fossero contenute in nuce in quei primi esperimenti di connessione globale – da subito, per esempio, la creazione di una identità virtuale parallela in cui nascondersi/rifugiarsi caratterizzava l’esperienza dei forum e delle chat – ci sono alcune tappe che hanno segnato in maniera irreversibile il nostro rapporto con il digitale, ma che soprattutto hanno permesso al digitale di instaurare quella che nel libro è definita come una vera e propria “mutazione antropologica”.
Chi si ricorda Indymedia tra gli anni Novanta e i Duemila, non poteva immaginare cosa sarebbe accaduto con l’avvento di Facebook nel 2004, che Mazzini indica giustamente come una delle tappe principali di questa mutazione. Nel 2010, la nascita di Instagram e l’inserimento della fotocamera anteriore nell’iPhone, hanno marcato in maniera definitiva l’impatto del visivo come dominio inscalfibile delle nostre quotidianità. Se all’inizio di Facebook postavamo degli “aggiornamenti” un po’ goffi, in seguito all’avvento di queste novità «lo smartphone divenne un dispositivo per la condivisione immediata di esperienze personali; e i social network, da piattaforme web, divennero applicazioni accessibili sempre e ovunque, capaci di trattenere l’attenzione degli utenti e di integrarsi in maniera capillare nella vita quotidiana». Difficile pensare, nella storia recente, a un cambiamento così drastico ed enorme nei modi in cui percepiamo noi stessi, le altre persone e il mondo circostante, difficile pensare a qualcosa che più di questo ha modificato le nostre abitudini e i nostri modi di vivere le relazioni e gli spazi.
Ma torniamo ai salari: in che senso siamo lavoratore sfruttato? I sensi sono in realtà molteplici. Wages for Facebook affermava che «quando parliamo di Facebook non stiamo parlando di un lavoro come gli altri, ma della manipolazione più pervasiva, della violenza più sottile e mistificata che il capitalismo ha recentemente perpetrato contro di noi». La nostra presenza sui social network, ormai dovremmo saperlo, non è neutra. Qualunque nostra attività è registrata e utilizzata come dato, merce preziosissima nell’economia tecno-capitalista. I nostri like, le nostre interazioni con post, reel, video, gli articoli che leggiamo, le pagine che seguiamo, i prodotti che cerchiamo online, tutto serve ad alimentare quell’enorme tesoro che sono i dataset, che le aziende utilizzano per creare il loro profitto e per alimentarlo, propinandoci, attraverso gli algoritmi, contenuti sempre più mirati e sempre più targettizzati, creando bolle e realtà parallele che contribuiscono a dividere e parcellizzare le popolazioni (e che contribuiscono inoltre allo sviluppo dei software di Intelligenza artificiale). Questa visione non è semplicemente riflesso di un timore legato alla paura del “progresso” o alla demonizzazione degli strumenti digitali, ma è piuttosto, come afferma anche Mazzini, l’osservazione di una realtà fattuale: siamo prodotti, e al contempo lavoriamo gratuitamente.
Uno dei modi in cui l’utilizzo dei social ha completamente plasmato la nostra realtà è esemplificato in maniera estremamente evidente dalla maniera in cui la politica istituzionale se ne è servita per creare bolle di opinione e polarizzare l’opinione pubblica. Mazzini riassume bene il modo in cui Donald Trump se ne è servito per raccogliere un consenso sempre maggiore, coalizzandosi anche con i proprietari delle aziende tech. Stiamo assistendo proprio in questi mesi alle dinamiche (e ai teatrini) fra Trump ed Elon Musk, personaggio sempre più al centro della politica statunitense. Un esempio più circoscritto, ma anche più vicino geograficamente, è la cosiddetta Bestia, il meccanismo propagandistico ideato da Luca Morisi per sostenere Matteo Salvini nell’acquisizione di consenso e voti a partire dal 2017.
Mazzini dedica un lungo capitolo al fenomeno dello sharenting – termine coniato dalla crasi tra share (condividere) e parenting (genitorialità) – nel quale racconta, attraverso numerosi esempi, di come le bambine e i bambini vengano usati da alcune famiglie per produrre alti profitti, talvolta in grado di mantenere l’intera famiglia e permettere una vita agiata. Ma a che prezzo? Come zia di due nipoti molto piccole mi interrogo moltissimo, così come i loro genitori, sul modo in cui le forme sociali influenzano i loro comportamenti, il loro umore, i loro gusti in quanto persone socializzate come donne. Ancor di più, lo faccio in relazione all’influenza che hanno i social network nella creazione di un immaginario sessualizzante e sessualizzato anche per bambine molto piccole. Ma la questione non è individuale. Prima di tutto, il prezzo che le/i bambine/i soggette allo sharenting pagano è quello di non avere un’infanzia libera, soprattutto libera dallo sguardo altrui. Queste bambine e questi bambini vengono ripresi in ogni momento della loro quotidianità (mentre mangiano, giocano, fanno il bagno, si vestono), esposti in momenti di vulnerabilità (quei reel che ci fanno tanto ridere con i bambini che piangono disperati perché sgridati o perché si sono fatti male giocando), utilizzati come fenomeni da baraccone o, peggio ancora, fatti recitare una parte.
Un esempio estremamente inquietante che viene fatto nel libro è quello di Wren Eleanor, una bambina che fin dai tre anni è stata mostrata su un profilo TikTok gestito dalla madre, che la esponeva anche attraverso video ambigui e sessualizzanti, in cui la bambina mangiava cibi di forma fallica o aveva atteggiamenti provocatori. Analizzando l’account era evidente che quei video fossero i contenuti con più visualizzazioni del profilo, e che fossero anche molto spesso pieni di commenti riconducibili a reti di pornografia infantile. Il caso Wren ha fatto emergere un movimento spontaneo, con molte persone che hanno chiesto alla madre di cancellare i video e che hanno cominciato a parlare dei problemi legati a questo tipo di account.
Ma il fenomeno è enorme ed estremamente produttivo e sono numerosi i genitori che non rispettano il consenso delle loro figlie, pensando evidentemente di possederle, al punto da utilizzare la loro infanzia come merce. Il canale Fantastic Adventures, per esempio, era gestito da una madre che sottoponeva i figli a privazioni di cibo e violenze di altro genere per obbligarli a partecipare ai video. Oppure il caso emerso l’anno scorso in cui la figlia dell’influencer Ruby Franke ha testimoniato nel processo in cui la madre è stata accusata per abusi su minori, raccontando l’esperienza di chi cresce come vittima del family vlogging.
Casi come questi, ci dice Mazzini, «ci mostrano come dietro i contenuti apparentemente innocui e divertenti, in cui i bambini sembrano sempre felici, spensierati e amati, possa nascondersi una realtà ben diversa». Pensiamo che sia divertente vedere il video di un bambino che fa qualcosa di buffo, o che sia innocuo l’utilizzare i propri figli per produrre canali YouTube pieni di contenuti di intrattenimento, ma «ignoriamo che quei bambini, che vediamo sorridere per intrattenere i nostri, potrebbero essere costretti a ripetere le stesse scene decine di volte, imparare copioni precisi […] per assecondare i desideri di genitori inebriati dall’algoritmo». Questi fenomeni, che sembrano riguardare solo chi lavora effettivamente con l’immagine della propria famiglia e dei propri figli, sono in realtà estremamente pervasivi della quotidianità di molte persone, e si concretizzano per esempio nel caricamento costante di foto e video che ritraggono bambine e bambini anche molto piccole/i senza oscurare il volto; pratica che, dice anche Mazzini, fino a un certo punto era una prassi delle regole non scritte dei social.
Il capitolo sullo sharenting è seguito da una riflessione molto interessante sul modo in cui i social hanno modificato il nostro rapporto con la morte – argomento affrontato in maniera puntuale anche dal tanatologo Davide Sisto – al punto da permetterci di scrivere dei messaggi che potranno poi essere pubblicati sui nostri profili alla nostra morte. Anche quello che Mazzini chiama “capitalismo della pietà” – che consiste in video di persone che vanno in giro a regalare soldi a chi si dimostra “buono” – ha molto spazio nel libro, così come il “reality show della malattia”, per cui vengono messe in mostra malattie, disabilità, situazioni di disagio sociale e psicologico al fine di guadagnare visualizzazioni (e quindi denaro).
Messa in questi termini, verrebbe voglia di scappare da ogni forma di socialità digitale. Forse, in parte, sarebbe auspicabile, ma la realtà è che per molte di noi utilizzare questi strumenti è ancora utile (per alcune persone necessario) e che, afferma Mazzini, disertare completamente da alcuni spazi sociali online – come è stato fatto nella disiscrizione di massa da Twitter, ora X, dopo l’acquisto della piattaforma da parte di Elon Musk – può portare alla creazione di bolle di violenza e radicalizzazione di destra inscalfibili. Al contempo, boicottare alcune piattaforme e cercare forme di socialità online alternative è più che positivo. I social network si sono succeduti nel tempo e se alcuni hanno avuto la meglio sugli altri è stato per la loro capacità di rispondere ad alcune esigenze, ma queste esigenze possono cambiare.
Alla fine del saggio Mazzini riflette anche su questo e, pur senza fornire esplicitamente delle alternative precise, evidenzia la necessità di smettere di accettare passivamente un sistema che in realtà non ci sta facendo del bene, e di concedere così tanto potere a queste piattaforme sulle nostre vite. Servirebbero, anche, delle azioni di politica istituzionale che invece tardano ad arrivare, per proteggere i dati delle/degli utenti, per limitare la possibilità di utilizzo da parte delle aziende, per informare le persone piccole e giovani riguardo al funzionamento delle tecnologie e dei social network. Serve però soprattutto, a suo avviso, un cambiamento di immaginario e di cultura in cui «piattaforme, brand, agenzie, creator e utenti» lavorino in direzione comune, ma anche e principalmente che la comunicazione abbandoni la sua ossessione per la viralità, cercando modalità che avvicinino utenti e creator, che responsabilizzino le/gli utenti e non li trattino da oggetti passivi.
Mazzini ci invita a chiederci: «Vogliamo davvero accettare di essere parte di un meccanismo che si nutre di noi, trasformando le nostre vite in semplici dati per macchine insaziabili? […] Per anni abbiamo lavorato gratuitamente, in silenzio, trasformando la nostra presenza digitale in una merce da vendere al miglior offerente. […] Riprenderci il controllo significa soprattutto guardare oltre gli schermi, ritrovando valore nelle comunità fisiche che spesso abbiamo trascurato. Questi spazi, fragili ma preziosi, offrono la possibilità di costruire relazioni autentiche, dove l’interazione non è filtrata da algoritmi o metriche di successo».
Il primo passo per uscire dagli schermi forse è ricordarci che tutto quello che vediamo delle vite altrui attraverso i social è una costruzione fatta per mostrarsi migliore, per raccontare un’idea di vita e, molto più di frequente, venderci qualcosa.
da HuffPost
Secondo una inchiesta condotta in 27 paesi europei, riportata dall’Economist, alla domanda «sei d’accordo che i diritti delle donne sono andati troppo oltre e minacciano le opportunità degli uomini» gli uomini della cosiddetta generazione Z (20-30 anni) hanno risposto affermativamente in percentuale significativamente superiore a quella degli uomini delle generazioni precedenti. In Cina nelle chat dei giovani maschi l’espressione “femminista puttana” è diventata frequente. Alla diffusione dei sentimenti antifemministi tra i giovani corrisponde un allontanamento tra i due sessi. La divaricazione non riguarda solo i legami erotici ma pure quelli amicali. Anche sul piano politico si sta verificando una separazione: le donne sono più sensibili dei maschi alle problematiche sociali e più vicine ai valori della democrazia.
Si pensa che il distanziamento tra i sessi che si diffonde tra i giovani sia dovuto all’emancipazione professionale delle donne (e al loro più elevato livello di preparazione), alla loro difficoltà di trovare uomini all’altezza del loro livello culturale e al ripiegamento difensivo degli uomini accompagnato da sentimenti di rancore e di rivalsa. Si è visto che nelle zone in cui aumenta la disoccupazione aumentano tra i giovani maschi l’ostilità contro le femministe e l’adesione alle idee della destra estrema.
In realtà la causa dell’incomprensione e dell’insofferenza reciproca è un’altra. Non è stata l’emancipazione femminile a favorire il progressivo distacco dei sessi tra i giovani. È stata la sistematica dissoluzione dei legami erotici, affettivi, culturali, lavorativi, politici, solidali e conviviali – che un modello di sviluppo economico sregolato e selvaggio (dominato dalla legge del più forte) ha prodotto – a divaricare le prospettive delle donne e degli uomini e a impoverire di emozioni e di pensiero le loro relazioni.
La deregulation totale, l’arbitrio come strumento di governo e lo strapotere dei più forti sui più deboli hanno creato una società performante: l’agire impersonale degli umani che fa di loro degli ingranaggi di una macchina collettiva, li esautora di una vita soggettivamente vissuta e, a lungo andare, minaccia la loro stessa sopravvivenza fisica. Questa società distrugge il tempo libero, la sedimentazione e l’elaborazione delle emozioni e dei pensieri, la conversazione (il dialogo che disloca lo sguardo in entrambi i conversanti senza imporre un punto di vista su un altro) e il senso della comunità (il nostro emozionarsi e comprenderci reciprocamente vivendo la nostra diversità in mezzo a quelle degli altri). Non è più una società patriarcale nel senso tradizionale del termine che reprime la sessualità femminile e restringe la vita delle donne nei limiti imposti dalla sua logica di autoconservazione (a volte più rigidi, a volte più flessibili). È una società di inclinazione totalitaria che si costituisce come antagonista del corpo erotico della donna, dissolvendo tutte le condizioni che consentono la sua libera espressione e realizzazione.
Quando si disattiva la sessualità femminile, perché dovrebbe essere sorprendente il fatto che l’incontro erotico diventi superficiale, nemico della profondità, tutto proteso alla ricerca di effetti eccitanti o calmanti? Se il far sesso si converte in droga o si percepisce come incognita da cui astenersi, perché il legame tra le donne e gli uomini dovrebbe miracolosamente mantenersi vivo e muoversi nel senso della parità e del reciproco rispetto? Gli uomini si aggrappano a una sessualità automatica, ripetitiva che gira a vuoto (aumentando la loro frustrazione e la loro violenza). Le donne sono costrette a rinunciare alla loro interiorità (o a sospenderla) trovando una magra consolazione nell’imitazione dell’efficacia performante maschile (un campo in cui esse possono, attivando la parte maschile di sé, ottenere risultati strabilianti) che le allontana dal loro modo di essere e di sentire e le rende infelici.
L’incomunicabilità erotica tra i due sessi che li porta a competere in un territorio neutro sul piano dei desideri e dei sentimenti (la natura nascosta del patriarcato, il “nuovo che avanza” oggi), aumenta la violenza e il consenso all’autoritarismo. Danneggia gli uomini convertendoli in caricature di sé stessi: che cosa è un essere umano sul piano del desiderio se l’oggetto desiderato è sempre più mortificato sul piano della sua libertà erotica o è percepito come minaccia? Danneggia le donne perché le spinge a tradire la loro intima natura anarchica, libera dalle convenzioni normative, e non dà loro in cambio un potere effettivo (questo resta saldamente in tutto il mondo in mani maschili).
Il capovolgimento silenzioso della prospettiva di una riforma femminile della civiltà (oggetto di resistenza forte radicata nel falso senso di sicurezza che ispirano i sistemi consolidati di potere) in una diluizione della diversità della donna, trova una sua espressione indiretta, ma molto insidiosa, nello spostamento dello sguardo dalla violenza nei confronti delle donne ai conflitti all’interno delle coppie. Si usano le dispute legali sull’affidamento dei minori come prova di una violenza da parte delle donne contro gli uomini. Queste dispute, complesse nella loro configurazione psicologica (che andrebbe valutata con molta cura caso per caso e non lasciata all’inventiva dei legali) sono la manifestazione di un malessere della relazione coniugale, sempre più diffuso e pernicioso, che vede la madre aggrapparsi ai figli e al suo ruolo materno (quando la donna in lei cede allo sconforto) e il padre (poco convinto del suo ruolo reale e in soggezione “filiale” verso la maternità) appellarsi alla sua legittimità formale.
È mistificante confondere l’infelicità coniugale e genitoriale con la violenza della società patriarcale contro le donne che spesso prende la strada della grave violenza fisica, individuale e gruppale, arrivando al femminicidio. Questa violenza avvelena la nostra salute psichica e scardina le nostre relazioni. L’incapacità di trasformare radicalmente in senso non patriarcale la società ci mette nella posizione del “cane che si morde la coda”. Le donne sono sole e non si può confidare all’infinito sulla loro resistenza. Gli uomini si schermano dietro i “difetti” delle loro donne (madri, donne, amanti). Si liberino, se vogliono restare vivi emotivamente e mentalmente (e non vivere come morti viventi), del loro violento vantaggio sociale sull’oggetto amato; si affidino al gioco dell’intesa con il conflitto che, nella buona e nella cattiva sorte, regola il destino dell’amore.
Dal Corriere della Sera
Nei prossimi due decenni, avverrà il maggiore trasferimento intergenerazionale di ricchezza mai registrato. E, da ora alla metà del secolo, saranno le donne a ereditare la maggior parte delle ricchezze in movimento. È un fenomeno che promette di produrre cambiamenti non solo nelle finanze personali di milioni di persone ma anche dal punto di vista sociale. Si tratta del passaggio alle cosiddette generazioni Millenial e Generazione Z di denaro, investimenti, case, opere d’arte, gioielli, vini eccetera accumulati in decenni dai Baby Boomers, dai nati tra il 1946 e il 1964, il vasto gruppo di persone che, in Occidente, ha vissuto anni di boom economico e di conseguente accumulazione. Le stime sulla portata del Grande Trasferimento di Ricchezza variano ma certamente si tratta di ben oltre i centomila miliardi di dollari, probabilmente 120-130 mila nel prossimo venticinquennio. Solo negli Stati Uniti, si calcola che supererà abbondantemente gli 80 mila miliardi. Secondo i calcoli di Kay Hope, analista di Bank of America Global Research, le donne riceveranno il 70% dei 124 mila miliardi che, calcola, passeranno di mano entro il 2048. Precisamente, 54 mila miliardi andranno al partner che è sopravvissuto: il 95% di questi sono donne. Altri 47 mila miliardi saranno ereditati da generazioni femminili più giovani.
Le donne controlleranno grandi patrimoni come mai prima nella storia. Si tratta di un risultato che ha ragioni storiche e sociali: durante il periodo coloniale, quando ricchezze cospicue sono state create nei Paesi europei, leggi, regole e usi tenevano il sesso femminile lontano dall’eredità. Oggi non è più così e il frutto delle ricchezze create durante anni di straordinaria crescita economica postbellica passa in eredità a maschi e femmine su base egualitaria. Le conseguenze possono essere molto rilevanti. Da una parte, sempre più donne saranno alla guida di scelte imprenditoriali e finanziarie di grande portata: già nel 2030, negli Stati Uniti due terzi della ricchezza sarà proprietà femminile, secondo la società di consulenza McKinsey: un protagonismo sociale delle donne molto maggiore di oggi. Certo, l’eredità non è un meccanismo per distribuire diffusamente nella società la ricchezza, a parte i casi di miliardari che costituiscono fondazioni con scopi benefici. Sarà comunque una rivoluzione non da poco.
Da L’Altravoce il Quotidiano
Ci sono nella vita di una donna esperienze indimenticabili di cui, col tempo, si può sentire la necessità di darne conto, scrivendone. È quello che fa Annie Ernaux con L’evento in cui, dopo averci girato attorno per anni, opposto “resistenza” senza smettere di “pensarci”, decide di raccontare il suo aborto clandestino di giovane studentessa universitaria. All’inizio della narrazione non è sicura di voler andare fino in fondo, ma strada facendo diventa determinata ad andare avanti, convinta che si debba scrivere di “qualsiasi cosa vissuta” perché “non ci sono verità inferiori”. Scrive di quella esperienza per non “oscurare la realtà delle donne” e anche se “la clandestinità”, in cui ha vissuto l’aborto, appartiene al passato, a lei non “sembra un motivo valido per lasciarla sepolta”. “E proprio perché nessun divieto pesa più sull’aborto” può “affrontare, in tutta la sua realtà, questo evento indimenticabile”, che per la prima volta la fa sentire in “una catena di donne attraverso cui passavano le generazioni”. Si immerge nel tempo e nel contesto di quella esperienza sconvolgente con la sensazione di “raggiungere la vita passata”, “come se fosse lì”. L’agenda e il diario di quei mesi di fine 1963 inizio 1964 le danno “le prove necessarie alla ricostruzione dei fatti” in una Francia dove, come in Italia, l’aborto era reato, punibile con il carcere, come pure la propaganda anticoncezionale. Sin dall’adolescenza attraverso i romanzi e i pettegolezzi di quartiere, aveva acquisito “vaghe conoscenze sui metodi che venivano utilizzati, il ferro da maglia, il decotto di prezzemolo, le iniezioni di acqua saponata, l’equitazione”. Sapeva però che la soluzione migliore consisteva nel trovare uno di quei medici detti “cucchiai d’oro”, a cui si rivolgevano donne danarose per abortire in sicurezza, e che a quelle come lei, “senza soldi”, “senza le giuste conoscenze”, non restava che cercare “una di quelle donne che venivano chiamate con patetico nome di ‘fabbricanti d’angeli’”. A confortarla c’era “il pensiero che prima” di lei “molte altre avevano fatto ciò che” si “apprestava a fare”. Non pensava che avrebbe potuto morire. Disperata per non sapere a chi rivolgersi, tenta di procurarsi l’aborto da sola con un ferro da maglia. Attraverso la scrittura cerca di rivivere i sentimenti di incredulità, solitudine, ansia, orrore, infelicità, paura, che l’hanno accompagnata in quella esperienza, in cui ha rischiato di morire per emorragia. Trovata la “studentessa sposata che aveva abortito due o tre anni prima, rimettendoci quasi la pelle” e che le presta i soldi per abortire, trova la “signora”, a cui non ha mai smesso di pensare con gratitudine. “È a lei che dovrei dedicare questo libro”.
Il solo a non sembrare interessato era colui di cui era incinta, come se la sua sessualità non c’entrasse affatto. L’aveva lasciata a “sbrigarsela da sola”. Pensandoci comprende che avrebbe dovuto dedurne che non provava più nulla per lei, ma ammette che, pur immaginando di essersene accorta, non aveva “la forza di lasciarlo, di aggiungere alla disperata ricerca di un modo per abortire anche il vuoto di una separazione”. Rivive lo “sconcerto” nell’aver sentito dentro di sé di “essere divenuta una delinquente” nell’ ambiente universitario in cui era immersa. Riascolta parole violente e di disprezzo che l’hanno ferita. E poi l’immagine della camera dell’aborto che “conserva il ricordo delle ragazze e delle donne salite fin lì a farsi trafiggere da una sonda” e lei che piange e urla di dolore. Il racconto di “quell’esperienza umana totale” ci dice come l’aborto per una donna non è mai stato e non è un diritto astratto né un’ideologia, ma una necessità, vissuta attraverso il suo corpo le sue sensazioni e pensieri, che con Annie Ernaux diventano scrittura.
da il manifesto
Fare fuoco Tra le montagne del Kurdistan iracheno la cerimonia che cambia la storia del conflitto turco-curdo
SULEIMANIYA. Non le hanno consegnate, non le hanno seppellite. Le armi le hanno bruciate, una ventina di kalashnikov, qualche fucile automatico e i caricatori appesi alla cintura.
È sempre il fuoco l’emblema della rinascita: come due millenni fa Kawa, fabbro tirannicida che liberò i Medi dal re assiro Dehak, risvegliò la primavera in Mesopotamia; e come ogni anno da allora, per l’equinozio di primavera, le fiamme del Newroz incitano alla resistenza contro l’oppressione e celebrano l’arrivo del nuovo anno.
Le 11 del mattino sono passate da poco quando da una feritoia nella montagna appaiono i combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, quindici donne e quindici uomini, guidati da Bese Hozat, co-presidente del Kck, l’Unione delle Comunità del Kurdistan. Apre la fila la combattente che ha costruito l’auto-organizzazione politica e militare delle donne nel partito. Trent’anni di vita dentro il Pkk e da dodici ai suoi vertici insieme allo storico leader Cemil Bayik, sarà proprio Bese Hozat a leggere il comunicato in curdo (Nedim Seven, accanto a lei, lo ripeterà in turco) che annuncia il disarmo, a una manciata di passi dagli agenti del Mit, i servizi turchi, e ai delegati del ministero della difesa di Ankara. È lì, forse, che si coglie quanto incredibile sia quel momento, l’attimo in cui il Pkk distrugge le proprie armi di fronte allo Stato che più di altri ha soffocato il sogno curdo all’autodeterminazione, lo Stato dentro i cui confini il Pkk è nato e si è trasformato, da partito politico a movimento armato.
Ed eccolo, cinque decenni dopo, di fronte all’ennesima trasformazione. Succede un venerdì mattina di luglio, nelle grotte di Jasana, a 50 chilometri da Suleimaniya nel Kurdistan in Iraq. Le montagne di Qandil, quartier generale politico e militare del Pkk, sono a un centinaio di chilometri. Un palco con quattro sedie, due gazebo per proteggere dal sole, un altro che fa da zona ristoro, chai, dolcetti e acqua fresca: ci sono da accogliere 500 persone, i “testimoni” del disarmo.
Ci sonoTulay Hatimogullari e Tuncer Bakirhan, i co-leader del partito curdo-turco di sinistra Dem, negoziatore tra Stato e Pkk; ci sono i rappresentanti del Governo regionale del Kurdistan e del clan che lo monopolizza, i Barzani; c’è il Puk, il partito del clan rivale, i Talabani, quello che comanda qui a Suleimaniya e lo si capisce dai loghi sulle uniformi dei peshmerga che monitorano l’intero percorso dalla valle alla montagna.
Ci sono le madri dei combattenti uccisi o scomparsi e c’è Leyla Zana, dieci anni di galera e il coraggio di aver parlato in curdo dentro il parlamento di Turchia nel 1991, non era mai successo prima. Ci sono le donne ezide di Shengal, sindacati, associazioni per i diritti umani, movimenti femministi, politici europei.
Sono tutti sedutiquando i combattenti scendono le scale di pietra che seguono la forma spigolosa della montagna. Pochi minuti prima una voce al microfono aveva intimato: no slogan allowed, gli slogan non sono permessi. Non obbedisce nessuno: all’apparire delle uniformi, le persone si tirano su in piedi, battono le mani, gridano «Biji Serok Apo», lunga vita al leader Apo. Lui c’è, in un fermo immagine catturato dal video pubblicato pochi giorni fa e proiettato su un pannello nero.
Bese Hozat legge il comunicato firmato “Gruppo per la pace e la società democratica”, e qualcuno ironizza: «Forse è il nuovo nome del Pkk». Lei ha la voce ferma, rimbomba tra i pinnacoli di pietra: «Noi combattenti per la libertà, donne e uomini, ci siamo uniti al Pkk in tempi diversi e da regioni diverse. Oggi qui rispondiamo all’appello del leader del popolo curdo, Abdullah Ocalan. (…) Distruggiamo volontariamente le nostre armi, davanti a voi, come gesto di buona volontà e determinazione».
«Vista la crescente pressione fascista, lo sfruttamento in tutto il globo e il bagno di sangue in corso in Medio Oriente – continua – i nostri popoli hanno più che mai bisogno di una vita pacifica, libera, uguale e democratica. In questo contesto comprendiamo a pieno la grandezza, la correttezza e l’urgenza del passo che stiamo prendendo».
Una a uno, si avvicinano a una vasca di metallo e ci poggiano dentro i kalashnikov. Un funzionario del Puk getta una torcia, le fiamme si fanno strada in mezzo a un denso fumo nero. I presenti applaudono, le madri in prima fila piangono. Piange anche Leyla Zana, qualcuno la abbraccia. Lacrime di dolore, di timore, di sollievo. In quei gesti si specchiano quattro decenni di lotta armata, di sangue e resistenza, di figli e figlie mai più rivisti. Sono i figli e le figlie delle famiglie che si affollano in fondo alla valle, non hanno potuto partecipare alla cerimonia ma stanno là, trepidanti.
Quel rogo parlaalle vite individuali e collettive di milioni di persone. Anche per questo, per dare forza alla cerimonia, era intervenuto il video-messaggio di Ocalan, il 9 luglio, a ribadire che l’unica via possibile è l’abbandono della lotta armata e lo scioglimento del Pkk. Per la prima volta dal 1999 è stata la voce del fondatore a consegnare l’appello al suo popolo. Nella Siria del nord-est, dove la rivoluzione è un divenire quotidiano, è esplosa la festa. In poche ore, dicono, nei negozi di abbigliamento le magliette beige con il logo Lacoste sono andate esaurite. È lo stesso modello indossato da Ocalan in video.
C’è anche però chi osserva la nuova fase con timore: è il Bakur, il Kurdistan in Turchia. «Le persone si fidano di Ocalan, ma non del governo turco. E c’è chi non sarà così felice di assistere alla distruzione delle armi, seppur siano poche. Un atto di buona volontà dettato anche dalle circostanze: non è più tempo per la guerriglia, in un mondo in cui le guerre si combattono in aria, con i droni», ci diceva un’alta funzionaria del partito alla vigilia.
Il futurodel processo di pace sta nei due elementi evocati dalla funzionaria: le misure concrete che prenderà (o non prenderà) Ankara e il modo in cui il disarmo verrà narrato. Il presidente Erdogan vuole la sua photo-opportunity: i kalashnikov che bruciano, nell’interpretazione da vendere alla sua gente, sono la vittoria del nazionalismo turco sul terrorismo separatista, con il Pkk che sventola bandiera bianca di fronte a un avversario tenace e invincibile. Per saperlo basta attendere oggi, quando Erdogan terrà un discorso in merito.
Il Pkk, ci dice un quadro del partito dopo la cerimonia, si aspetta l’annuncio di qualche misura reale, tanto più dopo le parole a caldo di Devlet Bahceli, il leader ultranazionalista dell’Mhp che nell’ottobre scorso ha dato il via al processo di pace invitando Ocalan in parlamento: «La leadership fondatrice del Pkk ha mantenuto la sua promessa e onorato il suo impegno». La posturaassunta da una delle forze più ferocemente anti-curde, ci spiega il quadro, sono frutto di una consapevolezza nuova, emersa dopo il 7 ottobre 2023: «Israele minaccia i tentativi egemonici regionali di Ankara che teme che la carta curda possa essere usata da altri. A ciò va aggiunta la dimensione interna: anni di repressione e lo Stato non riesce a sconfiggerci. A Ocalan si è presentata un’opportunità, dopotutto l’aveva prevista: i turchi verranno da noi, diceva. E sono venuti». Il punto non è il disarmo, tanto più in una regione in cui procurarsi armi non è impresa complessa, ma è il processo politico che ne scaturirà e che dovrà necessariamente passare per la costituzione della commissione parlamentare turca incaricata di risolvere la questione dei prigionieri politici e soprattutto quella delle riforme democratiche.
«Sul fronte dei prigionieri – continua la funzionaria – ci sono stati alcuni rilasci, ma si tratta di casi singoli e sporadici, non di una soluzione radicale. La risposta ufficiosa che abbiamo ricevuto da Ankara è che si dovrebbe cambiare la legge anti-terrorismo, lasciando scoperto lo Stato su un fianco, quello dell’altro grande nemico, il gulenismo». Non è un nostro problema, hanno risposto i curdi, la soluzione c’è ed è un’amnistia mirata.
Per il movimento curdo l’alternativa esiste. Lo ha detto ieri con le fiamme della sua ultima rinascita, un fuoco che non muore mai.
da Leggendaria
I cinquant’anni della Libreria delle donne di Milano vengono festeggiati anche con tre numeri speciali cartacei di Via Dogana, la rivista politica delle donne, nata nel 1991. Il n.1 Speciale, il primo di tre, dal titolo È ora di andare via, è uscito in febbraio 2025.
La lettura di questa rivista è un percorso inaspettato perché inaspettato è il filo conduttore che si percepisce sin dall’inizio. Ora chiaro e manifesto, ora sotteso, si nasconde per poi irrompere: è la libertà femminile. Viene declinata in vari modi, o inclusa implicitamente fra le righe dalle autrici degli articoli, ma sempre cattura la nostra attenzione.
Si presenta chiaramente nel titolo dell’articolo Distorsioni di libertà di Daniela Santoro e ammicca in un altro, Shirin Neshat e la liberazione dello sguardo,di Rosella Prezzo. In quest’ultimo articolo, dedicato all’opera dell’artista iraniana Shirin Neshat, la libertà è sottesa nelle «linee vibranti che ne [dell’immagine femminile] liberano il senso» edè nelle vicende biografiche dell’artista, come suo obiettivo di lotta e di vita, espresso dal grido “Donna, vita e libertà”. Di libertà femminile e di architettura ci parla Francesca Pasini, ma il nesso forte di Arte-Politica è, soprattutto, nell’articolo di Laura Minguzzi, là dove la libertà è indicata dall’autrice come la linfa vitale di questo nesso. Minguzzi dipana la storia della band Pussy Riot, quattro donne russe che dal 2011 lottano contro la guerra per la pace e la libertà. E proprio della libertà viene privata la loro leader Maša Alëchina che racconta in un libro la sua persecuzione. Quindi, non solo questo libro, ma tutte le performances della band ci vengono mostrate da Minguzzi come espressioni artistiche con una forte valenza politica libertaria: perché sono mezzi di lotta politica di donne, mosse dal desiderio di libertà e lanciate alla conquista della libertà stessa, per sé e per l’Altra/Altro. Così «la storia diventa un’altra storia»e nell’attributo “altra” c’è tutta la carica rivoluzionaria della libertà. Rivoluzionaria è anche la parola autorevole delle donne sulla scena pubblica: infatti, cambia il concetto stesso di parola umana, perché ha il suo presupposto nella libertà, come si evince dall’articolo di Giordana Masotto.
Nuccia Nunzella sembra andare alla ricerca della libertà nei libri che utilizza come una bussola per arrivare finalmente a scoprire in uno di questi l’incognito di una libertà da conquistare.
Inoltre, la libertà emerge nelle denunce, rispettivamente di Annarosa Buttarelli e di Daniela Santoro, nei confronti dell’attuale destra governativa e delle sue eclatanti mistificazioni ai danni del femminismo.
Buttarelli, andando al di là del contingente, dichiara: «[…] le cosiddette destre di ieri e di oggi, agiscono con la privazione progressiva delle libertà anche individuali[…] Tutto questo è senza ombra di dubbio distruttivo della libertà femminile».
Daniela Santoro focalizza la libertà femminile per evidenziarne le“distorsioni”nel campodel linguaggio, dal momentoche, come ci ricorda, «la lotta per la libertà femminile continua, infatti, a intrecciarsi profondamente con il linguaggio».
Secondo Santoro avviene attualmente, da parte di Meloni e Roccella, «[…] un vero e proprio scippo del linguaggio del femminismo (e di conseguenza del simbolico), trasformandone il nucleo concettuale […] e usandolo come scudo davanti a politiche repressive. Tutto questo […] depotenzia le parti in gioco nel campo di battaglia per la libertà femminile».
Il presente è anche tragico e la tragedia irrompe con un grido di dolore nell’articolo di Renata Sarfati, Israele Palestina pensare le cose come sono, in cui la pace invocata implica la libertà di scegliere la vita e non la morte.
A proposito della storia, non mi soffermo sulla dialettica passato-presente, che appare in parecchi scritti della rivista, e in cui la libertà ha un ruolo fondante, perché meriterebbe un’analisi a parte.
Si possono concludere queste brevi note con la domanda finale di rito: la via da percorrere quale è? Luisa Muraro sottolinea che non è quella della libertà femminile intesa come parità. Eppure, secondo Mirella Maifreda e Tiziana Nasali, il concetto di libertà femminile come equiparazione agli uomini esiste nella narrazione di stampa e dei social. È vero. Allora, che cosa fare? Possiamo, innanzitutto, rispondere con le parole di Daniela Santoro che, alla fine del suo articolo, scrive che è necessaria la «risemantizzazione della libertà delle donne riportandola al centro del discorso a partire dal caos post-patriarcale riconoscendone la portata trasformativa come nel 2022 ci invitava Dominijanni».
Comunque, ineludibile è la dimensione pratica della lotta, come sostiene Poonam Bruni nel suo articolo, il cui titolo Che fine ha fatto la pratica? è un interrogativo carico di molti significati. Il presupposto, secondo l’autrice, è una liberazione:«a lotta contro il proprio maschilismo interiorizzato nemico subdolo dei nostri giorni».
Il traguardo di questo percorso ideale potrebbe essere la conclusione di Lia Cigarini: l’autrice rivolge lo sguardo all’orizzonte, ad una società in cui la libertà si potrà concretizzare in modo preciso e definito, incarnandosi in «donne libere e uomini liberi».
Perciò, superando la dialettica passato-presente, viene prefigurato, fra storia ed utopia, ovviamente intesa in senso rivoluzionario, il futurofondato sulla libertà.